
Meridionalia
Letteratura, Arte, Teatro
Letteratura, Arte, Teatro
La collana «Meridionalia. Letteratura, Arte, Teatro» si rivolge all’ampio pubblico internazionale degli studiosi di letteratura latina e italiana, declinata in particolare nei suoi rapporti con l’Arte e con le discipline dello spettacolo (Teatro, Cinema). L’intento della collana è stimolare il dibattito letterario sul versante storico-critico attraverso lavori di alto livello scientifico di consolidati esperti accademici e soprattutto di giovani ricercatori in formazione che affrontino, in volumi monografici o in solide edizioni critiche, peculiari aspetti della letteratura italiana e della storia dello spettacolo con approcci metodologici innovativi e nell’ottica del dialogo tra le culture e tra i diversi ambiti disciplinari. I volumi (monografie, miscellanee, edizioni critiche) – anche in lingua straniera, per facilitarne la diffusione internazionale – sono sottoposti ad un sistema di valutazione basato sulla revisione paritaria ed anonima (peer review - double blind).
Ogni lavoro, sottoposto dall’editore all’attenzione dei Direttori di collana e del comitato scientifico, viene consegnato in forma anonima ad almeno due valutatori specialisti della materia e del metodo, il cui parere scritto – con eventuali suggerimenti ed indicazioni correttive – assieme al giudizio favorevole o sfavorevole, è trasmesso al Comitato Scientifico e ai Direttori di collana mediante un’apposita scheda di rilevazione. I criteri che guidano la valutazione sono: originalità e significatività del tema proposto; rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; coerenza teorica e pertinenza dei riferimenti bibliografici; innovatività e pertinenza dell’approccio metodologico; rigore filologico; compiutezza dell’indagine; proprietà di linguaggio e fluidità dello stile; rispetto delle norme redazionali della collana.
Ogni lavoro, sottoposto dall’editore all’attenzione dei Direttori di collana e del comitato scientifico, viene consegnato in forma anonima ad almeno due valutatori specialisti della materia e del metodo, il cui parere scritto – con eventuali suggerimenti ed indicazioni correttive – assieme al giudizio favorevole o sfavorevole, è trasmesso al Comitato Scientifico e ai Direttori di collana mediante un’apposita scheda di rilevazione. I criteri che guidano la valutazione sono: originalità e significatività del tema proposto; rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; coerenza teorica e pertinenza dei riferimenti bibliografici; innovatività e pertinenza dell’approccio metodologico; rigore filologico; compiutezza dell’indagine; proprietà di linguaggio e fluidità dello stile; rispetto delle norme redazionali della collana.
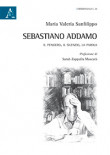
20
Sebastiano Addamo
Il pensiero, il silenzio, la parola
Sebastiano Addamo, autore di nicchia, «scrittore per pochi», per sua stessa ammissione «scrittore di grande insuccesso». Eppure questo autore, che ha spaziato dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al giornalismo, ha pubblicato con prestigiose case editrici e collaborato con riviste internazionali.
Il pensiero, il silenzio, la parola
Sebastiano Addamo, autore di nicchia, «scrittore per pochi», per sua stessa ammissione «scrittore di grande insuccesso». Eppure questo autore, che ha spaziato dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al giornalismo, ha pubblicato con prestigiose case editrici e collaborato con riviste internazionali.

19
«Una vaghissima mescolanza»
Sondaggi sul “patetico” nel teatro comico italiano fra Cinquecento e Seicento
Non esclusiva, nel tardo Cinquecento, della tragedia, l’attenzione alla dimensione emotiva dei personaggi (e dei lettori–spettatori) influenza anche gli intrecci dei testi comici, connotati da una sempre maggiore ricerca di g. Nel contesto italiano, ricco di varietà regionali e locali, l’esibizione del pathos diventa l’elemento unificante del teatro comico, in cui il repertorio passionale dei protagonisti costituisce una vera e propria koinè.
Sondaggi sul “patetico” nel teatro comico italiano fra Cinquecento e Seicento
Non esclusiva, nel tardo Cinquecento, della tragedia, l’attenzione alla dimensione emotiva dei personaggi (e dei lettori–spettatori) influenza anche gli intrecci dei testi comici, connotati da una sempre maggiore ricerca di g. Nel contesto italiano, ricco di varietà regionali e locali, l’esibizione del pathos diventa l’elemento unificante del teatro comico, in cui il repertorio passionale dei protagonisti costituisce una vera e propria koinè.

18
Le Nozze d’Antilesina
Comedia nova e piacevole del Pastor Monopolitano
Una commedia gastronomica dagli insospettabili risvolti politici e sociali. Un invito alla splendidezza dei costumi culinari, un’esortazione alla moderazione; due concezioni etiche opposte che si fronteggiano sul campo della gastronomia. Sullo sfondo della gara tra spilorci e splendidi il cibo è inteso come espressione di potenza e ricchezza sociale, economica, politica ma anche come emblema di un modo di essere e di concepire la vita.
Comedia nova e piacevole del Pastor Monopolitano
Una commedia gastronomica dagli insospettabili risvolti politici e sociali. Un invito alla splendidezza dei costumi culinari, un’esortazione alla moderazione; due concezioni etiche opposte che si fronteggiano sul campo della gastronomia. Sullo sfondo della gara tra spilorci e splendidi il cibo è inteso come espressione di potenza e ricchezza sociale, economica, politica ma anche come emblema di un modo di essere e di concepire la vita.
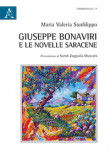
17
Giuseppe Bonaviri e le Novelle saracene
Una messa a fuoco delle Novelle saracene in un quadro di consonanze e diversità sociolinguistiche con altri autori: da Propp a Calvino, da Andersen a Capuana, a Rodari, sino a Walt Disney.
Una messa a fuoco delle Novelle saracene in un quadro di consonanze e diversità sociolinguistiche con altri autori: da Propp a Calvino, da Andersen a Capuana, a Rodari, sino a Walt Disney.

16
1915. In questo anno Futurista
Marinetti, il teatro e la guerra nei manifesti del Quindici
Nel centenario della partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra mondiale (1915–2015), è interessante ripercorre la genesi del Futurismo e le ragioni dell’esacerbato interventismo di Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944). Attraverso una rilettura critica dei Manifesti futuristi del ’15 l’autore sofferma la propria attenzione su due ambiti apparentemente inconciliabili fra loro, quali possono essere il Teatro e la Guerra.
Marinetti, il teatro e la guerra nei manifesti del Quindici
Nel centenario della partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra mondiale (1915–2015), è interessante ripercorre la genesi del Futurismo e le ragioni dell’esacerbato interventismo di Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944). Attraverso una rilettura critica dei Manifesti futuristi del ’15 l’autore sofferma la propria attenzione su due ambiti apparentemente inconciliabili fra loro, quali possono essere il Teatro e la Guerra.

15
L’innocenza del fauno
Da Bembo a Mallarmé
Il lavoro prende spunto da un pretestuoso raccordo intertestuale proposto da Benedetto Croce («Quaderni della Critica», 1950) tra Pietro Bembo e Stephane Mallarmé a proposito de L’après–midi d’un faune, che conserva però vitalità non nel metodo ma nell’intento, poiché suggerisce uno studio sul personaggio di Fauno dal Rinascimento al Simbolismo.
Da Bembo a Mallarmé
Il lavoro prende spunto da un pretestuoso raccordo intertestuale proposto da Benedetto Croce («Quaderni della Critica», 1950) tra Pietro Bembo e Stephane Mallarmé a proposito de L’après–midi d’un faune, che conserva però vitalità non nel metodo ma nell’intento, poiché suggerisce uno studio sul personaggio di Fauno dal Rinascimento al Simbolismo.
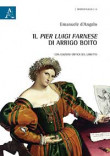
14
Il “Pier Luigi Farnese” di Arrigo Boito
Con edizione critica del libretto
Nel Pier Luigi Farnese, scritto per Costantino Palumbo tra il 1875 e il 1877 ma pubblicato solo nel 1891, Boito plasma genialmente la leggenda romantica e risorgimentale del Rinascimento nero, costruendo attorno alla cruenta congiura di Piacenza del 1547 un dramma ricco di colore storico quanto tenebroso, sontuoso e violento, impregnato di tetre passioni, sfaccettato e inquietante, agitato e machiavellico, una tragedia tutta notturna.
Con edizione critica del libretto
Nel Pier Luigi Farnese, scritto per Costantino Palumbo tra il 1875 e il 1877 ma pubblicato solo nel 1891, Boito plasma genialmente la leggenda romantica e risorgimentale del Rinascimento nero, costruendo attorno alla cruenta congiura di Piacenza del 1547 un dramma ricco di colore storico quanto tenebroso, sontuoso e violento, impregnato di tetre passioni, sfaccettato e inquietante, agitato e machiavellico, una tragedia tutta notturna.

13
Giovanni Leone Africano
La Cosmographia de l'Affrica (1526)
Giovanni Leone Africano (1494-1535?) o semplicemente Leone l'Africano, nome con il quale è conosciuto in Occidente Hassan Al-Wazzan, giunse in Italia nel 1518 prigioniero di una nave di corsari cristiani. Persona colta, grande viaggiatore e ambasciatore del sultano di Fes, entrò nelle grazie del papa Leone X da cui ricevette il battesimo.
La Cosmographia de l'Affrica (1526)
Giovanni Leone Africano (1494-1535?) o semplicemente Leone l'Africano, nome con il quale è conosciuto in Occidente Hassan Al-Wazzan, giunse in Italia nel 1518 prigioniero di una nave di corsari cristiani. Persona colta, grande viaggiatore e ambasciatore del sultano di Fes, entrò nelle grazie del papa Leone X da cui ricevette il battesimo.

12
La «pittoresca conversazione»
Letteratura, teatro e arti figurative a Napoli tra Otto e Novecento
Nella seconda metà dell’Ottocento e nella prima del Novecento il colloquio fittissimo tra letteratura, teatro e arti figurative determinò a Napoli la nascita di una sinergica comunità. Si condensa nella formula emblematica della «pittoresca conversazione» il senso profondo di quel prolifico e pluridisciplinare dialogo che produsse nella città partenopea esiti di indubbio valore.
Letteratura, teatro e arti figurative a Napoli tra Otto e Novecento
Nella seconda metà dell’Ottocento e nella prima del Novecento il colloquio fittissimo tra letteratura, teatro e arti figurative determinò a Napoli la nascita di una sinergica comunità. Si condensa nella formula emblematica della «pittoresca conversazione» il senso profondo di quel prolifico e pluridisciplinare dialogo che produsse nella città partenopea esiti di indubbio valore.

11
Un francescano osservante alle propaggini del Medioevo
Gli exempla di Iacopo Mazza. Tra materiale novellistico e motivi edificanti topici
Iacopo Mazza, francescano osservante vissuto tra la Sicilia e Napoli a cavallo tra Quattro e Cinquecento, è autore di trattati di edificazione. Il volume offre uno studio d’insieme di tali racconti, sì da individuare una supposta biblioteca del frate e rilevare se e in che misura la letteratura esemplare circolava nelle regioni meridionali della penisola alla fine del Medioevo.
Gli exempla di Iacopo Mazza. Tra materiale novellistico e motivi edificanti topici
Iacopo Mazza, francescano osservante vissuto tra la Sicilia e Napoli a cavallo tra Quattro e Cinquecento, è autore di trattati di edificazione. Il volume offre uno studio d’insieme di tali racconti, sì da individuare una supposta biblioteca del frate e rilevare se e in che misura la letteratura esemplare circolava nelle regioni meridionali della penisola alla fine del Medioevo.

9
Storia e Teatro nell’Età Moderna
Drammaturgia e sperimentazione scenica dal Rinascimento al Futurismo
Nato per convenzione nell’Età Moderna, sul bagaglio della Renovatio classicista dell’Umanesimo, il teatro italiano, nel suo fondarsi come tradizione di una cultura cortigiana, secolo dopo secolo ha subito nel tempo il “peso” della storia del nostro Paese.
Drammaturgia e sperimentazione scenica dal Rinascimento al Futurismo
Nato per convenzione nell’Età Moderna, sul bagaglio della Renovatio classicista dell’Umanesimo, il teatro italiano, nel suo fondarsi come tradizione di una cultura cortigiana, secolo dopo secolo ha subito nel tempo il “peso” della storia del nostro Paese.
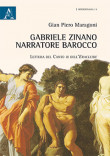
8
Gabriele Zinano narratore barocco
Lettura del Canto III dell’Eracleide
Possibile, oggi come oggi, far ricorso a una disciplina quale la grammaire du récit per provarsi ad accostare e sondare un racconto in versi risalente al primo quarto del XVII secolo? È la scommessa tentata in questo volume, che ripubblica e commenta il terzo canto d’una vasta epopea di conio tassiano (L’Eracleide di Gabriele Zinano) aspirando a lumeggiarne la tecnica narrativa e la stessa poetica, all’insegna dello sforzo, dello scialo e del puntiglio.
Lettura del Canto III dell’Eracleide
Possibile, oggi come oggi, far ricorso a una disciplina quale la grammaire du récit per provarsi ad accostare e sondare un racconto in versi risalente al primo quarto del XVII secolo? È la scommessa tentata in questo volume, che ripubblica e commenta il terzo canto d’una vasta epopea di conio tassiano (L’Eracleide di Gabriele Zinano) aspirando a lumeggiarne la tecnica narrativa e la stessa poetica, all’insegna dello sforzo, dello scialo e del puntiglio.

7
Struttura e funzione del monologo nel teatro terenziano
Nella storia degli studi sul teatro romano poca attenzione è stata riservata finora all’analisi del monologo nelle commedie terenziane e il debole interesse della critica è stato motivato attraverso la presunta “avversione” del poeta verso questo espediente drammaturgico. Un’attenta lettura delle Commedie rivela, invece, il ricorso costante di Terenzio al monologo e perfino l’uso di una tecnica raffinata. Il poeta sfrutta, infatti, a pieno le possibilità drammaturgiche che il monologo gli offre, se ne serve con accortezza stilistica e consapevolezza, e impiega questo strumento con diverse funzioni sceniche. Negli spettacoli terenziani il monologo arriva ad acquisire caratteristiche innovative, specchio di una nuova idea di teatro e segno ulteriore dell’originalità di Terenzio rispetto ai suoi modelli.
Nella storia degli studi sul teatro romano poca attenzione è stata riservata finora all’analisi del monologo nelle commedie terenziane e il debole interesse della critica è stato motivato attraverso la presunta “avversione” del poeta verso questo espediente drammaturgico. Un’attenta lettura delle Commedie rivela, invece, il ricorso costante di Terenzio al monologo e perfino l’uso di una tecnica raffinata. Il poeta sfrutta, infatti, a pieno le possibilità drammaturgiche che il monologo gli offre, se ne serve con accortezza stilistica e consapevolezza, e impiega questo strumento con diverse funzioni sceniche. Negli spettacoli terenziani il monologo arriva ad acquisire caratteristiche innovative, specchio di una nuova idea di teatro e segno ulteriore dell’originalità di Terenzio rispetto ai suoi modelli.

6
L’Artificio, L’Inganno e la Seduzione
Espedienti metateatrali e illusioni nel teatro italiano tra commedia e opera buffa
È possibile fare teatro mostrando un palcoscenico vuoto e persuadere gli spettatori che sono di fronte al più meraviglioso spettacolo mai messo in scena? Se il fascino del teatro parte inizialmente da un copione e dalla scrittura, quanti inganni e quante illusioni sanno costruire le parole? Le parole possono riempire una scena vuota, lo spazio di un palcoscenico senza maschere né attori, senza scene né musica. Un vuoto che tuttavia comunica perché, attraverso la scena come attraverso uno specchio, lega e incrocia gli sguardi di chi partecipa all’evento teatrale riflettendo la fantasia di cui è capace l’immaginazione umana.
Espedienti metateatrali e illusioni nel teatro italiano tra commedia e opera buffa
È possibile fare teatro mostrando un palcoscenico vuoto e persuadere gli spettatori che sono di fronte al più meraviglioso spettacolo mai messo in scena? Se il fascino del teatro parte inizialmente da un copione e dalla scrittura, quanti inganni e quante illusioni sanno costruire le parole? Le parole possono riempire una scena vuota, lo spazio di un palcoscenico senza maschere né attori, senza scene né musica. Un vuoto che tuttavia comunica perché, attraverso la scena come attraverso uno specchio, lega e incrocia gli sguardi di chi partecipa all’evento teatrale riflettendo la fantasia di cui è capace l’immaginazione umana.

5
Squarzina e Pirandello
Dalla matrice narrativa alla realizzazione scenica
L'autore delinea un profilo critico di Luigi Squarzina, regista teatrale, drammaturgo, saggista, teorico e storico del teatro, ma anche docente universitario prima a Bologna, poi a Roma. Nel saggio approfondisce quello che per circa un sessantennio è stato il rapporto del suo Maestro con la drammaturgia e il teatro di Pirandello.
Dalla matrice narrativa alla realizzazione scenica
L'autore delinea un profilo critico di Luigi Squarzina, regista teatrale, drammaturgo, saggista, teorico e storico del teatro, ma anche docente universitario prima a Bologna, poi a Roma. Nel saggio approfondisce quello che per circa un sessantennio è stato il rapporto del suo Maestro con la drammaturgia e il teatro di Pirandello.

4
I volti di Partenope
La drammaturgia napoletana del Novecento da Bracco a De Simone
La drammaturgia napoletana tra secondo Ottocento e Novecento è stata in questi anni al centro di progetti di ricerca e di convegni internazionali promossi dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Master di II livello in Letteratura, scrittura e critica teatrale.
La drammaturgia napoletana del Novecento da Bracco a De Simone
La drammaturgia napoletana tra secondo Ottocento e Novecento è stata in questi anni al centro di progetti di ricerca e di convegni internazionali promossi dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Master di II livello in Letteratura, scrittura e critica teatrale.
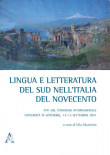
3
Lingua e letteratura del Sud nell’Italia del Novecento
Atti del Convegno internazionale, Università di Göteborg, 13-14-15 settembre 2011
Luogo deputato dell’anima, oltre che scenario di struggente bellezza, il meridione d’Italia ha visto nascere, nel tempo, opere che hanno scandito il ritmo della letteratura italiana, dandole un carattere, una fisionomia ed un significato fra i piú decisivi nella sua storia millenaria. Ma il Sud è anche stato sempre fonte di grande ispirazione per scrittori di tutto il mondo.
Atti del Convegno internazionale, Università di Göteborg, 13-14-15 settembre 2011
Luogo deputato dell’anima, oltre che scenario di struggente bellezza, il meridione d’Italia ha visto nascere, nel tempo, opere che hanno scandito il ritmo della letteratura italiana, dandole un carattere, una fisionomia ed un significato fra i piú decisivi nella sua storia millenaria. Ma il Sud è anche stato sempre fonte di grande ispirazione per scrittori di tutto il mondo.
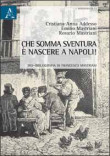
2
Che somma sventura è nascere a Napoli!
Bio-bibliografia di Francesco Mastriani
L’opera di Francesco Mastriani (Napoli, 1819-1891), romanziere d’appendice, giornalista letterario, critico ed autore di teatro, costituisce un ‘caso’ nella Napoli ottocentesca in quanto a continuità, eterogeneità e ‘quantità’. Questo volume ne offre uno studio bio-bibliografico, prendendone in esame la produzione narrativa costituita da oltre cento romanzi, la scrittura giornalistica ed il teatro. Alle ‘opere’ sono stati [...]
Bio-bibliografia di Francesco Mastriani
L’opera di Francesco Mastriani (Napoli, 1819-1891), romanziere d’appendice, giornalista letterario, critico ed autore di teatro, costituisce un ‘caso’ nella Napoli ottocentesca in quanto a continuità, eterogeneità e ‘quantità’. Questo volume ne offre uno studio bio-bibliografico, prendendone in esame la produzione narrativa costituita da oltre cento romanzi, la scrittura giornalistica ed il teatro. Alle ‘opere’ sono stati [...]

1
Francesco Mastriani. Novelle Scene e Racconti
Con appendice di testi
Nel 1867 Francesco Mastriani raccoglie in volume, con il titolo Novelle Scene e Racconti. In questa edizone la raccolta Novelle Scene e Racconti è arricchita da un’Appendice contenente una parte dei testi inediti che Mastriani escluse dalla raccolta del 1867.
Con appendice di testi
Nel 1867 Francesco Mastriani raccoglie in volume, con il titolo Novelle Scene e Racconti. In questa edizone la raccolta Novelle Scene e Racconti è arricchita da un’Appendice contenente una parte dei testi inediti che Mastriani escluse dalla raccolta del 1867.
Andreaus Michele, Università di Trento
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Processo di presentazione, valutazione ed accettazione dei contributi in volume (opere monografiche, raccolte e atti di convegno)
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
EVENTI
VIDEO
recensioni
approfondimenti

SINTESI
PUBBLICAZIONI
EVENTI

Informativa
Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto








