
Riverrun
Collana di letteratura e cultura inglese
Collana di letteratura e cultura inglese
| Direttore | Raffaella Antinucci, Michela Marroni |
| Comitato scientifico | Benedetta Bini, Mariaconcetta Costantini, Andrew Hiscock, Mihaela Irimia, Sandro Jung, Gloria Lauri-Lucente, Jude Nixon, Francesca Orestano, Biancamaria Rizzardi, Philip Tew |
| Comitato di redazione | Luca Baratta, Alessandra Olga Grazia Serra, Martina Zamparo |
| Coordinamento di Redazione | Renzo D’Agnillo |
La collana intende promuovere lo studio della letteratura e della cultura inglese, rivolgendo un’attenzione particolare alle letterature e alle culture anglofone nella loro dimensione innovativa, intese cioè come produzione di testi che parlano di altri mondi, di altre sensibilità artistiche, di altre modalità espressive e conoscitive. Da questo punto di vista, rimane la centralità della lingua e della letteratura inglese tout-court, termini imprescindibili di un confronto con la tradizione. Mentre la lingua inglese allarga sempre più lo spazio della sua funzionalità nella comunicazione e impone la sua egemonia linguistico-culturale, nel panorama globalizzato del terzo millennio nulla è immobile in un processo in cui non è sempre facile distinguere chi influenza da chi è influenzato – anche in termini culturologici. Di qui il ruolo assunto dal concetto di “attraversamento” che implica anche fluidità e permeabilità degli spazi culturali. Un riverrun che si sostituisce alla dialettica centro/periferia o, se si vuole, alla coppia oppositiva continuità/discontinuità, configurando in tal modo un territorio nuovo per gli studi di anglistica, anche sul piano della ricerca comparativa e interculturale.

22
Traduzione e intermedialità nella prosa breve di Samuel Beckett
Imagination morte imaginez e Assez
In un confronto con l’intero corpus beckettiano, con l’attività di autotraduzione e con le carte manoscritte, si sono osservati aspetti primari — fonetici, grammatico–lessicali e sintattici — e secondari del discorso — tipologia testuale, genere — ma anche fattori materiali del medium prescelto per l’atto comunicativo, ricorrendo ora agli strumenti dell’analisi dei corpora, ora alla narratologia, ma anche all’analisi del discorso e alla traduttologia.
Imagination morte imaginez e Assez
In un confronto con l’intero corpus beckettiano, con l’attività di autotraduzione e con le carte manoscritte, si sono osservati aspetti primari — fonetici, grammatico–lessicali e sintattici — e secondari del discorso — tipologia testuale, genere — ma anche fattori materiali del medium prescelto per l’atto comunicativo, ricorrendo ora agli strumenti dell’analisi dei corpora, ora alla narratologia, ma anche all’analisi del discorso e alla traduttologia.

21
Filomela, Filomele
Variazioni del mito ovidiano nella letteratura in lingua inglese
Il volume esplora la macronarrazione del mito ovidiano di Filomela nella letteratura in lingua inglese attraverso l’esame di riscritture poetiche, in prosa e teatrali da Geoffrey Chaucer fino ad autrici contemporanee. Per questa indagine ci si avvale dei presupposti teorici dei Classical Reception Studies e di un modello interpretativo che guarda alle dinamiche del genere testuale e alle strategie retoriche della messa in discorso della storia antica.
Variazioni del mito ovidiano nella letteratura in lingua inglese
Il volume esplora la macronarrazione del mito ovidiano di Filomela nella letteratura in lingua inglese attraverso l’esame di riscritture poetiche, in prosa e teatrali da Geoffrey Chaucer fino ad autrici contemporanee. Per questa indagine ci si avvale dei presupposti teorici dei Classical Reception Studies e di un modello interpretativo che guarda alle dinamiche del genere testuale e alle strategie retoriche della messa in discorso della storia antica.

20
Disorderly Families
La teatralizzazione dell’incesto da Shakespeare a Ford
Il volume è dedicato al tema dell’incesto nel teatro inglese, seguendo un percorso che copre circa un trentennio a cavallo fra XVI e XVII secolo. A un’ampia sezione introduttiva, che offre le coordinate storico–culturali utili a spiegare la costruzione retorica e politica della famiglia, seguono le analisi ravvicinate delle opere di Shakespeare, Beaumont, Fletcher e Ford.
La teatralizzazione dell’incesto da Shakespeare a Ford
Il volume è dedicato al tema dell’incesto nel teatro inglese, seguendo un percorso che copre circa un trentennio a cavallo fra XVI e XVII secolo. A un’ampia sezione introduttiva, che offre le coordinate storico–culturali utili a spiegare la costruzione retorica e politica della famiglia, seguono le analisi ravvicinate delle opere di Shakespeare, Beaumont, Fletcher e Ford.

19
Viaggio nella narrativa postapocalittica
Teorie, credenze, affabulazioni
Il libro analizza la narrativa del Regno Unito appartenente al filone postapocalittico, affrontando gli approcci teorici e le caratteristiche intrinseche del genere, proponendo una classificazione delle opere e rilevando i propositi metatestuali degli autori e le loro interazioni con il pubblico. Si propongono inoltre un’intervista esclusiva a M.J. Harrison e un sondaggio oltre che lo studio particolareggiato di tre libri che esemplificano lo sviluppo diacronico del genere.
Teorie, credenze, affabulazioni
Il libro analizza la narrativa del Regno Unito appartenente al filone postapocalittico, affrontando gli approcci teorici e le caratteristiche intrinseche del genere, proponendo una classificazione delle opere e rilevando i propositi metatestuali degli autori e le loro interazioni con il pubblico. Si propongono inoltre un’intervista esclusiva a M.J. Harrison e un sondaggio oltre che lo studio particolareggiato di tre libri che esemplificano lo sviluppo diacronico del genere.

18
Elisabetta I poetessa e regina
Questo volume si propone di presentare al pubblico italiano le poesie di Elisabetta I, la regina inglese dei tempi di William Shakespeare e Christopher Marlowe, e indiscussa protagonista femminile della lotta per il potere nell’Europa contemporanea.
Questo volume si propone di presentare al pubblico italiano le poesie di Elisabetta I, la regina inglese dei tempi di William Shakespeare e Christopher Marlowe, e indiscussa protagonista femminile della lotta per il potere nell’Europa contemporanea.

17
Ellenismi britannici
L’ellenismo nella poesia, nelle arti e nella cultura britannica dagli augustei al romanticismo
Il volume esamina il recupero dell’eredità ellenica che ha interessato la letteratura, l’arte e la cultura britanniche dall’età augustea al romanticismo.
L’ellenismo nella poesia, nelle arti e nella cultura britannica dagli augustei al romanticismo
Il volume esamina il recupero dell’eredità ellenica che ha interessato la letteratura, l’arte e la cultura britanniche dall’età augustea al romanticismo.
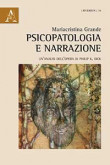
16
Psicopatologia e narrazione
Un’analisi dell’opera di Philip K. Dick
Philip Kindred Dick è ormai ritenuto la più grande firma del panorama letterario postmodernista. I mondi descritti sono universi in cui il processo conoscitivo rifiuta la distinzione tra normalité, folie e déraison ed in cui l’insistenza su tematiche legate alla psicopatologia mentale si intreccia alla disperata ricerca di una verità, penultima che possa essere, la cui immanenza rimanderebbe all’esperienza di comunione empatica, ultimo senso dell’esistenza umana.
Un’analisi dell’opera di Philip K. Dick
Philip Kindred Dick è ormai ritenuto la più grande firma del panorama letterario postmodernista. I mondi descritti sono universi in cui il processo conoscitivo rifiuta la distinzione tra normalité, folie e déraison ed in cui l’insistenza su tematiche legate alla psicopatologia mentale si intreccia alla disperata ricerca di una verità, penultima che possa essere, la cui immanenza rimanderebbe all’esperienza di comunione empatica, ultimo senso dell’esistenza umana.

15
Nel mondo di John Fante
Autobiografismo e furore letterario
Questo studio prende in esame l’opera di John Fante con l’obiettivo di delinearne il percorso tematico e formale, senza ignorarne la dimensione autobiografica. Nella sua compattezza tematica e ampia prospettiva socioculturale, la narrativa fantiana è qualcosa di straordinariamente nuovo nel panorama letterario del Novecento americano.
Autobiografismo e furore letterario
Questo studio prende in esame l’opera di John Fante con l’obiettivo di delinearne il percorso tematico e formale, senza ignorarne la dimensione autobiografica. Nella sua compattezza tematica e ampia prospettiva socioculturale, la narrativa fantiana è qualcosa di straordinariamente nuovo nel panorama letterario del Novecento americano.

14
Oltre la fantascienza
Paradigmi e intertestualità nella narrativa di J. G. Ballard
J. G. Ballard è uno degli autori più visionari e discussi del Novecento. Negli anni Sessanta, promuove un progetto di rinnovamento della fantascienza rivolgendosi all’universo interiore dell’uomo piuttosto che ai temi classici. Esploratore profondo dell’inconscio, le sue metafore estreme svelano gli effetti destabilizzanti del paesaggio mediatico sulla psiche.
Paradigmi e intertestualità nella narrativa di J. G. Ballard
J. G. Ballard è uno degli autori più visionari e discussi del Novecento. Negli anni Sessanta, promuove un progetto di rinnovamento della fantascienza rivolgendosi all’universo interiore dell’uomo piuttosto che ai temi classici. Esploratore profondo dell’inconscio, le sue metafore estreme svelano gli effetti destabilizzanti del paesaggio mediatico sulla psiche.

13
La seconda chance
Bilinguismo e auto–traduzione nell’opera di Samuel Beckett
Come Beckett spiega a Ferdeman scrivere in una seconda lingua e poter correggere il testo traducendolo, offre allo scrittore, una seconda possibilità di dire ciò che voleva dire.Il libro composto in quattro capitoli, contiene: una rassegna della critica beckettiana sul bilinguismo e l’auto-traduzione; una casistica per categorie degli scarti testuali nell’opera di Beckett; un’interpretazione critica di una tale pratica dell’auto–traduzione e un’intervista a Raymond Federman.
Bilinguismo e auto–traduzione nell’opera di Samuel Beckett
Come Beckett spiega a Ferdeman scrivere in una seconda lingua e poter correggere il testo traducendolo, offre allo scrittore, una seconda possibilità di dire ciò che voleva dire.Il libro composto in quattro capitoli, contiene: una rassegna della critica beckettiana sul bilinguismo e l’auto-traduzione; una casistica per categorie degli scarti testuali nell’opera di Beckett; un’interpretazione critica di una tale pratica dell’auto–traduzione e un’intervista a Raymond Federman.

12
Arnold Bennett, David Herbert Lawrence, Giovanni Verga
Transitional realism, translation and dialect
This work investigates the relationship between translation, transition and realism in connection with the development of dialectal forms, the concept of city and travel images in late-nineteenth-century literary production in Europe, with particular emphasis on French, English and Italian realist literature.
Transitional realism, translation and dialect
This work investigates the relationship between translation, transition and realism in connection with the development of dialectal forms, the concept of city and travel images in late-nineteenth-century literary production in Europe, with particular emphasis on French, English and Italian realist literature.

11
Elizabeth Inchbald: scandalo e convenzione
Romanzo e teatro nell’Inghilterra della Reggenza
Elizabeth Inchbald fu una delle più significative personalità della cultura inglese fra Sette e Ottocento e riscosse grande successo come romanziera e come drammaturga. Amica di Kemble, Holcroft e Godwin, ella si schierò su posizioni politiche “giacobine”, ma in lei il radicalismo e la tentazione dello scandalo sono temperati da un moralismo che la rende una figura insieme puritana e trasgressiva, inibita e spregiudicata.
Romanzo e teatro nell’Inghilterra della Reggenza
Elizabeth Inchbald fu una delle più significative personalità della cultura inglese fra Sette e Ottocento e riscosse grande successo come romanziera e come drammaturga. Amica di Kemble, Holcroft e Godwin, ella si schierò su posizioni politiche “giacobine”, ma in lei il radicalismo e la tentazione dello scandalo sono temperati da un moralismo che la rende una figura insieme puritana e trasgressiva, inibita e spregiudicata.
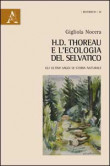
10
H.D. Thoreau e l’ecologia del selvatico
Gli ultimi saggi di storia naturale
Di H.D. Thoreau (1817-1862), trascendentalista, autore di Walden (1854) e di saggi libertari quali La disobbedienza civile (1849), viene qui riscoperta l’attività di studioso della natura e dell’America pre-colombiana così come espressa negli ultimi saggi di storia naturale redatti tra il 1851 e il 1862, anno della morte.
Gli ultimi saggi di storia naturale
Di H.D. Thoreau (1817-1862), trascendentalista, autore di Walden (1854) e di saggi libertari quali La disobbedienza civile (1849), viene qui riscoperta l’attività di studioso della natura e dell’America pre-colombiana così come espressa negli ultimi saggi di storia naturale redatti tra il 1851 e il 1862, anno della morte.

9
Leggendo Godot
Questo bel volume, una completa ed esaustiva lettura di Waiting for Godot preceduta da una riflessione sulle tematiche principali poste dallo studio di Beckett, si propone fra i suoi scopi primari la presentazione, decrittazione e illuminazione del capolavoro beckettiano per gli studenti universitari italiani.
Questo bel volume, una completa ed esaustiva lettura di Waiting for Godot preceduta da una riflessione sulle tematiche principali poste dallo studio di Beckett, si propone fra i suoi scopi primari la presentazione, decrittazione e illuminazione del capolavoro beckettiano per gli studenti universitari italiani.
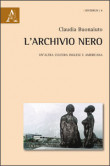
8
L'archivio nero
Un'altra cultura inglese e americana
L’Archivio nero istituisce un nuovo edificio simbolico fatto di moderni linguaggi espressivi, altre memorie, genealogie di pensatori africani–caraibici–britannici–americani in grado di rac-contare la storia dalla parte di coloro che sono stati esclusi dagli archivi e musei eurocentrici. Da una prospettiva metodologica degli studi culturali e postcoloniali, il libro è alla riscoperta di una storia e cultura inglese e americana mai detta, repressa, ovvero rivelata sotto altra luce dal Nobel Derek Walcott, dal premio Pulitzer Alice Walker, dal pluripremiato Caryl Phillips, dal pittore digitale Keith Piper e dal cineasta d’avanguardia Isaac Julien. Questi scrittori e artisti del mondo anglofono producono opere estetiche ma soprattutto politiche, all’insegna dell’identità della diaspora africana che non solo mette in relazione più tradizioni tra Africa, Europa e Americhe, ma che inventa nuove arti della memoria attraverso musica, teatro, letteratura, arti visive e cinema.
Un'altra cultura inglese e americana
L’Archivio nero istituisce un nuovo edificio simbolico fatto di moderni linguaggi espressivi, altre memorie, genealogie di pensatori africani–caraibici–britannici–americani in grado di rac-contare la storia dalla parte di coloro che sono stati esclusi dagli archivi e musei eurocentrici. Da una prospettiva metodologica degli studi culturali e postcoloniali, il libro è alla riscoperta di una storia e cultura inglese e americana mai detta, repressa, ovvero rivelata sotto altra luce dal Nobel Derek Walcott, dal premio Pulitzer Alice Walker, dal pluripremiato Caryl Phillips, dal pittore digitale Keith Piper e dal cineasta d’avanguardia Isaac Julien. Questi scrittori e artisti del mondo anglofono producono opere estetiche ma soprattutto politiche, all’insegna dell’identità della diaspora africana che non solo mette in relazione più tradizioni tra Africa, Europa e Americhe, ma che inventa nuove arti della memoria attraverso musica, teatro, letteratura, arti visive e cinema.

7
Joyce, Give and Take
Joyce, Give and Take is a collection of four essays that comparatively explore the theme of influence in James Joyce’s works. The first two essays investigate the kind of influence the Italian humanist philosopher Giovanni Pico della Mirandola and the romantic poet, engraver and painter William Blake have exerted on the Irish writer. By contrast the other two focus on the influence that Joyce has exercised on the stateless writer Vladimir Nabokov, and on the postcolonial poet and playwright Derek Walcott. Such a wide perspective offers challenging insights into Joyce’s works, and into the kind of literary reciprocity that is enacted through his writing. On the one hand Joyce subsumes in his opus the Western literary canon, on the other he becomes an inescapable reference point for any writer who aims at representing modernity.
Joyce, Give and Take is a collection of four essays that comparatively explore the theme of influence in James Joyce’s works. The first two essays investigate the kind of influence the Italian humanist philosopher Giovanni Pico della Mirandola and the romantic poet, engraver and painter William Blake have exerted on the Irish writer. By contrast the other two focus on the influence that Joyce has exercised on the stateless writer Vladimir Nabokov, and on the postcolonial poet and playwright Derek Walcott. Such a wide perspective offers challenging insights into Joyce’s works, and into the kind of literary reciprocity that is enacted through his writing. On the one hand Joyce subsumes in his opus the Western literary canon, on the other he becomes an inescapable reference point for any writer who aims at representing modernity.

6
Mark the Music
The Language of Music in English Literature from Shakespeare to Salman Rushdie
Mark the Music responds to Bakhtin’s invitation to look to one language through the eyes (and ears) of another, offering a musical reading of some key moments and experiences relating to the world of English literature from Shakespeare to Wilde, from Woolf to Rushdie, in a process in which music is considered as pure sound, as discourse and as a fundamental social practice.
The Language of Music in English Literature from Shakespeare to Salman Rushdie
Mark the Music responds to Bakhtin’s invitation to look to one language through the eyes (and ears) of another, offering a musical reading of some key moments and experiences relating to the world of English literature from Shakespeare to Wilde, from Woolf to Rushdie, in a process in which music is considered as pure sound, as discourse and as a fundamental social practice.

5
Victorian Dominatrices
Women of Arcane Power in Nineteenth-Century Fiction
Victorian Dominatrices investigates women of arcane power in the fiction by Charlotte Brontë, William Morris, Thomas Hardy, Vernon Lee and Ford Madox Ford. This study focuses on a variety of fictional genres (gothic, romance, naturalistic, fantastic, and impressionistic) and situates them in the fields of art, culture and society.
Women of Arcane Power in Nineteenth-Century Fiction
Victorian Dominatrices investigates women of arcane power in the fiction by Charlotte Brontë, William Morris, Thomas Hardy, Vernon Lee and Ford Madox Ford. This study focuses on a variety of fictional genres (gothic, romance, naturalistic, fantastic, and impressionistic) and situates them in the fields of art, culture and society.

3
Shakespeare and the Power of Difference
The celebrity of Shakespeare is not just great; it is of a different kind. Along with the Shakespeare industry there exist other, more anarchic Shakespeares, as exemplified by rewritings, adaptations and alternative performances across a range of media. This volume — mainly addressed to Italian graduate students of English — combines cultural reflections and close readings, with the aim to trace difference in the early modern inscriptions of Shakespeare’s language.
The celebrity of Shakespeare is not just great; it is of a different kind. Along with the Shakespeare industry there exist other, more anarchic Shakespeares, as exemplified by rewritings, adaptations and alternative performances across a range of media. This volume — mainly addressed to Italian graduate students of English — combines cultural reflections and close readings, with the aim to trace difference in the early modern inscriptions of Shakespeare’s language.

2
Verso l’Itaca antillana
Omeros di Derek Walcott
l volume funge da introduzione a Omeros (1990, 2003 1 ed. italiana), poema di ambizioni epiche e problematiche postcoloniali, che è valso il Premio Nobel a Derek Walcott. Il primo capitolo del libro colloca l’opera nel contesto culturale. Il secondo capitolo indaga la dibattuta classificazione dell’opera come poema epico, soffermandosi su alcuni episodi emblematici. L’ultima parte della monografia spiega la composizione linguistica sia del testo sia dell’isola in esso cantata.
Omeros di Derek Walcott
l volume funge da introduzione a Omeros (1990, 2003 1 ed. italiana), poema di ambizioni epiche e problematiche postcoloniali, che è valso il Premio Nobel a Derek Walcott. Il primo capitolo del libro colloca l’opera nel contesto culturale. Il secondo capitolo indaga la dibattuta classificazione dell’opera come poema epico, soffermandosi su alcuni episodi emblematici. L’ultima parte della monografia spiega la composizione linguistica sia del testo sia dell’isola in esso cantata.

1
Jane Austen’s Emma
Revisitations and Critical Contexts
The editors of this collection believe that a novel like Emma continues to speak to us, and continues to do so in that peculiar tone that pertains only tomasterpieces as they relentlessly strive to reinscribe themselves anew in the mind of each reader.
Revisitations and Critical Contexts
The editors of this collection believe that a novel like Emma continues to speak to us, and continues to do so in that peculiar tone that pertains only tomasterpieces as they relentlessly strive to reinscribe themselves anew in the mind of each reader.
Andreaus Michele, Università di Trento
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Processo di presentazione, valutazione ed accettazione dei contributi in volume (opere monografiche, raccolte e atti di convegno)
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
EVENTI
VIDEO
recensioni
approfondimenti

SINTESI
PUBBLICAZIONI

Informativa
Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto








