
trópos profili
Monografie
Monografie
| Direttore | Gaetano Chiurazzi |
| Comitato scientifico | Gianluca Cuozzo, Jeremy Robert Nicholas Davey, Federico Luisetti, Jeff Malpas, Roberto Salizzoni, Gianni Vattimo |
Le collane “trópos orizzonti” e “trópos profili” estendono la proposta nata con la rivista «trópos» attraverso la pubblicazione di opere collettanee (nella sezione “orizzonti”) e monografiche (nella sezione “profili”) che riflettono su temi della tradizione ermeneutica, ma che si prestano altresì a interagire con altri ambiti disciplinari, dall’estetica all’architettura, dalla politica all’etica.

23
L’apertura della domanda
Gadamer e il carattere dialogico dell'esperienza
Seguendo il filo conduttore della concezione della domanda nel pensiero di Hans-Georg Gadamer (1900-2002) è possibile comprenderne non solo i passaggi più rilevanti, ma anche l’attualità. In tal senso l’indagine ricostruisce il recupero gadameriano della componente dialogica della dialettica platonica, per poi rivolgersi all’interpretazione della dicotomia di domanda e problema, in grado di spiegarci che cosa significhi domandare.
Gadamer e il carattere dialogico dell'esperienza
Seguendo il filo conduttore della concezione della domanda nel pensiero di Hans-Georg Gadamer (1900-2002) è possibile comprenderne non solo i passaggi più rilevanti, ma anche l’attualità. In tal senso l’indagine ricostruisce il recupero gadameriano della componente dialogica della dialettica platonica, per poi rivolgersi all’interpretazione della dicotomia di domanda e problema, in grado di spiegarci che cosa significhi domandare.

22
Natura e Spirito
Lezioni del semestre estivo 1927
Il volume raccoglie alcune riflessioni composte da Husserl nel 1927. Nei testi, l’autore insiste sull’importanza del “mondo–della–vita” soggettivo–relativo, utile “terreno di fondazione” anche per il mondo oggettivo delle scienze. Le teorie scientifiche conservano, infatti, un loro contenuto positivo, un riferimento oggettivo alla realtà, proprio mediante nozioni pre–scientifiche che cercano invece di naturalizzare.
Lezioni del semestre estivo 1927
Il volume raccoglie alcune riflessioni composte da Husserl nel 1927. Nei testi, l’autore insiste sull’importanza del “mondo–della–vita” soggettivo–relativo, utile “terreno di fondazione” anche per il mondo oggettivo delle scienze. Le teorie scientifiche conservano, infatti, un loro contenuto positivo, un riferimento oggettivo alla realtà, proprio mediante nozioni pre–scientifiche che cercano invece di naturalizzare.

21
Interpretazioni della Metafisica di Aristotele
Teologia e ontologia modale. Tomo II
L’opera si prefigge una lettura della Filosofia Prima di Aristotele, secondo i parametri e i risultati raggiunti dalla critica aristotelica del XX secolo. La ricerca, svolta in base a una dettagliata comparazione dei testi e delle loro problematiche, sia dal punto di vista storico che ermeneutico, si propone il recupero del contesto greco in cui è nata la Metafisica aristotelica.
Teologia e ontologia modale. Tomo II
L’opera si prefigge una lettura della Filosofia Prima di Aristotele, secondo i parametri e i risultati raggiunti dalla critica aristotelica del XX secolo. La ricerca, svolta in base a una dettagliata comparazione dei testi e delle loro problematiche, sia dal punto di vista storico che ermeneutico, si propone il recupero del contesto greco in cui è nata la Metafisica aristotelica.

20
Interpretazioni della Metafisica di Aristotele
Tomo I
L’opera si prefigge una lettura della Filosofia Prima di Aristotele secondo i parametri e i risultati raggiunti dalla critica aristotelica del XX secolo, recuperando del contesto greco in cui è nata la Metafisica aristotelica. L’autrice espone la complessa unità e la sistematicità aperta proprie dell’“ontologia delle differenze” dello Stagirita. Si percorrono, quindi, le sue topologie plurali e l’articolazione seriale dei suoi nessi dottrinali.
Tomo I
L’opera si prefigge una lettura della Filosofia Prima di Aristotele secondo i parametri e i risultati raggiunti dalla critica aristotelica del XX secolo, recuperando del contesto greco in cui è nata la Metafisica aristotelica. L’autrice espone la complessa unità e la sistematicità aperta proprie dell’“ontologia delle differenze” dello Stagirita. Si percorrono, quindi, le sue topologie plurali e l’articolazione seriale dei suoi nessi dottrinali.

19
Appello e decisione
Arte, linguaggio e poesia tra Martin Heidegger, Romano Guardini e Walter F. Otto
Attraverso l’intrecciarsi del loro pensiero a partire dalle vicende biografiche, il volume conduce un dialogo a tre tra Heidegger, Guardini e Otto rilevando in essi, tra analogie e differenze, la centralità dell’esperienza artistica e della parola poetica come luoghi privilegiati di apertura dell’essere e di rivelazione del sacro.
Arte, linguaggio e poesia tra Martin Heidegger, Romano Guardini e Walter F. Otto
Attraverso l’intrecciarsi del loro pensiero a partire dalle vicende biografiche, il volume conduce un dialogo a tre tra Heidegger, Guardini e Otto rilevando in essi, tra analogie e differenze, la centralità dell’esperienza artistica e della parola poetica come luoghi privilegiati di apertura dell’essere e di rivelazione del sacro.

18
Intuizione e riflessione nella fenomenologia di Edmund Husserl
Il volume indaga, sul piano metodologico e teoretico, il rapporto tra intuizione e riflessione nella fenomenologia di Edmund Husserl.
Il volume indaga, sul piano metodologico e teoretico, il rapporto tra intuizione e riflessione nella fenomenologia di Edmund Husserl.

17
Origine ed epilogo dell'intellettuale
Persona, educazione e politica in Ortega y Gasset
Un viaggio all’interno della filosofia di José Ortega y Gasset realizzato seguendo una luce fissa: la sua inguaribile passione per l’insegnamento e per la vita intellettuale. Ma chi può davvero dirsi intellettuale? Esiste tale figura sociale? Sono queste alcune delle questioni a cui il volume dà una risposta attraverso l’analisi della teoria dell’educazione del più grande filosofo spagnolo e di una delle voci più autorevoli dell’Europa del XX secolo.
Persona, educazione e politica in Ortega y Gasset
Un viaggio all’interno della filosofia di José Ortega y Gasset realizzato seguendo una luce fissa: la sua inguaribile passione per l’insegnamento e per la vita intellettuale. Ma chi può davvero dirsi intellettuale? Esiste tale figura sociale? Sono queste alcune delle questioni a cui il volume dà una risposta attraverso l’analisi della teoria dell’educazione del più grande filosofo spagnolo e di una delle voci più autorevoli dell’Europa del XX secolo.

16
Pavel A. Florenskij
I due mondi dell’icona fra prospettiva rovesciata e metafisica concreta
Nella Sofia scriviamo l'icona. Una donna di fuoco imprime la Verità vivente sulla tavola, attraverso la luce e i colori. Una Verità che è volto luminoso, volto antiprospettico.
I due mondi dell’icona fra prospettiva rovesciata e metafisica concreta
Nella Sofia scriviamo l'icona. Una donna di fuoco imprime la Verità vivente sulla tavola, attraverso la luce e i colori. Una Verità che è volto luminoso, volto antiprospettico.

15
La fondazione della necessità degli oggetti ideali in Husserl
La critica di Husserl alla fondazione psicologistica della logica si fonda su un’attestazione di idealità e apriorità delle sue leggi. L’attestazione di necessità dell’ideale puro è garantita in ultimo dall’astrazione ideante. Problematicità del metodo ed incertezza degli esiti, che si pongono qui in luce, finiscono però per ricondurre Husserl stesso a difficoltà analoghe a quelle da lui esposte.
La critica di Husserl alla fondazione psicologistica della logica si fonda su un’attestazione di idealità e apriorità delle sue leggi. L’attestazione di necessità dell’ideale puro è garantita in ultimo dall’astrazione ideante. Problematicità del metodo ed incertezza degli esiti, che si pongono qui in luce, finiscono però per ricondurre Husserl stesso a difficoltà analoghe a quelle da lui esposte.

14
La società civile in Hegel
Critica e ricostruzione concettuale
Il progetto etico sviluppato da Hegel nei “Lineamenti di Filosofía del Diritto” contemplava di recuperare la totalità della polis greca senza negare all’individuo il diritto a una esistenza libera e autonoma. Ma il principio della particolarità rese illusoria la riconciliazione etica che egli si aspettava dallo Stato.
Critica e ricostruzione concettuale
Il progetto etico sviluppato da Hegel nei “Lineamenti di Filosofía del Diritto” contemplava di recuperare la totalità della polis greca senza negare all’individuo il diritto a una esistenza libera e autonoma. Ma il principio della particolarità rese illusoria la riconciliazione etica che egli si aspettava dallo Stato.

13
Latenze vichiane
Per un’"antropodicea": psicologia e mitologia da Jung a Joyce
Lungi dal voler fare di Vico il “precursore” di questa o quella riflessione novecentesca, questo studio ha avvertito l’esigenza di provocarne una rilettura alla luce del valore di humanitas nel senso più esteso del termine e tale da poter far pensare a una teodicea “non garantita”.
Per un’"antropodicea": psicologia e mitologia da Jung a Joyce
Lungi dal voler fare di Vico il “precursore” di questa o quella riflessione novecentesca, questo studio ha avvertito l’esigenza di provocarne una rilettura alla luce del valore di humanitas nel senso più esteso del termine e tale da poter far pensare a una teodicea “non garantita”.

12
Dalla parte dei fenomeni
Nello scoprire i fenomeni l’esistenza umana ha la caratteristica di scoprirsi essa stessa in quanto fenomeno dato. In questo volume l’autrice indaga il rapporto fra soggetto e mondo fenomenico tentando una ricollocazione della soggettività in relazione a una realtà fenomenica di cui essa non può riconoscersi origine.
Nello scoprire i fenomeni l’esistenza umana ha la caratteristica di scoprirsi essa stessa in quanto fenomeno dato. In questo volume l’autrice indaga il rapporto fra soggetto e mondo fenomenico tentando una ricollocazione della soggettività in relazione a una realtà fenomenica di cui essa non può riconoscersi origine.

11
Ricoeur e i suoi contemporanei
Bourdieu, Derrida, Deleuze, Foucault e Castoriadis
Paul Ricœur, maestro della filosofia del Novecento, a confronto con i massimi esponenti del post-strutturalismo: Johann Michel cerca per la prima volta di aprire questo dialogo, mostrando la difficoltà di “far risuonare” il pensiero di Valence, di Deleuze, di Bourdieu, di Foucault, di Derrida e di Castoriadis. Attraverso una serie di confronti, l’autore riesce a ricostruire una fase fondamentale della storia della filosofia contemporanea e di chiarire i punti nodali dell’opera ricœriana.
Bourdieu, Derrida, Deleuze, Foucault e Castoriadis
Paul Ricœur, maestro della filosofia del Novecento, a confronto con i massimi esponenti del post-strutturalismo: Johann Michel cerca per la prima volta di aprire questo dialogo, mostrando la difficoltà di “far risuonare” il pensiero di Valence, di Deleuze, di Bourdieu, di Foucault, di Derrida e di Castoriadis. Attraverso una serie di confronti, l’autore riesce a ricostruire una fase fondamentale della storia della filosofia contemporanea e di chiarire i punti nodali dell’opera ricœriana.

10
Un’acrobatica del pensiero
La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk
Negli ultimi dieci anni il filosofo tedesco Peter Sloterdijk ha sempre più conquistato la ribalta della scena intellettuale europea. I suoi saggi spaziano dall’estetica alla teoria dei media, dalla religione all’antropologia, dalla globalizzazione alla tecnica. È presente in essi un filo conduttore, o le sue sono da considerarsi incursioni nei differenti campi del sapere? La tesi di questo libro è che esistano due fili conduttori nella filosofia di Sloterdijk: il soggetto e l’esercizio.
La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk
Negli ultimi dieci anni il filosofo tedesco Peter Sloterdijk ha sempre più conquistato la ribalta della scena intellettuale europea. I suoi saggi spaziano dall’estetica alla teoria dei media, dalla religione all’antropologia, dalla globalizzazione alla tecnica. È presente in essi un filo conduttore, o le sue sono da considerarsi incursioni nei differenti campi del sapere? La tesi di questo libro è che esistano due fili conduttori nella filosofia di Sloterdijk: il soggetto e l’esercizio.

9
La topologia di Heidegger
Essere, luogo, mondo
Ripercorrendo le tappe del pensiero di Heidegger, l’autore delinea l’evoluzione della sua concezione topologica, la quale è animata dalla convinzione che il luogo non sia una nozione secondaria o derivata rispetto ai concetti di spazio o di tempo, ma che anzi rappresenti la condizione ineliminabile di qualunque riflessione filosofica sul mondo che ci circonda e su noi stessi.
Essere, luogo, mondo
Ripercorrendo le tappe del pensiero di Heidegger, l’autore delinea l’evoluzione della sua concezione topologica, la quale è animata dalla convinzione che il luogo non sia una nozione secondaria o derivata rispetto ai concetti di spazio o di tempo, ma che anzi rappresenti la condizione ineliminabile di qualunque riflessione filosofica sul mondo che ci circonda e su noi stessi.

8
Il Gioberti frainteso
Sulle tracce della condanna
La storiografia giobertiana ha divulgato almeno “due Gioberti”: l’autore essoterico, retrivo e neoguelfo delle opere edite e quello acroamatico e panteista delle opere inedite. Questo saggio, facendo ricorso alla filologia d’autore, ribadisce l’unitarietà del pensiero giobertiano
Sulle tracce della condanna
La storiografia giobertiana ha divulgato almeno “due Gioberti”: l’autore essoterico, retrivo e neoguelfo delle opere edite e quello acroamatico e panteista delle opere inedite. Questo saggio, facendo ricorso alla filologia d’autore, ribadisce l’unitarietà del pensiero giobertiano

7
La possibilità intransitiva
Per un'etica e un'ontologia della sospensione
La possibilità intransitiva è la possibilità che non transita, che né si realizza né non si realizza. Essa è indipendente dalla realtà effettiva e occorre perciò distinguerla tanto dalla potenza quanto da un’illusione retrospettiva. La possibilità intransitiva opera una sospensione non solo della realtà, ma anche della temporalità, senza con ciò impedire l’impegno etico o una qualunque assunzione di responsabilità.
Per un'etica e un'ontologia della sospensione
La possibilità intransitiva è la possibilità che non transita, che né si realizza né non si realizza. Essa è indipendente dalla realtà effettiva e occorre perciò distinguerla tanto dalla potenza quanto da un’illusione retrospettiva. La possibilità intransitiva opera una sospensione non solo della realtà, ma anche della temporalità, senza con ciò impedire l’impegno etico o una qualunque assunzione di responsabilità.
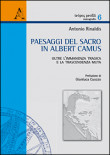
6
Paesaggi del sacro in Albert Camus
Oltre l’immanenza tragica e la trascendenza muta
Il Sacro come luogo intermedio dell’umano, intervallo fra la tentazione di una felicità terrena e sensuale e l’aspirazione a un contatto mistico con il Cielo, è la chiave di lettura del percorso esistenziale di Albert Camus. L’Assurdo, la Rivolta e l’Amore sono le tappe di un’ascesi che parte dal territorio disincantato dell’Assurdo, s’incammina sulla via della rivolta per la liberazione dell’uomo, per diventare ricerca solitaria di un contatto con l’Assoluto senza nome e senza volto.
Oltre l’immanenza tragica e la trascendenza muta
Il Sacro come luogo intermedio dell’umano, intervallo fra la tentazione di una felicità terrena e sensuale e l’aspirazione a un contatto mistico con il Cielo, è la chiave di lettura del percorso esistenziale di Albert Camus. L’Assurdo, la Rivolta e l’Amore sono le tappe di un’ascesi che parte dal territorio disincantato dell’Assurdo, s’incammina sulla via della rivolta per la liberazione dell’uomo, per diventare ricerca solitaria di un contatto con l’Assoluto senza nome e senza volto.

5
Nietzsche e il prospettivismo
Interpretazioni e influenze nella filosofia americana contemporanea
È possibile rinvenire tracce di legami e interessi per Friedrich Nietzsche nella filosofia americana degli ultimi sessanta anni nonostante l’apparente incompatibilità? Quali sono le nuove prospettive e gli sviluppi nella comprensione della filosofia contemporanea offerte da questo détournement? Una prima corposa risposta emerge qui dall’inconsueto approfondimento delle interpretazioni americane del pensiero di Nietzsche, in particolare del suo prospettivismo.
Interpretazioni e influenze nella filosofia americana contemporanea
È possibile rinvenire tracce di legami e interessi per Friedrich Nietzsche nella filosofia americana degli ultimi sessanta anni nonostante l’apparente incompatibilità? Quali sono le nuove prospettive e gli sviluppi nella comprensione della filosofia contemporanea offerte da questo détournement? Una prima corposa risposta emerge qui dall’inconsueto approfondimento delle interpretazioni americane del pensiero di Nietzsche, in particolare del suo prospettivismo.

4
Fusioni di orizzonti
Saggi su estetica e linguaggio in Hans-Georg Gadamer
Quello di “fusione degli orizzonti” è senza dubbio uno dei concetti-chiave dell’ermeneutica filosofica di Gadamer. Introdotto in Verità e metodo per indicare l’integrazione reciproca tra l’orizzonte di partenza dell’interprete, determinato dai suoi pregiudizi e dalle sue aspettative di senso, e quello della “cosa stessa” che è in gioco nel testo da interpretare.
Saggi su estetica e linguaggio in Hans-Georg Gadamer
Quello di “fusione degli orizzonti” è senza dubbio uno dei concetti-chiave dell’ermeneutica filosofica di Gadamer. Introdotto in Verità e metodo per indicare l’integrazione reciproca tra l’orizzonte di partenza dell’interprete, determinato dai suoi pregiudizi e dalle sue aspettative di senso, e quello della “cosa stessa” che è in gioco nel testo da interpretare.

3
Intersoggettività e discorso
Ermeneutica e verità nel pensiero di Karl-Otto Apel
In questo volume, a partire dal paradigma filosofico dell’intersoggettività, l’autore svolge un’analisi ricostruttiva della riflessione di Karl–Otto Apel sull’ermeneutica e sulla questione della verità. In questa chiave, il recupero della forza normativa del logos viene letto come essenziale per riarticolare un discorso si gnificativo sulla natura del sapere filosofico e la sua strutturale tensione all’universalità.
Ermeneutica e verità nel pensiero di Karl-Otto Apel
In questo volume, a partire dal paradigma filosofico dell’intersoggettività, l’autore svolge un’analisi ricostruttiva della riflessione di Karl–Otto Apel sull’ermeneutica e sulla questione della verità. In questa chiave, il recupero della forza normativa del logos viene letto come essenziale per riarticolare un discorso si gnificativo sulla natura del sapere filosofico e la sua strutturale tensione all’universalità.

2
Sulla propria pelle
La questione trascendentale tra Kant e Deleuze
Per mostrare l’incessante rimando dalla tensione politica all’attenzione filosofica che anima il pensiero di Deleuze, abbiamo deciso di immergerlo nel grande mare del trascendentale kantiano. Perché Kant? Nella visione deleuziana della storia della filosofia, fatta di alleati e di nemici, Kant occupa un ruolo anfibio, erede e prosecutore di gran parte degli elementi contro cui Deleuze dirige le sue critiche ma, al tempo stesso, avversario da cui imparare molto e da cui partire, o meglio fuggire, per costruire un altro pensiero trascendentale.
La questione trascendentale tra Kant e Deleuze
Per mostrare l’incessante rimando dalla tensione politica all’attenzione filosofica che anima il pensiero di Deleuze, abbiamo deciso di immergerlo nel grande mare del trascendentale kantiano. Perché Kant? Nella visione deleuziana della storia della filosofia, fatta di alleati e di nemici, Kant occupa un ruolo anfibio, erede e prosecutore di gran parte degli elementi contro cui Deleuze dirige le sue critiche ma, al tempo stesso, avversario da cui imparare molto e da cui partire, o meglio fuggire, per costruire un altro pensiero trascendentale.

1
La libertà impotente
L'engagement tragico di Jean-Paul Sartre
Non c’è dubbio che Sartre abbia plasmato a sua immagine il secolo in cui ha vissuto; che proiettando su di esso la sua ombra incombente lo abbia largamente dominato. Ma a quale prezzo? Ecco una domanda che sembra imporsi alla curiosità del critico, alla quale, tuttavia, di rado si è tentati di rispondere.
L'engagement tragico di Jean-Paul Sartre
Non c’è dubbio che Sartre abbia plasmato a sua immagine il secolo in cui ha vissuto; che proiettando su di esso la sua ombra incombente lo abbia largamente dominato. Ma a quale prezzo? Ecco una domanda che sembra imporsi alla curiosità del critico, alla quale, tuttavia, di rado si è tentati di rispondere.
Andreaus Michele, Università di Trento
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Processo di presentazione, valutazione ed accettazione dei contributi in volume (opere monografiche, raccolte e atti di convegno)
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
EVENTI
VIDEO
recensioni
approfondimenti

SINTESI
PUBBLICAZIONI
COLLANE COLLEGATE

Informativa
Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto









