
«I Libri» di Archivio Penale
L’Editore, d’intesa con i curatori della Rivista, ha voluto affiancare a quest’ultima una collana, che costituisce un’importante “costola” di questa stimolante iniziativa editoriale. L’importanza è dovuta ad una pluralità di fattori, o meglio, di interrogativi, a cui si cercherà in vario modo di rispondere attraverso «I Libri» di Archivio Penale. Si cercherà in primo luogo di comprendere le direzioni ove si vanno orientando il diritto ed il processo penale, in un’epoca in cui, tramontato ormai da tempo il “mito” di una nuova codificazione del diritto penale sostanziale, il codice di procedura penale del 1989 ha subìto ormai tante e tali modifiche, sia da parte della Corte costituzionale, che del legislatore, da perdere quella caratteristica originaria di un processo “tendenzialmente” accusatorio, per risolversi in un “ibrido”, ove rigurgiti di stampo chiaramente inquisitorio, soprattutto, ma non solo, sul terreno della criminalità organizzata, si alternano a “correzioni di rotta”, spesso timide, di matrice, invece, accusatoria. Sul versante del diritto penale sostanziale, il codice penale del lontano 1930 — tramontata, ormai, come accennato, la speranza che veda, almeno a breve, la luce un codice penale di stampo “democratico” — ormai più volte riformato, non solo nella parte generale, quanto, soprattutto, in quella speciale, sembra però sempre più assomigliare ai “centri storici” delle nostre antiche città, attorno ai quali è sorta, disordinatamente, una moltitudine di “leggi speciali”, dando luogo, sovente, a veri e propri “sottosistemi”, che caratterizzano, ormai da tempo, la c.d. “età della codificazione”, ove il limite più preoccupante è rappresentato dal fatto che sovente i “sottosistemi” non si conformano ai principi generali del sistema, soprattutto di ordine costituzionale. In questo “ginepraio” si muove un legislatore occupato, ormai da tempo, soprattutto di varare riforme “settoriali”, se non, addirittura, “singolari”, che indubbiamente complicano lo “stato dell’arte”, soprattutto sul versante della cronica “inefficienza” del sistema, anche perché non sono all’orizzonte reali e, in particolare, fattibili riforme di struttura. In questa situazione, in particolare le “monografie” tenteranno di fornire una risposta a questa sconfortante situazione, scandagliando ipiù diversi temi, con la necessaria ampiezza, sia del diritto penale che del diritto processuale penale, ormai da intendersi come “due facce di una stessa medaglia”, che anche, eventualmente, delle c.d. “scienze penalistiche integrate”.I settori riservati ai Saggi ed ai Materiali di esercitazione possiederanno, invece, o un orizzonte più limitato, oppure, attraverso la ricostruzione indicata, una prospettiva di analisi bensì approfondita epperò circoscritta al tema oggetto di didattica. Da ultimo, un’altra sezione verrà affidata agli Atti di Convegno, ove proprio la pluralità di voci nel coro dovrebbe contribuire a fornire una visione più variegata del nostro complesso ed incerto orizzonte.

22
Manipolazione psicologica e diritto penale
Le attuali tecniche di proselitismo politico e, soprattutto, religioso generano diffuse istanze incriminatrici volte a colmare il vuoto di tutela lasciato dalla sentenza di incostituzionalità del delitto di plagio, e a proteggere l’integrità psichica da condizionamenti illeciti eteroindotti, anche quando privi di dannosità sociale in quanto autorizzati da un consenso pieno e “competente” dell’avente diritto.
Le attuali tecniche di proselitismo politico e, soprattutto, religioso generano diffuse istanze incriminatrici volte a colmare il vuoto di tutela lasciato dalla sentenza di incostituzionalità del delitto di plagio, e a proteggere l’integrità psichica da condizionamenti illeciti eteroindotti, anche quando privi di dannosità sociale in quanto autorizzati da un consenso pieno e “competente” dell’avente diritto.

21
Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale
Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore
Onore e diritto penale hanno rappresentato tradizionalmente un binomio problematico. Sono noti i dibattiti sul concetto di onore come legittimo oggetto di tutela penale; e altrettanto noti sono i problemi originati dai rapporti di interferenza tra onore e libertà di manifestazione del pensiero.
Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore
Onore e diritto penale hanno rappresentato tradizionalmente un binomio problematico. Sono noti i dibattiti sul concetto di onore come legittimo oggetto di tutela penale; e altrettanto noti sono i problemi originati dai rapporti di interferenza tra onore e libertà di manifestazione del pensiero.

20
La minaccia
Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante
Per quanto il tema indagato sia classico, la prassi mostra non di rado incertezze interpretative sulla nozione penalmente rilevante di minaccia (da ultimo, ad es., in relazione ai rapporti tra concussione riformata e induzione indebita ex art. 319–quater c.p., ovvero a proposito della configurabilità dell’estorsione in caso di minaccia di esercitare un diritto, come nel noto caso Corona).
Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante
Per quanto il tema indagato sia classico, la prassi mostra non di rado incertezze interpretative sulla nozione penalmente rilevante di minaccia (da ultimo, ad es., in relazione ai rapporti tra concussione riformata e induzione indebita ex art. 319–quater c.p., ovvero a proposito della configurabilità dell’estorsione in caso di minaccia di esercitare un diritto, come nel noto caso Corona).

19
Il delitto di atti persecutori
La fattispecie di atti persecutori (c.d. stalking) ha avuto ingresso nel nostro sistema penale solo in tempi relativamente recenti, nel 2009, attraverso l’innesto nel codice dell’art. 612-bis. Con ciò il legislatore italiano si è finalmente allineato a una tendenza di politica criminale già emersa da tempo nei sistemi giuridici dei Paesi più evoluti.
La fattispecie di atti persecutori (c.d. stalking) ha avuto ingresso nel nostro sistema penale solo in tempi relativamente recenti, nel 2009, attraverso l’innesto nel codice dell’art. 612-bis. Con ciò il legislatore italiano si è finalmente allineato a una tendenza di politica criminale già emersa da tempo nei sistemi giuridici dei Paesi più evoluti.

18
I confini dell’indagine personologica nel processo penale
Il giudizio “tecnico” sulla personalità dell’imputato nel processo penale può rilevare a diversi fini che vanno dalla necessità di comprendere la dinamica dell’evento criminoso, all’esigenza di commisurare la sanzione penale ai sensi dell’art. 133 c.p. o valutare la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza, al bisogno di realizzare un trattamento penitenziario individualizzato ed in funzione rieducativa della pena.
Il giudizio “tecnico” sulla personalità dell’imputato nel processo penale può rilevare a diversi fini che vanno dalla necessità di comprendere la dinamica dell’evento criminoso, all’esigenza di commisurare la sanzione penale ai sensi dell’art. 133 c.p. o valutare la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza, al bisogno di realizzare un trattamento penitenziario individualizzato ed in funzione rieducativa della pena.

17
Le regole di esclusione della prova nel processo penale
Questo studio vuole preliminarmente delineare le dovute differenziazioni tra le prescrizioni limitative che devono guidare il giudice nell’opera di ricostruzione del fatto sulla sussistenza del quale è tenuto a decidere, allo scopo di bandire le solo apparenti commistioni tra regole che presentano tratti distintivi soprattutto a livello operativo, stante la loro reale capacità di determinare i differenti effetti per i quali sono state poste.
Questo studio vuole preliminarmente delineare le dovute differenziazioni tra le prescrizioni limitative che devono guidare il giudice nell’opera di ricostruzione del fatto sulla sussistenza del quale è tenuto a decidere, allo scopo di bandire le solo apparenti commistioni tra regole che presentano tratti distintivi soprattutto a livello operativo, stante la loro reale capacità di determinare i differenti effetti per i quali sono state poste.

16
Il mare con il cucchiaino
Vademecum per la repressione penale della bancarotta fraudolenta
In un'epoca segnata da una perdurante crisi economica, in cui la bancarotta fraudolenta, da episodio unico e traumatico nella vita dell'impresa, diventa reato seriale e funzionale a sofisticate strategie illecite, la magistratura e le forze dell'ordine si scoprono sottodimensionate e quasi impotenti di fronte alla massa dei fallimenti e dei delitti a essi sottesi.
Vademecum per la repressione penale della bancarotta fraudolenta
In un'epoca segnata da una perdurante crisi economica, in cui la bancarotta fraudolenta, da episodio unico e traumatico nella vita dell'impresa, diventa reato seriale e funzionale a sofisticate strategie illecite, la magistratura e le forze dell'ordine si scoprono sottodimensionate e quasi impotenti di fronte alla massa dei fallimenti e dei delitti a essi sottesi.

15
Le “regole dell’incoerenza”
Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale
L’incoerenza costituisce per il diritto penale un fattore di delegittimazione e per il pluralismo giuridico il presupposto della sua esistenza. I sistemi pluralistici sono, infatti, per definizione quegli spazi in cui si registrano conflitti tra norme, per un verso giuridicamente rilevanti e, per altro verso, non risolvibili. L’uso della pena in questa dimensione avviene, perciò, in un contesto normativo in cui l’incoerenza è, al tempo stesso, patologica e fisiologica.
Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale
L’incoerenza costituisce per il diritto penale un fattore di delegittimazione e per il pluralismo giuridico il presupposto della sua esistenza. I sistemi pluralistici sono, infatti, per definizione quegli spazi in cui si registrano conflitti tra norme, per un verso giuridicamente rilevanti e, per altro verso, non risolvibili. L’uso della pena in questa dimensione avviene, perciò, in un contesto normativo in cui l’incoerenza è, al tempo stesso, patologica e fisiologica.

14
Le misure interdittive nei confronti delle persone giuridiche nella prospettiva europea
La responsabilità da reato delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 trae fondamento dall’ordinamento sovranazionale. L’esigenza di una normativa di natura repressiva specificamente riservata alle persone giuridiche nasce e si diffonde, infatti, nel sistema giuridico europeo soprattutto ai fini della tutela del sistema concorrenziale delle imprese e, più in generale, degli enti a fronte di un mercato ormai transnazionale.
La responsabilità da reato delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 trae fondamento dall’ordinamento sovranazionale. L’esigenza di una normativa di natura repressiva specificamente riservata alle persone giuridiche nasce e si diffonde, infatti, nel sistema giuridico europeo soprattutto ai fini della tutela del sistema concorrenziale delle imprese e, più in generale, degli enti a fronte di un mercato ormai transnazionale.

13
Contributo allo studio del falso in prospetto
Il lavoro parte dall’esame della definizione di “prospetto informativo” fornita dall’art.94 del Testo Unico della Finanza e delle diverse modalità di realizzazione della sollecitazione del pubblico risparmio per giungere allo studio della fattispecie di “falso in prospetto” di cui all’art.173-bis del TUF.
Il lavoro parte dall’esame della definizione di “prospetto informativo” fornita dall’art.94 del Testo Unico della Finanza e delle diverse modalità di realizzazione della sollecitazione del pubblico risparmio per giungere allo studio della fattispecie di “falso in prospetto” di cui all’art.173-bis del TUF.

12
Il fascio d’ortiche e la monade infranta
Conformità al tipo e offensività della condotta nella sistematica dei reati di falso
Tradizionalmente ritenuta un “fascio d’ortiche” o “la vera Sfinge del diritto penale”, la materia dei reati di falso fornisce interessanti spunti per affrontare la problematica dei fatti inoffensivi apparentemente conformi al tipo, rispetto ai quali la “monade” tipicità-offesa sembra sgretolarsi.
Conformità al tipo e offensività della condotta nella sistematica dei reati di falso
Tradizionalmente ritenuta un “fascio d’ortiche” o “la vera Sfinge del diritto penale”, la materia dei reati di falso fornisce interessanti spunti per affrontare la problematica dei fatti inoffensivi apparentemente conformi al tipo, rispetto ai quali la “monade” tipicità-offesa sembra sgretolarsi.

11
Esiguità ed irrilevanza nella concezione gradualistica del reato
Il presente lavoro affronta i temi della esiguità e della irrilevanza nella concezione gradualistica del reato. Il reato, inteso come una “costruzione a gradi”, rimane soggetto a graduazione sia in senso qualitativo che quantitativo, al pari di ogni elemento da cui è composto. Il volume affronta tale graduazione, soffermandosi, in particolare, sulla soglia di minima rilevanza del fatto ( c.d. esiguità ) e di ogni elemento costitutivo del reato.
Il presente lavoro affronta i temi della esiguità e della irrilevanza nella concezione gradualistica del reato. Il reato, inteso come una “costruzione a gradi”, rimane soggetto a graduazione sia in senso qualitativo che quantitativo, al pari di ogni elemento da cui è composto. Il volume affronta tale graduazione, soffermandosi, in particolare, sulla soglia di minima rilevanza del fatto ( c.d. esiguità ) e di ogni elemento costitutivo del reato.

10
La tutela penale dei finanziamenti pubblici all’economia
Il presente lavoro monografico ha ad oggetto principalmente il delitto di malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p., introdotto dall’art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86.
Il presente lavoro monografico ha ad oggetto principalmente il delitto di malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p., introdotto dall’art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86.

9
Sul limite
Testamento biologico e decisioni di fine vita
Dopo gli eclatanti casi giudiziari e un massiccio intervento della giurisprudenza, il tema delle decisioni in situazioni sul limite tra la vita e la morte, rinnovato nei termini e nel lessico, pone all’interprete immediate soluzioni e questioni ancora tutte da risolvere. Una di queste è costituita dal testamento biologico e dalle direttive anticipate di trattamento.
Testamento biologico e decisioni di fine vita
Dopo gli eclatanti casi giudiziari e un massiccio intervento della giurisprudenza, il tema delle decisioni in situazioni sul limite tra la vita e la morte, rinnovato nei termini e nel lessico, pone all’interprete immediate soluzioni e questioni ancora tutte da risolvere. Una di queste è costituita dal testamento biologico e dalle direttive anticipate di trattamento.
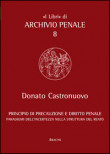
8
Principio di precauzione e diritto penale
Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato
L’Autore – all’esito di un’inedita indagine sui differenziati modelli di decisione giudiziale improntati alla logica precauzionale – esamina i diversi livelli di incoerenza logica tra le categorie “classiche” del reato e il principio di precauzione, allo scopo di tratteggiarne, alla luce dei canoni garantistici, le possibilità e i limiti di integrazione nelle dinamiche della responsabilità penale.
Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato
L’Autore – all’esito di un’inedita indagine sui differenziati modelli di decisione giudiziale improntati alla logica precauzionale – esamina i diversi livelli di incoerenza logica tra le categorie “classiche” del reato e il principio di precauzione, allo scopo di tratteggiarne, alla luce dei canoni garantistici, le possibilità e i limiti di integrazione nelle dinamiche della responsabilità penale.

7
La prova penale e la sua valutazione
Nelle pagine del lavoro si cerca di fondare razionalmente questa convinzione, fornendo della stessa alcune esemplificazioni e supportandola con una riflessione teorica.
Nelle pagine del lavoro si cerca di fondare razionalmente questa convinzione, fornendo della stessa alcune esemplificazioni e supportandola con una riflessione teorica.

6
L’argomentazione giudiziale e il suo controllo in cassazione
Unione Camere Penali. Atti del convegno, Lipari 10 settembre 2011
Il volume costituisce un contributo a più voci sul tema della logica nel processo penale e del suo controllo nel giudizio di cassazione. Dagli spunti forniti in occasione del Convegno di Lipari del 10 settembre 2011, è nato il presente quaderno che, alla luce della qualità e dell’approfondimento del lavoro di rielaborazione dei testi realizzato dagli autori (avvocati, magistrati, professori universitari e filosofi), contiene una esaustiva ricognizione sulla materia.
Unione Camere Penali. Atti del convegno, Lipari 10 settembre 2011
Il volume costituisce un contributo a più voci sul tema della logica nel processo penale e del suo controllo nel giudizio di cassazione. Dagli spunti forniti in occasione del Convegno di Lipari del 10 settembre 2011, è nato il presente quaderno che, alla luce della qualità e dell’approfondimento del lavoro di rielaborazione dei testi realizzato dagli autori (avvocati, magistrati, professori universitari e filosofi), contiene una esaustiva ricognizione sulla materia.

5
Merci illecite e contraffatte: sequestro e distruzione
Tra prassi operative e garanzie europee
Atti del seminario al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Roma, 27 settembre 2011
Tra prassi operative e garanzie europee
Atti del seminario al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Roma, 27 settembre 2011

4
La tutela della vittima e le garanzie dell’imputato
La più recente normativa dell’Unione europea
Il presente volume analizza le nuove proposte di direttiva dell’Unione europea per rafforzare i diritti delle vittime di reato, con particolare riferimento alla proposta di direttiva COM (2011) 275 che detta le norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato, valutandone il prevedibile impatto sull’ordinamento dello Stato.
La più recente normativa dell’Unione europea
Il presente volume analizza le nuove proposte di direttiva dell’Unione europea per rafforzare i diritti delle vittime di reato, con particolare riferimento alla proposta di direttiva COM (2011) 275 che detta le norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato, valutandone il prevedibile impatto sull’ordinamento dello Stato.

3
Riservatezza ed intercettazioni tra norma e prassi
Questo case-book, destinato alla didattica, raccoglie una serie di contributi, alcuni nuovi e alcuni già editi in un passato recente, a documento dell’evolversi continuo delle problematiche, perennemente attuali e sempre irrisolte, innescate dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e dei diritti di riservatezza (delle persone captate) e di difesa (degli imputati) a queste connessi.
Questo case-book, destinato alla didattica, raccoglie una serie di contributi, alcuni nuovi e alcuni già editi in un passato recente, a documento dell’evolversi continuo delle problematiche, perennemente attuali e sempre irrisolte, innescate dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e dei diritti di riservatezza (delle persone captate) e di difesa (degli imputati) a queste connessi.

2
Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio
Nella incessante mutevolezza che connota gli assetti normativi del processo penale vigente, l’analisi delle ricadute sistematiche – a più di cinque anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento – della regola di giudizio sulla colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio offre una prospettiva di dibattito tuttora attuale per una riflessione di ampio respiro sulle profonde trasformazioni in atto del modello processuale del codice di rito penale del 1989.
Nella incessante mutevolezza che connota gli assetti normativi del processo penale vigente, l’analisi delle ricadute sistematiche – a più di cinque anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento – della regola di giudizio sulla colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio offre una prospettiva di dibattito tuttora attuale per una riflessione di ampio respiro sulle profonde trasformazioni in atto del modello processuale del codice di rito penale del 1989.

1
I princìpi del diritto penale nella dottrina di Giuliano Vassalli
Attraverso la rilettura dei numerosi scritti che Vassalli ha dedicato alla disamina dei princìpi fondamentali dell’ordinamento penale (principio di legalità, colpevolezza, offensività, polifunzionalità della pena), questo saggio ricostruisce, in maniera puntuale ed organica, il quadro di una dottrina illuminante che ha sancito l’evoluzione della scienza giuridica.
Attraverso la rilettura dei numerosi scritti che Vassalli ha dedicato alla disamina dei princìpi fondamentali dell’ordinamento penale (principio di legalità, colpevolezza, offensività, polifunzionalità della pena), questo saggio ricostruisce, in maniera puntuale ed organica, il quadro di una dottrina illuminante che ha sancito l’evoluzione della scienza giuridica.
Andreaus Michele, Università di Trento
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Processo di presentazione, valutazione ed accettazione dei contributi in volume (opere monografiche, raccolte e atti di convegno)
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
EVENTI
VIDEO
recensioni
approfondimenti

SINTESI
PUBBLICAZIONI
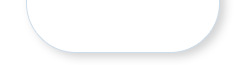
Informativa
Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto








