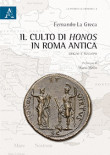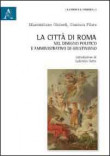La vicenda storica di Roma si snoda per mille anni in occidente e per altri mille prosegue nel mondo bizantino, i cui ordinamenti e il cui impianto sociopolitico riproducono nel tempo, in perfetta coerenza, il modello di stato costantiniano. Siamo di fronte cioè all'esperienza politica più longeva della storia, che attraverso periodici ed epocali mutamenti di assetto istituzionale (dalla monarchia alla repubblica, dal principato/repubblica imperiale all'impero tardoantico) mantiene saldo il principio della continuità, sostanziale e simbolica, con la Roma del quadrato palatino romuleo. È evidente che una simile realtà ha influito, e per molti versi continua a influire, sulla storia del mondo occidentale ben oltre i limiti cronologici della sua sopravvivenza politica autonoma: per questo, di là dall'enfasi letteraria, appare ancora valido il giudizio di Henry de Montherlant, nella Postilla alla sua opera teatrale La guerra civile: «I Romani hanno spiegato con la loro vita un largo ventaglio, che va dall'arte di godere all'arte di morire: al centro, tra le due, il coraggio, la gravità, l'infamia e la tristezza. Per questo, la loro storia è il microcosmo di tutta la Storia; chi conosce bene la storia romana, non ha bisogno di conoscere la storia del mondo; tutto quello che è opus romanum è opus humanum, tutto ciò che è opera romana è opera umana». Di qui, crediamo, l'utilità di una nuova collana di studi di Storia Romana, aperta al contributo sia di studiosi affermati sia di giovani e capaci ricercatori, che soprattutto indaghi le dinamiche del potere che hanno consentito allo stato romano, fin dalle origini multietnico e multiculturale, di percorrere la lunga durata del suo successo storico; che analizzi quei meccanismi di integrazione e assimilazione, di acquisizione del consenso, di esercizio di potere morbido, di riconoscimento della doppia cittadinanza, che sono la chiave dell'efficacia del processo di romanizzazione; che estenda il proprio interesse alla persistenza come riferimento costante nel tempo del modello ideologico/politico della repubblica imperiale romana, dal medioevo all'età contemporanea, in una ricezione che spesso si è trasformata sia in tentativo di riproduzione in falsariga del modello (si pensi, ad es., alla relazione fra la fondazione degli Stati Uniti d'America e l'icona della repubblica romana) sia in termine di confronto politologico, storico e storiografico per la teoria degli imperi (si pensi alla ricchissima letteratura su analogia/differenze fra l'impero di Roma e gli imperi coloniali, l'impero britannico o l'"impero" americano).
6
Palmira: dinamiche politico-economiche e fenomeni culturali nei primi tre secoli dell’Impero
Città tornata recentemente alla ribalta delle cronache, per via delle distruzioni perpetrate dall’Isis, Palmira rivive nel volume i fasti della sua storia millenaria, specificamente durante l’apogeo che l’ha interessata a cavallo fra il II e il III secolo dell’era cristiana. La monografia consegna al lettore un’immagine completa di questo periodo, focalizzandosi sia sugli aspetti economici, politici e giuridici, sia su quelli letterari, religiosi e culturali.
5
Latrocinium maris
Fenomenologia e repressione della pirateria nell’esperienza romana e oltre
Percepita e rappresentata come una minaccia dilagante e inarrestabile a partire dall’età repubblicana fino a quella tardo-imperiale, la pirateria assunse in ambito romano un ruolo tutt’altro che marginale, già ampiamente indagato dalla storiografia moderna.
4
Il culto di Honos in Roma antica
Origini e sviluppo
Il volume propone uno studio unitario del culto di Honos nell’antica Roma, nel suo svolgimento storico, insieme alla gemella Virtus. Divinità soprattutto civile, Honos si rivela, attraverso le fonti, « il dio che concede l’onore », ossia le magistrature.
3
Ammiano Marcellino, XXVIII e XXIX
Problemi storici e storiografici
Dopo un’introduzione sulla vita e il metodo di lavoro di Ammiano, tre capitoli analizzano i problemi del suo rapporto con l’antica capitale dell’impero, le iniziative diplomatiche e militari di Valentiniano I per la difesa della frontiera settentrionale, una valutazione complessiva dell’imperatore. Il giudizio di Ammiano risulta solo parzialmente condizionato dai sentimenti dell’aristocrazia senatoria.
2
La città di Roma nel disegno politico e amministrativo di Giustiniano
“Il volume di Massimiliano Ghilardi e Gianluca Pilara ripercorre le fasi di un contesto urbano e politico particolare ed interessante per Roma sotto vari aspetti. L’Urbe, infatti, nel sesto secolo ha conosciuto diversi mutamenti sotto i più distinti profili, storici sociali culturali giuridici, offrendo a tutti gli studiosi interessati a tali questioni un panorama ricco di informazioni utili ad approfondimenti e a ricerche di diversa natura.”(Dall’Introduzione di Ludovico Gatto)
1
Le segrete stanze del potere
I comites consistoriani e l'imperatore tardoantico
Questo volume intende restituire i comites consistoriani alla loro corretta dimensione storica e politica, privilegiando la prospettiva che più esemplifica la loro originalità rispetto a gruppi politici tradizionali: il loro reclutamento ed eventuali discriminanti ad esso sottese.
Andreaus Michele, Università di Trento
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Processo di presentazione, valutazione ed accettazione dei contributi in volume (opere monografiche, raccolte e atti di convegno)
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
recensioni
approfondimenti