
Orientamenti di Strasburgo

27
Liberalizzazioni e diritti fondamentali
Il testo, partendo dall’esame della giurisprudenza della CEDU, della Corte di Giustizia e delle nostre Corti nazionali in tema di rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e liberalizzazioni giunge alla conclusione che una politica di liberalizzazioni non debba andare necessariamente a scapito dei diritti fondamentali...
Il testo, partendo dall’esame della giurisprudenza della CEDU, della Corte di Giustizia e delle nostre Corti nazionali in tema di rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e liberalizzazioni giunge alla conclusione che una politica di liberalizzazioni non debba andare necessariamente a scapito dei diritti fondamentali...

26
Il diritto di asilo
I presupposti e le garanzie procedurali
Il diritto di asilo ha assunto negli ultimi tempi una crescente importanza a seguito di numerosi interventi del legislatore comunitario e di rilevanti pronunzie delle Corti europee. Il presente lavoro intende offrire al lettore una rapida e al contempo esaustiva disamina dei principali istituti della protezione internazionale, riguardati alla luce della più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria.
I presupposti e le garanzie procedurali
Il diritto di asilo ha assunto negli ultimi tempi una crescente importanza a seguito di numerosi interventi del legislatore comunitario e di rilevanti pronunzie delle Corti europee. Il presente lavoro intende offrire al lettore una rapida e al contempo esaustiva disamina dei principali istituti della protezione internazionale, riguardati alla luce della più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria.

25
L’esecuzione delle sentenze della CEDU
Il testo esamina le problematiche dell’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, quale momento cruciale dell’attuazione della tutela convenzionale, soffermandosi sui soggetti della fase di esecuzione e sulla relativa procedura nei suoi vari momenti dell’esecuzione ed esaminando le questioni più ricorrenti nella prassi (in particolare, in relazione ai problemi delle controversie c.d. Pinto e di quelle c.d. Torreggiani).
Il testo esamina le problematiche dell’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, quale momento cruciale dell’attuazione della tutela convenzionale, soffermandosi sui soggetti della fase di esecuzione e sulla relativa procedura nei suoi vari momenti dell’esecuzione ed esaminando le questioni più ricorrenti nella prassi (in particolare, in relazione ai problemi delle controversie c.d. Pinto e di quelle c.d. Torreggiani).

24
Human Rights Obligations of States in the Context of Counter-Terrorism Operations
A Commentary in the Light of Al Nashiri vs Poland and Husayn (Abu Zubaydah) vs Poland
The article discusses state obligations in the context of counter-terrorism operations, with particular focus on the human rights obligations of third states offering assistance in counter-terrorism operations, in the light of the recent judgments rendered by the European Court of Human Rights in the cases of Al Nashiri and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland.
A Commentary in the Light of Al Nashiri vs Poland and Husayn (Abu Zubaydah) vs Poland
The article discusses state obligations in the context of counter-terrorism operations, with particular focus on the human rights obligations of third states offering assistance in counter-terrorism operations, in the light of the recent judgments rendered by the European Court of Human Rights in the cases of Al Nashiri and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland.

23
Limiti alla retroattività della legge civile
Il testo riprende ed integra la Relazione svolta presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione il 29 ottobre 2014 nel Convegno organizzato dalla Formazione decentrata della Suprema Corte su “Le questioni aperte nei rapporti tra le Corti Supreme nazionali e le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo”.
Il testo riprende ed integra la Relazione svolta presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione il 29 ottobre 2014 nel Convegno organizzato dalla Formazione decentrata della Suprema Corte su “Le questioni aperte nei rapporti tra le Corti Supreme nazionali e le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo”.

22
Procreazione assistita
Il testo esamina in modo analitico e compiuto la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di procreazione assistita.
Il testo esamina in modo analitico e compiuto la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di procreazione assistita.

21
I diritti delle persone LGBT
Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Il presente contributo offre un’esaustiva rassegna della giurisprudenza della Corte EDU concernente le tematiche legate all’identità di genere e alle discriminazioni in relazione all’orientamento sessuale. L’analisi dei casi mette in luce la profonda trasformazione nell’approccio giuridico, ma anche sociologico, alle istanze della comunità LGBT avvenuta negli ultimi decenni.
Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Il presente contributo offre un’esaustiva rassegna della giurisprudenza della Corte EDU concernente le tematiche legate all’identità di genere e alle discriminazioni in relazione all’orientamento sessuale. L’analisi dei casi mette in luce la profonda trasformazione nell’approccio giuridico, ma anche sociologico, alle istanze della comunità LGBT avvenuta negli ultimi decenni.

20
Lo statuto dei diritti fondamentali del contribuente europeo tra austerity, pareggio di bilancio e garanzie di indipendenza della giurisdizione tributaria italiana
La crisi economica e le controverse politiche di austerity corrono il rischio di chiudere in una pericolosa morsa i diritti fondamentali dei cittadini, quali fruitori dei servizi essenziali, da un lato, e contribuenti dall’altro. È pertanto necessario far adeguatamente salire la soglia di attenzione quanto alle modalità di progettazione e attuazione del diritto finanziario.
La crisi economica e le controverse politiche di austerity corrono il rischio di chiudere in una pericolosa morsa i diritti fondamentali dei cittadini, quali fruitori dei servizi essenziali, da un lato, e contribuenti dall’altro. È pertanto necessario far adeguatamente salire la soglia di attenzione quanto alle modalità di progettazione e attuazione del diritto finanziario.

19
Echr article 10: how does the protection work
Article 10 of the Convention of Human Rights plays a major role in protecting Freedom of Expression in the framework of the Member States of the Council of Europe.
Article 10 of the Convention of Human Rights plays a major role in protecting Freedom of Expression in the framework of the Member States of the Council of Europe.

18
La CEDU e le discriminazioni di genere
Il testo esamina la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di discriminazione delle donne ed analizza la posizione dei giudici donne in seno alla Corte e nel contesto dei giudici europei. Lo studio riproduce la relazione tenuta al convegno nazionale “Donne in magistratura 1963-2013…50 anni dopo”, organizzato dall’Associazione nazionale magistrati in Roma il 27 settembre 2013.
Il testo esamina la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di discriminazione delle donne ed analizza la posizione dei giudici donne in seno alla Corte e nel contesto dei giudici europei. Lo studio riproduce la relazione tenuta al convegno nazionale “Donne in magistratura 1963-2013…50 anni dopo”, organizzato dall’Associazione nazionale magistrati in Roma il 27 settembre 2013.

17
Tutela civile dei diritti umani e ragion di stato
È possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un atto che lo Stato compia nell’esercizio della politica estera o nella conduzione di operazioni militari? Quali sono gli ostacoli che si frappongono a tale risultato? Dove sono i limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti e, specularmente, alla Ragion di Stato?
Muovendo dalla rilettura del caso Markovic ed altri c. Italia, l’opera aspira ad abbozzare una risposta a tali scottanti interrogativi.
È possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un atto che lo Stato compia nell’esercizio della politica estera o nella conduzione di operazioni militari? Quali sono gli ostacoli che si frappongono a tale risultato? Dove sono i limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti e, specularmente, alla Ragion di Stato?
Muovendo dalla rilettura del caso Markovic ed altri c. Italia, l’opera aspira ad abbozzare una risposta a tali scottanti interrogativi.

16
Previdenza ed assistenza sociale
Nella giurisprudenza CEDU
Il testo esamina la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di previdenza ed assistenza sociale, analizzando le tutele dei singoli in relazione alle varie prestazioni di sicurezza sociale, sia con riferimento alla loro attribuzione, sia in relazione alla loro misura, e soffermandosi su alcuni casi di dialogo difficile tra le corti nazionali e la corte di Strasburgo.
Nella giurisprudenza CEDU
Il testo esamina la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di previdenza ed assistenza sociale, analizzando le tutele dei singoli in relazione alle varie prestazioni di sicurezza sociale, sia con riferimento alla loro attribuzione, sia in relazione alla loro misura, e soffermandosi su alcuni casi di dialogo difficile tra le corti nazionali e la corte di Strasburgo.

15
Diritto comparato e dottrina del margine di apprezzamento nella CEDU
Partendo dalle analisi di diritto comparato, e dalla nozione di “consensus” nell'ambito dei diritti umani c.d. non inderogabili, i giudici di Strasburgo hanno elaborato la importante dottrina del “margine di apprezzamento”. La sua applicazione non sempre uniforme e in recente evoluzione, mira ad evitare da un lato l’appiattimento della Corte sul “consensus” in funzione anti-maggioritaria e, dall'altro, il rischio di consentire standard diversi tra Stati membri nella protezione dei diritti umani.
Partendo dalle analisi di diritto comparato, e dalla nozione di “consensus” nell'ambito dei diritti umani c.d. non inderogabili, i giudici di Strasburgo hanno elaborato la importante dottrina del “margine di apprezzamento”. La sua applicazione non sempre uniforme e in recente evoluzione, mira ad evitare da un lato l’appiattimento della Corte sul “consensus” in funzione anti-maggioritaria e, dall'altro, il rischio di consentire standard diversi tra Stati membri nella protezione dei diritti umani.

14
Questioni di diritto del lavoro
Nella giurisprudenza CEDU
Nonostante siano poche le norme che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo dedica alla materia del lavoro, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha esaminato varie questioni di diritto del lavoro, sia soffermandosi sia sulle nuove forme di lavoro forzato, sia ampliando le tutele dei diritti dei lavoratori offerte dalle legislazioni nazionali, confermando la natura della Convenzione quale “living instrument” che vincola gli Stati aderenti.
Nella giurisprudenza CEDU
Nonostante siano poche le norme che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo dedica alla materia del lavoro, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha esaminato varie questioni di diritto del lavoro, sia soffermandosi sia sulle nuove forme di lavoro forzato, sia ampliando le tutele dei diritti dei lavoratori offerte dalle legislazioni nazionali, confermando la natura della Convenzione quale “living instrument” che vincola gli Stati aderenti.

13
Agente provocatore ed operazioni sotto copertura
Tra diritto interno e giurisprudenza CEDU
Il lavoro consiste in una riflessione critica su alcuni dei principali aspetti problematici che si pongono all’attenzione dell’interprete in tema di indagini sotto copertura e di testimonianza anonima. Alla luce dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo si avrà modo di rilevare come, ancora una volta, il nostro legislatore sembra aver previsto garanzie minime inferiori rispetto a quelle richieste dalla Convenzione europea.
Tra diritto interno e giurisprudenza CEDU
Il lavoro consiste in una riflessione critica su alcuni dei principali aspetti problematici che si pongono all’attenzione dell’interprete in tema di indagini sotto copertura e di testimonianza anonima. Alla luce dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo si avrà modo di rilevare come, ancora una volta, il nostro legislatore sembra aver previsto garanzie minime inferiori rispetto a quelle richieste dalla Convenzione europea.

12
Libertà e diritti sindacali
Nella giurisprudenza CEDU
Il testo esamina la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di diritto sindacale, analizzando le libertà sindacali, la tutela dei dirigenti sindacali, la contrattazione collettiva, anche aziendale, e lo sciopero.
Nella giurisprudenza CEDU
Il testo esamina la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di diritto sindacale, analizzando le libertà sindacali, la tutela dei dirigenti sindacali, la contrattazione collettiva, anche aziendale, e lo sciopero.

11
Gli schiavi di ieri e di oggi
La schiavitù è esistita per secoli e per un lungo tempo è stata anche giuridicamente consentita. Oggi, nonostante le proibizioni legali del diritto, se ne registrano ancora numerosi casi. Il testo offre spunti sulla condizione dello schiavo nell'antichità (nel diritto romano, ma anche nella letteratura antica ed in particolare nella poesia di Orazio) e sul fenomeno della schiavitù dei nostri giorni, per come emerso nella giurisprudenza di legittimità nazionale e in quella della CEDU.
La schiavitù è esistita per secoli e per un lungo tempo è stata anche giuridicamente consentita. Oggi, nonostante le proibizioni legali del diritto, se ne registrano ancora numerosi casi. Il testo offre spunti sulla condizione dello schiavo nell'antichità (nel diritto romano, ma anche nella letteratura antica ed in particolare nella poesia di Orazio) e sul fenomeno della schiavitù dei nostri giorni, per come emerso nella giurisprudenza di legittimità nazionale e in quella della CEDU.

11
Processo equo e terzietà del giudice
Il problema dell'autodichia
Indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice sono tre aspetti diversi posti a fondamento del principio del processo equo garantito dalla CEDU e dalla Costituzione italiana. Il testo ne esamina i caratteri alla luce della giurisprudenza CEDU sul diritto al processo equo e della giurisprudenza nazionale sui rimedi processuali ai vizi relativi al giudice, soffermandosi sull'istituto della ricusazione ed esaminando il problema della legittimità dell'autodichia.
Il problema dell'autodichia
Indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice sono tre aspetti diversi posti a fondamento del principio del processo equo garantito dalla CEDU e dalla Costituzione italiana. Il testo ne esamina i caratteri alla luce della giurisprudenza CEDU sul diritto al processo equo e della giurisprudenza nazionale sui rimedi processuali ai vizi relativi al giudice, soffermandosi sull'istituto della ricusazione ed esaminando il problema della legittimità dell'autodichia.

10
Stranieri invalidi
Il testo esamina le problematiche giuridiche relative alla concessione agli stranieri, ed in particolare agli extracomunitari, delle prestazioni di assistenza sociale previste per l'invalidità civile e le minorazioni, soffermandosi in particolare sulla rilevanza della durata della permanenza dello straniero in Italia ai fini della attribuzione delle dette prestazioni.
Il testo esamina le problematiche giuridiche relative alla concessione agli stranieri, ed in particolare agli extracomunitari, delle prestazioni di assistenza sociale previste per l'invalidità civile e le minorazioni, soffermandosi in particolare sulla rilevanza della durata della permanenza dello straniero in Italia ai fini della attribuzione delle dette prestazioni.

9
Procedimento e processo amministrativo alla luce dell’art. 6 CEDU
Il presente lavoro esamina i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo in tema di applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e valuta se il procedimento ed il processo amministrativo italiani siano con essi compatibili.
Particolare attenzione è riservata ai procedimenti amministrativi che incidono su diritti ed obbligazioni di “carattere civile” ed alle sanzioni inflitte dalla pubblica autorità.
Il presente lavoro esamina i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo in tema di applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e valuta se il procedimento ed il processo amministrativo italiani siano con essi compatibili.
Particolare attenzione è riservata ai procedimenti amministrativi che incidono su diritti ed obbligazioni di “carattere civile” ed alle sanzioni inflitte dalla pubblica autorità.

8
Processo equo e terzietà del giudice
Il problema dell'autodichia
Indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice sono tre aspetti diversi posti a fondamento del principio del processo equo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione italiana. Il testo ne esamina i caratteri alla luce della giurisprudenza CEDU sul diritto al processo equo e della giurisprudenza nazionale sui rimedi processuali ai vizi relativi al giudice.
Il problema dell'autodichia
Indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice sono tre aspetti diversi posti a fondamento del principio del processo equo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione italiana. Il testo ne esamina i caratteri alla luce della giurisprudenza CEDU sul diritto al processo equo e della giurisprudenza nazionale sui rimedi processuali ai vizi relativi al giudice.

7
Human rights in cinema
A guide in search of justice and inspiration
The publication explores the topic of human rights in cinema. Presenting its history and modernity as well as infrastructure as a movement, it also looks at form and content of human rights films.
A guide in search of justice and inspiration
The publication explores the topic of human rights in cinema. Presenting its history and modernity as well as infrastructure as a movement, it also looks at form and content of human rights films.

6
Formalismo ed accesso alla giustizia
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso una giurisprudenza, ancora poco conosciuta, che ha censurato le applicazioni delle norme nazionali processuali, operate sulla base di interpretazioni formalistiche delle norme o di principi incerti, che hanno comunque l'effetto di comprimere il diritto di accesso alla giustizia.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso una giurisprudenza, ancora poco conosciuta, che ha censurato le applicazioni delle norme nazionali processuali, operate sulla base di interpretazioni formalistiche delle norme o di principi incerti, che hanno comunque l'effetto di comprimere il diritto di accesso alla giustizia.

5
Evoluzione della CEDU e analisi di diritto comparato
La Convenzione EDU ha conosciuto una significativa evoluzione negli ultimi anni, per far fronte ad un accresciuto carico di lavoro, frutto anche dell'allargamento ad est a nuovi Stati contraenti. Simili sfide hanno comportato modifiche normative, riorganizzazioni interne e nei meccanismi di protezione dei diritti umani, di cui una parte significativa è costituita dalla preparazione di analisi di diritto comparato su questioni comuni ai 47 Stati membri.
La Convenzione EDU ha conosciuto una significativa evoluzione negli ultimi anni, per far fronte ad un accresciuto carico di lavoro, frutto anche dell'allargamento ad est a nuovi Stati contraenti. Simili sfide hanno comportato modifiche normative, riorganizzazioni interne e nei meccanismi di protezione dei diritti umani, di cui una parte significativa è costituita dalla preparazione di analisi di diritto comparato su questioni comuni ai 47 Stati membri.
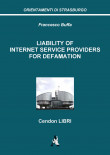
4
Liability of internet service providers for defamation
This ebook analyses some juridical problems in the matter of freedom of expression and liability, dealing with the position of the Internet services providers, their powers to filter and block illegal data, and their duties to cooperate with public Authorities to detect and reveal on-line criminals.
This ebook analyses some juridical problems in the matter of freedom of expression and liability, dealing with the position of the Internet services providers, their powers to filter and block illegal data, and their duties to cooperate with public Authorities to detect and reveal on-line criminals.

3
Le travail des détenus
Bref commentaire sur l’affaire Stummer c. Autriche
Ce petit livre étudie le cas d'un détenu qui a travaillé en prison et n’a pas été affilié au régime des pensions de retraite pendant ses années d’incarcération. Il s'est plaint avant la CEDH d’avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de sa condition de détenu et d'avoir été privé d’une pension.
Le texte examine les questions tranchées par l'arrêt de la Cour, et se développe jusque à des réflexions sur la protection des droits fondamentaux des détenus.
Bref commentaire sur l’affaire Stummer c. Autriche
Ce petit livre étudie le cas d'un détenu qui a travaillé en prison et n’a pas été affilié au régime des pensions de retraite pendant ses années d’incarcération. Il s'est plaint avant la CEDH d’avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de sa condition de détenu et d'avoir été privé d’une pension.
Le texte examine les questions tranchées par l'arrêt de la Cour, et se développe jusque à des réflexions sur la protection des droits fondamentaux des détenus.

2
Il reato di clandestinità
Art. 10-bis T.U. Imm.
Il c.d. reato di clandestinità, sopravvissuto allo scrutinio di compatibilità coi principi costituzionali e con la direttiva sui rimpatri, è giunto al suo quarto anno di vita, ma non si può dire che goda di ottima salute
Art. 10-bis T.U. Imm.
Il c.d. reato di clandestinità, sopravvissuto allo scrutinio di compatibilità coi principi costituzionali e con la direttiva sui rimpatri, è giunto al suo quarto anno di vita, ma non si può dire che goda di ottima salute

1
Le sentenze della CEDU e l’ordinamento italiano
Sottolineando i tratti differenziali principali rispetto alla Corte di Lussemburgo, il testo studia la posizione della CEDU nell'ordinamento internazionale, la portata delle sue sentenze e la loro efficacia nell'ordinamento nazionale, anche sui casi coperti da giudicato, precisando gli obblighi di interpretazione conforme e il potere di non applicazione del giudice nazionale, anche alla luce del Trattato di Lisbona.
Sottolineando i tratti differenziali principali rispetto alla Corte di Lussemburgo, il testo studia la posizione della CEDU nell'ordinamento internazionale, la portata delle sue sentenze e la loro efficacia nell'ordinamento nazionale, anche sui casi coperti da giudicato, precisando gli obblighi di interpretazione conforme e il potere di non applicazione del giudice nazionale, anche alla luce del Trattato di Lisbona.
Andreaus Michele, Università di Trento
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Angeloni Silvia, Università del Molise
Baldarelli Maria Gabriella, Università di Bologna
Barnabè Federico, Università di Siena
Bernini Francesca, Università di Pisa
Bianchi Carmine, Università di Palermo
Bivona Enzo, Università di Palermo
Cavenago Dario, Università Bicocca – Milano
Chiucchi Maria Serena, Università Politecnica delle Marche
Ciao Biagio, Università Bicocca - Milano
Cincimino Salvatore, Università di Palermo
Corbella Silvano, Università di Verona
Costa Massimo, Università di Palermo
Della Corte Valentina, Università di Napoli – Federico II
Depperu Donatella, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Fortuna Fabio, Università Telematica N.Cusano di Roma
Garibaldi Roberta, Università di Bergamo
Gonnella Enrico, Università di Pisa
Invernizzi Giorgio, Università L. Bocconi - Milano
Liberatore Giovanni, Università di Firenze
Mari Libero Mario, Università di Perugia
Miraglia Rosalba, Università di Catania
Pastore Patrizia, Università della Calabria
Pencarelli Tonino, Università di Urbino
Pulejo Luisa, Università di Messina
Ricciardi Antonio, Università della Calabria
Ruggiero Pasquale, Università di Siena – University of Brighton
Rusconi Gianfranco, Università di Bergamo
Signori Silvana, Università di Bergamo
Silvia Tommaso, Università della Calabria
Sorci Carlo, Università di Palermo
Zattoni Alessandro, Università Uniparthenope – Napoli
Processo di presentazione, valutazione ed accettazione dei contributi in volume (opere monografiche, raccolte e atti di convegno)
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
Il processo che porta alla pubblicazione di un prodotto monografico prende avvio con la proposta avanzata dall’Autore (progetto editoriale o lavoro monografico già definito). Tale proposta, corredata dal curriculum vitae dell’autore, va inviata al coordinatore scientifico della collana (Marcantonio Ruisi: marcantonio.ruisi@unipa.it). Il suo contenuto verrà preferibilmente esplicitato in una scheda di sintesi che dovrà coprire i seguenti punti: titolo (seppur non definitivo) dell’opera monografica, tematica generale di riferimento, obiettivi conoscitivi, metodo di ricerca, stato dell’arte della conoscenza scientifica, contributo all’avanzamento delle conoscenza, eventuali implicazioni per lo sviluppo aziendale e sociale, eventuale indice del volume. La proposta viene preliminarmente esaminata dal coordinatore che, nel caso di valutazione positiva e dopo aver espresso il proprio parere in forma scritta, sottopone, avendo cura di renderla anonima, la proposta stessa a tutto o parte (almeno tre componenti) del comitato scientifico. Il comitato scientifico avrà il compito di confermare l’accettazione della proposta verificando, in particolare, la corrispondenza con l’oggetto della collana, l’originalità del progetto e il contributo conoscitivo che intende apportare nell’ambito della letteratura economico-aziendale in generale e di quella specialistica riguardante il particolare tema trattato. L’accettazione della proposta avverrà a maggioranza assoluta dei componenti del comitato scientifico o di quelli coinvolti e avverrà in forma scritta. Nel documento di accettazione potranno essere riportati anche commenti, indicazioni, suggerimenti da far pervenire all’autore per migliorare il proprio progetto di editoriale o la monografia se sussistente. Di norma, la trasmissione della proposta avviene in formato elettronico via mail. Ogni componente coinvolto del comitato scientifico ha un tempo perentorio di due settimane per esprimere un parere sulla proposta progettuale o sul lavoro monografico o collettaneo presentato. Nel caso in cui il parere non arrivi entro i tempi previsti si considera il principio del silenzio assenso.
Il coordinatore acquisito il parere positivo dei componenti coinvolti del comitato scientifico, trasmette, nel caso di proposta progettuale, la decisione all’autore/curatore inviandogli anche eventuali commenti e suggerimenti esplicitati; nel caso di volume già definito, avvia direttamente il lavoro di referaggio secondo le modalità di seguito esplicitate. Contestualmente alla trasmissione del parere positivo, viene comunicata all’autore/curatore che ha presentato la mera proposta progettuale, la scadenza inerente la presentazione dell’opera completa, che di norma non può essere superiore ad un anno.
L’attività di referaggio avviene secondo le modalità del processo Double Blind Review (doppio referaggio anonimo). Il coordinatore, dunque, nominerà tra i membri del comitato scientifico un responsabile del processo di revisione e due revisori all’interno dell’elenco dei reviewer della collana. Il responsabile del processo è incaricato di ricevere il lavoro e di trasmetterlo ai due revisori prescelti. Il processo di referaggio si basa sull’assoluto rapporto di anonimato tra autore e revisori e si conclude entro due mesi dalla presentazione del volume. In caso di lavoro collettaneo o di atti di convegno, la proposta editoriale dovrà essere presentata dal curatore del volume (che dovrà presentare altresì il curriculum di ogni autore presente nel collettaneo) e ogni singolo contributo sarà sottoposto a referaggio (in tal caso i revisori potrebbero anche essere più di due). I revisori sono proposti dal coordinatore e dagli altri membri del comitato scientifico tra i professori ordinari e associati e tra i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) delle discipline economico aziendali appartenenti all’ordinamento accademico italiano e da ora internazionali aventi ruoli equipollenti rispetto agli studiosi nazionali. Nell’elenco dei revisori (suscettibile di aggiornamento) sono compresi i membri del comitato scientifico e del comitato di redazione, mentre né è escluso il coordinatore. Nel caso di proposta di monografia da parte di un membro del comitato scientifico, esso sarò escluso dall’intero processo di valutazione a partire dall’accettazione della stessa proposta.
Il revisore dovrà compilare una relazione analitica in cui spiegherà le motivazioni alla base della propria scelta. Ogni revisore terminerà la propria relazione con uno dei seguenti pareri di sintesi: lavoro pubblicabile, lavoro pubblicabile con minime revisioni, lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali, lavoro non pubblicabile. Nel caso di lavoro pubblicabile con minime revisioni, l’autore avrà un mese per apportare le modifiche richieste o per accogliere eventuali suggerimenti, nel caso di lavoro pubblicabile con revisioni sostanziali l’autore avrà, invece, a disposizione due mesi per riconsegnare il lavoro. Per l’eventuale secondo momento di referaggio, il tempo richiesto ai revisori per esprimere il loro parere sarà celere e l’esisto finale sarà un giudizio sulla pubblicabilità o meno dell’elaborato. Qualora i due revisori avessero pareri totalmente discordi ed inconciliabili, il responsabile del referaggio può in alternativa, avocare a sé la decisione circa la pubblicabilità del lavoro, nominare un terzo revisore, rinviare la decisione al coordinatore.
EVENTI
VIDEO
recensioni
approfondimenti

SINTESI
PUBBLICAZIONI

Informativa
Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto








