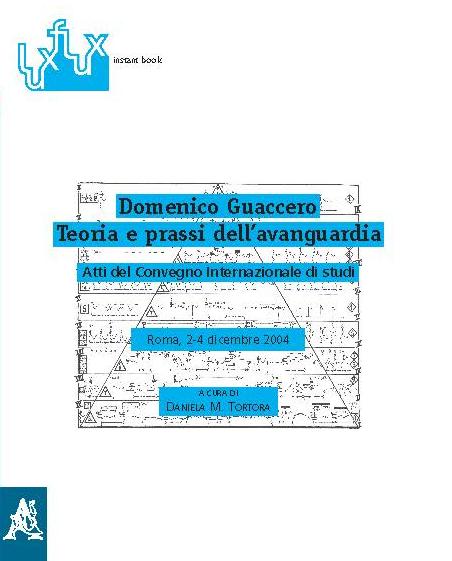http://www.argonline.it/
Domenico Guaccero (1927-1984) ha abbracciato con la sua esistenza precocemente interrotta l’inquieta molteplicità esperienziale della musica d’arte nel secondo dopoguerra. Il volume offre un puntuale resoconto dello svolgimento del convegno internazionale di studi a lui dedicato nel ventennale della scomparsa e organizzato dall’Archivio storico della musica contemporanea del MLAC presso le sale del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università di Roma Sapienza, con il patrocinio della facoltà di Scienze Umanistiche e della SIAE (Società Italiana Autori Editori) e con il sostegno della federazione Cemat, dell’associazione Nuova Consonanza e del Goethe Institut-Rom.
I contributi pronunciati, e qui raccolti nella quasi totalità dei casi, nonché la loro successione rispecchiano grosso modo fedelmente l’andamento dei lavori e le tre parti in cui il volume è suddiviso (I. Il contesto e il pensiero; II. Le opere e l’esperienza musicale; III. Questioni di prassi esecutiva) ripropongono la scansione delle tre giornate del convegno. Meritano di essere segnalati tutti i saggi di carattere propriamente analitico, riguardanti gli ambiti più diversi della produzione del maestro, dall’opera vocale, a quella di teatro, sino ai grandi lavori strumentali (le Sinfonie, le Variazioni) e corali della maturità e del congedo (Casa dell’armonia e Il sole e l’altre stelle). Di grande interesse appaiono pure gli studi che accostano l’opera di Guaccero, o parti di esso, ad analoghe imprese di altri musicisti contemporanei italiani (Dallapiccola, Petrassi, Scelsi) e non (Cage, Kagel, Schnebel, Curran), nonché tutti i contributi che pongono l’accento sul pensiero e sul percorso concettuale del musicista di Palo del Colle, con affondi sulle questioni a lui particolarmente care della grafia musicale, della composizione elettronica, dell’improvvisazione, del teatro per musica, del rapporto col pubblico e con la società tutta. Ricerche ponderose sono state effettuate, inoltre, in territori meno battuti dalla musicologia corrente, vale a dire intorno al rapporto di Guaccero con i mass media e, infine – grazie all’apporto di registi amici e sodali di un tempo, all’inatteso e ai più ignoto ambito della musica applicata al documentario televisivo e al teatro di parola. La sezione conclusiva, ove figurano le testimonianze di amici e interpreti nuovi e storici del maestro, s’incarica di affrontare dal di dentro la questione dell’interpretazione della scrittura musicale di Guaccero e il passo più spedito della trattazione riesce qui ad agevolare l’accesso alla intatta problematica complessità che si annida nelle sue partiture. Lo slancio e l’entusiasmo che animarono le memorabili giornate dicembrine romane del 2004 rivivono con calore nelle ricerche e nei discorsi molteplici che qui, a distanza di circa un quinquennio, s’intrecciano con immutata adesione al portato concettuale, oltre che artistico e musicale, dell’opera di Domenico Guaccero.Daniela Margoni Tortora è titolare della cattedra di storia ed estetica della musica presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli e docente di storia della musica contemporanea presso la facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Roma Sapienza. è responsabile dell’Archivio storico della musica contemporanea del MLAC (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea) della medesima Università. Ha al suo attivo studi e ricerche sull’opera del primo Ottocento (Drammaturgia del Rossini serio, Torre d’Orfeo, 1996), sulla drammaturgia musicale del Novecento e sulle neoavanguardie italiane del secondo dopoguerra (Nuova Consonanza. Trent’anni di musica contemporanea in Italia, LIM, 1990), sulla cultura musicale e sulla didattica della composizione in ambito napoletano negli anni tra le due guerre, sui sodalizi artistici degli anni sessanta (Collage 1961. Un’azione dell’arte di Achille Perilli e Aldo Clementi, Gangemi, 2005) e degli anni quaranta (Danza Pittura Musica. Dallapiccola, Milloss, Petrassi, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2009).
Link al sito