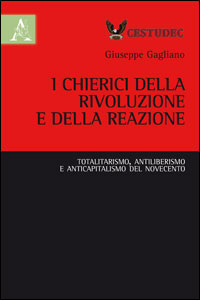Il Giornale di Como
Un saggio sui limiti della visione del mondo dell'intellettuale di sinistra. Il dottor Giuseppe Galliano presenta l’ultima fatica: I chierici della rivoluzione e della reazione
Abbiamo avuto modo di intervistareGiuseppe Gagliano - Presidente delCentro Studi De Cristoforis e docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Sant'Elia di Cantù – qualche settimana fa a proposito di intelligence economica. Questa volta la nostra attenzione si sofferma su un saggio dal titoloI chierici della rivoluzione e delle reazione (edizioni Aracne).Da una lettura rapida dell'indice risulta evidente come questo lavoro abbia un taglio filosofico-politico apparentemente lontano dalle sue pubblicazioni di natura strategica. Com’è organizzata la pubblicazione?
«Il saggio è costituito da tre parti autonome e nel contempo strettamente legate. Nella prima abbiamo esposto in modo ampio le interpretazioni filosofico-politiche e sociologiche volte a individuare i numerosi limiti della visione del mondo dell'intellettuale di sinistra facendo riferimento alle tesi - quanto mai attuali a mio modo di vedere – di Raymond Aron, Luciano Pellicani, Lucio Colletti, Giuseppe Bedeschi e Daniel Bell».
Cosa accomuna tutti questi intellettuali?
«La profonda conoscenza da un lato del pensiero marxiano e marxista nelle sue diverse declinazioni e dall'altra lato la loro profonda avversione alla visione del mondo e alla prassi marxiana e marxista».
Vuole essere più specifico?
«Per quanto concerne le tematiche espresse dai chierici – chiamati così in senso volutamente ironico - o intellettuali della sinistra novecentesca presi in esame nella prima parte (la Scuola di Francoforte, Horkheimer, Marcuse, Foucault, Fromm, il Situazionismo, Ivan Illich, Simone Weil e Serge Latouche quest'ultimo uno dei punti di riferimento del Movimento cinque stelle) queste sono state individuate nel rifiuto del capitalismo e del liberalismo, dell'Illuminismo e della riflessione cartesiano-baconiana, della democrazia rappresentativa e della società di massa, della rivoluzione industriale, del riformismo gradualistico, della conoscenza oggettiva delle discipline scientifiche interpretate come temibile concorrente rispetto alle forme culturali tradizionali di matrice prevalentemente umanistica e infine del rifiuto dell'America letta come paradigma del male. A tale proposito una delle tematiche che non a caso accomuna la sinistra radicale del Novecento con i movimenti alterglobal è certamente l'antiamericanismo, le cui motivazioni sono state individuate con estrema lucidità daMassimo Teodori secondo il quale l'avversione viscerale è da individuarsi nella politica di potenza americana, nel rigetto del modello culturale americano e più esattamente nel rifiuto consapevole o meno dell'individualismo, del capitalismo, del primato tecnologico, del pragmatismo sostanzialmente anti-ideologico. In altri termini, rileva Teodori, non c’è dubbio che da un punto di vista squisitamente storico l'antiamericanismo nel suo complesso sia stato teorizzato e difeso da tutti coloro che si sono fatti, e si fanno, portavoce di programmi politici rivoluzionari e reazionari. Nonostante le ideologie totalitarie di destra e di sinistra siano concluse tanto quanto i modelli anticapitalisti e terzomondisti, l'antiamericanismo continuerà a essere teorizzato da ideologie radicali come quelle presenti nel movimento alterglobal laico e religioso. D’altra parte la concezione della storia degli intellettuali di sinistra che è emersa, ora implicitamente ora esplicitamente nella seconda parte del saggio, è stata di volta in volta descritta attraverso scenari apocalittici, è stata letta in un'ottica messianica ed escatologica – rigettandone la complessità e determinando la mitizzazione della società preindustriale – e in un’ottica manichea sia in rapporto alla dimensione politica sia a quella morale e culturale. La lettura fatta della storia dagli intellettuali di sinistra ha inoltre determinato un'interpretazione arbitraria e priva di rigore storico-filologico sia della filosofia che dello sviluppo delle istituzioni, conducendo inevitabilmente a un'utilizzazione di strumenti interpretativi della realtà sociale assolutamente inadatti a interpretarla, all'elaborazione di modelli interpretativi del tutto privi di riscontro oggettivo e ad accostamenti arbitrari e strumentali tra sistemi di potere asimmetrici».
Insomma, per farla breve, chi è il chierico della rivoluzione?
«È un intellettuale che assume un atteggiamento di indignazione permanente verso la realtà, estraneo al mondo moderno (ma in taluni casi pienamente e contraddittoriamente inserito in esso), consapevole di essere diventato una figura del tutto marginale e che proprio per questo ha assunto un atteggiamento di risentimento, di rancore e di frustrazione verso la cultura scientifica e tecnologica come verso il capitalismo. Inoltre l’intellettuale di sinistra-erede coerente della ideologia giacobina di Robespierre e Saint-Just- ha attuato un’interpretazione dicotomica della realtà in base alla quale se da un lato ha mitizzato il Sessantotto, le società preindustriale, la civiltà greca, la civiltà orientale, la Comune di Parigi dall'altro lato ha invece demonizzato il potere politico, la democrazia rappresentativa, il liberalismo e il capitalismo».Ma il chierico della rivoluzione ha almeno indicato delle alternative a suo modo di vedere credibili?«In linea di massima le alternative si sono concretizzate ora in una forma di democrazia partecipativa dai contorni vaghissimi ora in una visione estetizzante della politica di matrice neoromantica, ora in un'alternativa totalitaria di matrice marxista, ora in un percorso mistico individuale (come nel caso della filosofa Weil), ora – infine – in un’assenza vera e propria di alternativa. Quanto alle pratiche di opposizione progettate o messe in atto per contrastare e trasformare radicalmente il sistema di pensiero dominante queste sono state individuate: nel modello babeuvista e leninista, nella sovversione culturale attraverso la controinformazione, il sabotaggio, la disinformazione e nella disubbidienza civile. L’università pubblica e la scuola pubblica hanno giocato – soprattutto dal sessantotto al settantasette – un ruolo determinante nel farci portavoce di questo antagonismo».
Nella terza parte – correndo l’indice – ha invece preso in considerazione i chierici della reazione e cioè autori e correnti culturali note come la Rivoluzione conservatrice, Junger, Evola, Guenon e soprattutto Alain De Benoist.
«Vede grazie agli studi dello storico della filosofia Paolo Rossi è stato agevole mostrare come la cultura della destra radicale e cioè quella elaborata da De Maistre, Nietzsche, Heidegger, Gentile, Schmitt, Spengler, Pound, Guénon, La Rochelle, Céline, Evola, Cioran e Eliade abbia rigettato di volta in volta: il comunismo, il liberalismo, l'Illuminismo, l'individualismo, il capitalismo, la democrazia rappresentativa e parlamentare, la scienza e la tecnica, la civiltà industriale, l'empirismo e lo sperimentalismo nati durante la rivoluzione industriale, la rivoluzione scientifica, la riflessione cartesiana e baconiana e infine l'economia come scienza oltre che naturalmente la cultura di massa vista come cultura omologante e alienante. Anche in questo caso l'interpretazione della storia fornita dagli intellettuali della destra radicale è assai lontana da quella delle scienze storiche e si è concretizzata: nella mitizzazione del concetto di nazione, nella demonizzazione della società preindustriale, nell'equipollenza – priva di qualunque legittimità storica – tra stalinismo e industrialismo, tra sistema liberale e sistemi totalitari, in una visione ciclica di matrice neospengleriana in cui la civiltà moderna è vista come un'inesorabile decadenza rispetto alla società preindustriale mitizzata, in una visione dicotomica in cui vi è una permanente e irriducibile contrapposizione tra sapere profano e sacro, tra cultura umanista e cultura scientifica e infine tra cultura occidentale e orientale».
E le alternative indicate?
«Quanto alle alternative indicate dagli intellettuali della destra radicale rispetto al sistema dominante attuale, queste sono state individuate: in un totalitarismo di matrice stalinista e nazifascista, nel nazionalismo di tipo militare o di tipo socialrivoluzionario, in una forma di individualismo aristocratico ed estetizzante, nel recupero di una tradizione di matrice spiritualistica edificabile politicamente sul corporativismo, nel misticismo di tradizione orientale e occidentale e infine in un'Europa imperiale federale di matrice ghibellina. Per quanto concerne l'intellettuale della destra radicale, il suo ruolo – caratterizzato da un atteggiamento profetico e di permanente indignazione analoga a quella dell'intellettuale della sinistra radicale – si è concretizzato nella convinzione di potere sovvertire il sistema dominante sfruttandone le debolezze attraverso tecniche di sabotaggio, di infiltrazione all'interno del sistema dominante e di pratiche rivoluzionarie di natura reazionaria».
La terza parte del suo volume ci sembra – se possibile – ancora più provocatoria a controcorrente delle precedenti. «Indubbiamente. Abbiamo da un lato mostrato come le riflessioni di due noti intellettuali italiani – Massimo Fini e Umberto Galimberti (ma sarebbe agevole farlo anche per Marcello Veneziani) – siano sovrapponibili poiché le fonti filosofiche alle quali hanno attinto sono analoghe e le conclusioni alle quali sono giunti sono prive di qualsivoglia originalità . Inoltre abbiamo concluso il volume facendo riferimento alle tesi di due noti scienziati americani Sokal-Bricmont che hanno letteralmente smantellato con arguzia e ironia le interpretazioni filosofiche della scienza date da notissimi filosofi quali Bergsòn, Lacan, Latour etc. Traendo le dovute conseguenze dalla tesi dei due scienziati è difficile non concludere che la filosofia sia stata spesso - e sia - una mistificazione ed una impostura intellettuale. D'altronde Popper diceva che la psicoanalisi di Freud aveva lo stesso valore dei miti omerici... E che dire delle riflessioni del noto filosofo Severino le cui riflessioni furono oggetto della spietata ironia di Paolo Rossi uno dei massimi storici della filosofia e della scienza?»
Link al sito