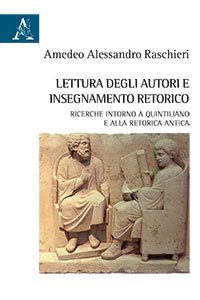Bollettino di Studi Latini
Amedeo Alessandro Raschieri, Lettura degli autori e insegnamento retorico. Ricerche in-torno a Quintiliano e alla retorica antica. Canterano (Roma), Aracne 2020, pp. 216.
Nato sulla scia di un progetto di ricerca condotto presso il Dipartimento di Studi letterari filologici e linguistici dell’Università degli Studi di Milano tra il 2014 e il 2018 sul tema Canoni letterari e scuola in età imperiale, e in origine circoscritto al primo capitolo del decimo libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, il volume raccoglie nei primi tre capitoli la rielaborazione di comunicazioni presentate in diverse sedi congressuali su tematiche attinenti e necessarie, secondo l’A., a inquadrare “i presupposti e le specificità della rassegna degli autori e delle opere greche e latine che Quintiliano presenta in quel capitolo” (12). E in effetti la messa a punto delle problematiche relative a La retorica come professione in Quintiliano (cap. I, 17-48), Appunti sul bello nella riflessione retorica antica (cap. II, 49-83), Memoria letteraria e pratiche di scrittura (cap. III, 85-130) si rivela un’utile premessa ad affrontare l’esegesi di quel vasto e articolato catalogo letterario che costituisce forse la sezione più nota e fortunata del manuale quintilianeo. Dal punto di vista della figura professionale ne emerge infatti quella di un retore ben consapevo- le del suo ruolo di “professionista della scrittura e dell’insegnamento” (12) sia nell’elaborazione di una definizione della retorica come arte onnicomprensiva ma in progress e non acquisita una volta per tutte, sia nella riflessione sulla deontologia – la moralità – della disciplina, sia nella definizione del suo campo d’azione rispetto alle altre arti e ai saperi tecnici come la medicina, l’architettura, la musica, la scultura, i cui strumenti sono necessari nella stessa misura in cui lo sono gli instrumenta capaci di dare forma all’opera dell’oratore. Quintiliano si sente scrittore e ricercatore ma anche, se non soprattutto, maestro, attento alle caratteristiche dei singoli allievi e alla gestione delle loro attività, pronto a collaborare con altre figure professionali come a prestare ascolto alle richieste dei genitori, a questo ruolo spinto soprattutto da quando, privato dai casi della vita di una propria discendenza, si era visto costretto ad allargare a una più ampia fascia di utenza la sua attività di educatore. Nella veste di scrittori e di critici letterari i retori latini, e tra di loro Quintiliano, concessero invece scarso spazio alla riflessione sul ‘bello’ che tanta parte aveva rappresentato nell’opera dei teorici greci, da Aristotele e Teofrasto in poi, a vantaggio di nuove coordinate di valutazione fondate sulla distinzione tra virtutes e vitia nei testi scritti: il nuovo paradigma culturale interessò anche scrittori di temi storici, religiosi e morali, ed esercitatosi sulla riflessione dei testi del passato e su quelli contemporanei, anche rappresentati a teatro, dovette fin da subito fare i conti “con la realtà e con la percezione dello spettatore, dell’ascoltatore, del lettore” (83). [...]
BOLLETTINO DI STUDI LATINI - Anno LI - fascicolo I Gennaio-Giugno 2021