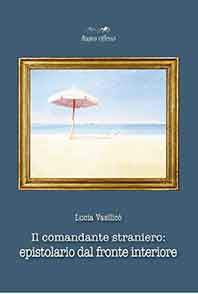Presentazione del libro a Più Libri Più Liberi
L’intervento di G.M. Miniussi alla presentazione de “Il comandante straniero: epistolaro dal fronte interiore“
Signore e Signori buonasera. Ringrazio la casa editrice Aracne per l'ospitalità e soprattutto ringrazio di cuore Lucia per avermi invitato alla presentazione del suo libro. Prima di dare il mio piccolo contributo vorrei parlare del contributo che questo libro ha dato a me: lo stupore. Che è, come affermava Aristotele, l'origine di ogni riflessione filosofica. Il Tauma. La lettura mi ha provocato inizialmente stupore appunto per la forza delle descrizioni dei luoghi e delle persone. Una descrizione estremamente immaginifica e al contempo estremamente realistica. I luoghi sono descritti attraverso sensazioni o addirittura aspettative; delle persone non è il loro carattere o le loro azioni a esser presentate, ma la spiritualità con la quale svolgono le loro attività quotidiane, i loro rituali. Altrettanto estremamente realistica mi risulta la “trascrizione” delle lettera di Giovanni, lo «zio Babila», il protagonista del romanzo, o meglio lo scrittore di quasi tutte le lettere che compongono questo libro. Qui lo stupore mi viene suscitato perché il realismo, che pretende di essere uno sguardo oggettivo sulla realtà, in questo caso si attua proprio nel suo modo contrario: nella radicale soggettività della prospettiva che una persona mentalmente instabile ha sul mondo. In poche parole, Lucia nel descrivere tale prospettiva peculiare e il flusso di pensieri che ne proviene è riuscita ad essere estremamente realistica, riuscendo con ciò a farci immedesimare nel suo protagonista. Riesce soprattutto a far percepire al lettore il senso di claustrofobia che il protagonista prova, in quanto Captivus, prigioniero dentro la propria mente. Per lui il mondo esterno è lontano, irraggiungibile al punto da suscitare in lui timore ed ossessività. È convinto, per esempio, che il postino, le persone che incrocia lungo la strada, o al caffè, gli rivolgano sommesse offese, che gli parlino alle spalle, o gli facciano dispetti. È ossessionato da colpe che è convinto di dover espiare in modo violento, quando dice, per esempio che lo condanneranno a morte, o che verranno a spezzargli la schiena, senza che però se ne possa capire realmente il motivo. Questa prigionia all'interno del proprio spirito si riflette all'esterno, dove il protagonista risulta, se non prigioniero, estremamente limitato nei movimenti. Si sente chiuso nella casa paterna, dove passa le giornate – per uscire deve aspettare l'accompagnamento della sorella o del padre stesso – in una Reggio Emilia mai descritta accuratamente, al contrario di quanto avviene per Viareggio. Lo spazio esterno è quindi altrettanto claustrofobico quanto quello interno, e le sue tinte sono per la maggior parte scure, crepuscolari ed invernali. In poche parole, Zio Babila non è padrone della sua stessa esistenza; si sente come un semplice passeggero a bordo di essa, come se questa fosse condotta da un comandante sconosciuto, straniero. Il comandante straniero, entrando un po' nel filosofico, mette in scena la tragedia di uno spostamento, un disallineamento, una dislocazione dello spirito rispetto al mondo. Come in una sorta di idealismo corrotto, non conciliato, interrotto. Vorrei leggervi una lettera che Hegel – il filosofo tedesco dell’idealismo per eccellenza – scrisse all'amico Windischmann: “Io conosco per esperienza personale questo stato dell'anima […] quando, internamente certa della propria meta, non è ancora venuta a capo, non è ancora pervenuta alla chiarezza e al dettagliamento dell'intero. Ho sofferto un paio d'anni di questa ipocondria fino all'esaurimento delle forze; certo ogni uomo ha un tale punto di svolta nella vita, il punto notturno della contrazione della sua essenza, attraverso la cui strettoia è costretto a passare”. Il rischio che lo spirito senza mondo, o meglio non conciliato con il mondo esterno, reale corre, Hegel lo conosceva benissimo. L’idealismo hegeliano, grossolanamente si presenta infatti come una conciliazione: lo spirito uscendo da sé incontra il diverso da sé, il mondo, il non-identico, lo riconosce come tale e fa rientro, per così dire in sé, conservando tale esperienza. Questo «ritorno» è la dialettica del soggetto e dell'oggetto conciliati. La Trinità. Ma questa dialettica corre sempre il grave rischio di una catastrofe psico-cosmica. Lo spirito, nel tentativo di uscire da sé, può rimbalzare sui suoi stessi confini, venir respinto e allora si ritrae e si contrae. Questa contrazione è la produzione autarchica di un mondo che è auto-scambio dello spirito con se stesso. Questa lettera di ci parla di tre elementi in particolare che c'interessano, perché ci aiutano a comprendere la condizione di Giovanni – Zio Babila. Il primo è “l'ipocondria”. Non dobbiamo farci distrarre dal significato che oggi l'ipocondria ha. Nel XIX secolo, con tale termine si definiva una grave patologia mentale. Proprio “Ipocondria” fu la diagnosi che portò all'internamento della sorella di Hegel stesso, Christiane Louise, in un manicomio dove questa poi morì suicida. L'ipocondria è la consapevolezza di un mancato passaggio al mondo. Il disallineamento è in primo luogo un restringimento vitale. La solitudine di uno spirito senza mondo è povertà, è malattia. È morte.Il secondo fattore tirato in ballo nella lettera è il notturno: per Hegel la contrazione in sé dello spirito è come il raggiungimento del punto più buio, la necessaria oscurità che precede ogni venir alla luce. È esattamente quanto avviene, secondo Schelling, in Dio. Dio è preceduto dalla più profonda oscurità e la chiarezza si sprigiona solo “dalla notte della sua essenza”. La strettoia, il terzo dei concetti qui richiamati, è proprio questo passaggio dalla notte al mattino, è l'aurora. Il venire alla vita, che è luce, che è calore. Il riferimento alla nascita è evidente; lo sforzo che ci è richiesto per «venire al mondo» è simile a quello che dobbiamo affrontare per «avere un mondo». Non credo siano casuali i riferimenti che Lucia fa così spesso nel libro, da una parte alle ossessioni ipocondriache di Giovanni (che si lava maniacalmente le mani fino a scorticarsele) e dall'altra a questa dimensione notturna. All'oscurità. Come ho detto, la descrizione di Reggio Emilia, così come della casa paterna, dove è vissuta e dove è morta la madre di Giovanni, ha tinte decisamente crepuscolari, notturne. Zio Babila sembra quasi descriversi come un vampiro: passa intere nottate a scrivere lettere alla nipote Orsola, di cui è innamorato; nel pomeriggio, mentre fuori la vita si agita, lui è costretto (dalla sorella o dal padre) a riposare, a fare il riposino pomeridiano. La casa paterna è descritta come un tempio, o meglio un mausoleo, una tomba – quella della madre, ma anche quella di Giovanni, in cui è sepolto vivo. Si ha la percezione, lungo la lettura delle epistole, la limpida percezione che la morte della madre rappresenti per Giovanni l'origine dei suoi mali, del suo deperimento mentale. Una questione non risolta, il mancato passaggio al mondo che lo rende ipocondriaco, disallineato. Spostato (Verrückt - Folle). Questo risulta evidente dalla lettera del 6 luglio 1961, in cui la grammatica di Giovanni, nel parlare della madre morta è al presente, mentre Orsola viene trattata al passato. E infine, sovrapponendo le due figure, si parla della madre al futuro. Quella casa, insomma è a tutti gli effetti un utero dal quale Giovanni cerca di venire al mondo, e di conquistarsi un mondo, uno spazio dove vivere, “dove farlo […] il nido”. In questi punti Il Comandante straniero raggiunge una liricità unica: sono quei momenti in cui zio Babila resta sulla soglia. E Lucia è stata bravissima anche in questo, a tenere la metafora della Soglia così reale: il protagonista spia quel mondo a lui negato da dietro la finestra, da dietro un cancello; lo vede agitarsi al di là del suo fronte, del fronte interiore. Giovanni spia e cerca un passaggio al mondo, che non può che darsi in un conguaglio che provenga dalla bellezza. La bellezza, che è luminosità, calore, risplendere accecante e festa. Orsola, la nipote di cui è innamorato Giovanni, rappresenta il passaggio al mondo. “Orsola non scrive e il suo silenzio mi fa camminare in tondo nella mia stanza, senza più angoli né finestre né porte, solo una fessura da dove entrano serpenti sibilanti” [Lettera del 28 settembre 1961]. Il romanzo ruota tutto attorno a questa polarizzazione. Alla solitudine, all'ossessione e segregazione nella casa oscura di Raggio Emilia si contrappone la soleggiata Viareggio, serena e rigenerante, dove Orsola protegge lo zio, lo allevia dalle sue ansie e al quale, in quanto nuova figura materna, può dare un'altra chance per venire al mondo. Addirittura Giovanni arriva a esplicitare nella grafia questa contrapposizione, scrivendo Via-Reggio, via da Reggio. Nella lettera del 28 aprile 1960 per esempio questa polarizzazione e sovrapposizione della figura materna sono portate all'estremo (Orsola prepara la camomilla o il latte caldo allo zio, il quale proprio non riesce a bere il latte se non filtrato. Questa immagine richiama evidentemente le cure materne). Questa lettera di Giovanni in particolare mi è particolarmente cara, perché la mia mente qui ha cominciato a viaggiare velocissima. Il lirismo, le immagini di Giovanni e la sua condizione, mi hanno infatti ricordato la poesia e la condizione di F. Hölderlin (1770-1843), poeta tedesco amico di Hegel, che è passato alla storia come il «poeta folle». Hölderlin ha molti punti in comune con Giovanni. Passò gli ultimi trentadue anni della propria vita chiuso in una torre, a scriver poesie e firmandole con pseudonimi come spesso fa Giovanni con le sue lettere, e come lui consapevole della propria instabilità mentale. La similitudine con il protagonista del libro di Lucia non si ferma qui. Hölderlin infatti attribuiva la propria malattia (che, secondo la tesi più accreditata, quella di Peters, sembra esser stata una Sindrome schizofrenica affettiva), ad una segregazione nello spirituale; nel non riuscire ad accedere al mondano, che gli è avulso, come dice egli stesso: “Ah il mondo ha fatto sì, che sin dalla prima giovinezza il mio spirito (Geist) si ritraesse in se stesso, e di ciò soffro ancor sempre” [Lettera di Hölderlin a Christian Ludwig Neuffer del 12 novembre 1798].Per entrambi quindi la causa della loro malattia è un'assenza di mondo, ed entrambi cercano il passaggio ad esso attraverso la continua tensione verso un Utopia, nel significato letterale di eu-topia, luogo felice, bello. Dove essi possano abitare, possano stare. Possano fare il nido. Un mondo che vada bene per loro, che sono così diversi, sapendo di esserlo. Hölderlin scrive, riferendosi a se stesso: “Tu nobile fiera nel bosco. Ma in capanne abita l'uomo!”, così come Giovanni nella lettera al proprio medico curante, del 14 agosto 1958, scrive: “Lo chiedo a lei che ha la mia cartella clinica: [...] sono forse il lupo delle fiabe? Il serpente del giardino dell'Eden?”. Entrambi insomma cercano un luogo, un mondo che sia finalmente esterno, dove cioè possano essere liberi, possano evadere dalla prigionia nella loro stessa anima. Dove, finalmente il comandante straniero che li guida con le sue mille voci li lasci in pace. Quelle voci che si alternano, si accavallano e infine lasciano esausto Giovanni (Lettera del 3 luglio 1959). Sia per Giovanni che per Hölderlin l'utopia, il mondo sognato al quale tendono, si assomiglia. Sognano entrambi il “venire al mondo”, che è sempre un venire alla luce, che è vita e che è calore. E in quanto tale è festa, è bellezza. È l'amore, che concilia nella bellezza, il passaggio al mondo. Scrive Giovanni ad Orsola: “Per quelle estati… estatiche estasi… estese… esterrefatte… estasiate… estenuanti… […] io ti ringrazio […] Perché noi voliamo o camminiamo e tu mi tieni per mano come un aquilone”. Così Hölderlin ne La festa della pace: “E solo la legge dell'amore avrà valore da qui in cielo, conciliando nella bellezza”. L'utopia si assomiglia nell'inconfondibile quiete di una bonaccia estiva, dall'aria rarefatta e dai suoni ovattati, dove finalmente le voci tacciono. È sulla spiaggia del bagno Caboto, in riva al mare, quando Giovanni è assieme a Orsola, che finalmente le voci “quasi non si sentono più” (Lettera del 28 aprile 1960), così come nella poesia L'Arcipelago, lo spirito del poeta tedesco se ne sta tranquillo sulla riva (still am Gestad), e finalmente lontano da ogni parola sogna di inabissarsi nel silenzio del mare (schweigender Wassertiefe). Per Giovanni l'amore che prova per Orsola è la possibilità di un mondo, di rompere la sua prigionia: “Vivo con Orsola la libertà di essere solo, la gioia di essere unico. Un paradiso terrestre. Una sorta di libertà vigilata dall'anima. Quando c'è Orsola, allora posso esserci anch'io” [Lettera del 21 novembre 1966].Vorrei concludere come ho iniziato, cioè parlando del contributo che il libro di Lucia mi ha dato, e ci ha dato. Lucia ha lanciato un pensiero ad una questione, ha rivolto lo sguardo verso persone che soffrono un grave disagio, che sono disallineate rispetto alla nostra realtà. Ecco perché ho parlato di un poeta tedesco morto quasi duecento anni fa. Così come la malattia non ha impedito ad Hölderlin di donare al mondo uno dei più elevati momenti di poesia, così il disagio mentale di Giovanni, e di molti come lui, non gli ha impedito di amare e di essere amato. Anzi, forse proprio in virtù di questa “distanza”, scrivono e amano. Del resto, la storia di un amore può benissimo essere la storia di una distanza.
Link al sito