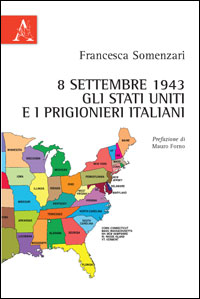La provincia di Como
L’America amara dei prigionieri di guerra italiani.
Una storia dimenticata ora riportata alla luce
Una storia dimenticata ora riportata alla luce
POWs. Una sigla che, per chi non si interessi di storia, nulla dice. In realtà, abbondano, soprattutto nel mondo anglosassone, i lavori dedicati ai POWs, ovvero ai “Prisoners of War”, prigionieri di guerra. Una storia quasi tutta moderna, che nasce con la guerra ”en masse”, figlia della leva “en masse”, nefasta eredità prima giacobina poi napoleonica che termina con la fine dell’ultima guerra mondiale, e il faticoso approdo dell’Europa, almeno quella occidentale – la storia slava testimonia il contrario per l’Est – ad uno dei più lunghi periodi di pace che abbia mai conosciuto. Nel 2015, settant’anni. Una storia però che si intensifica in modo esponenziale nel lungo periodo in cui l’Europa, per usare la locuzione dello storico piemontese Enzo Traverso, ora docente a Cornell negli USA, era stata messa “a ferro e fuoco” tra il 1914, ma forse anche da prima, dalle guerre balcaniche prodromo del primo conflitto mondiale, fino al 1945. Una lunga guerra civile europea, se l’Europa concepiamo, anche solo distrattamente, come patria comune.
Non è notissima la vicenda dei prigionieri di guerra italiani deportati in America dopo l’armistizio, o propriamente, secondo la formula originaria del trattato, poi addolcita per non far soffrire troppo le coscienze, la resa dell’8 settembre. Ne aveva parlato alcuni decenni fa Flavio Conti, in un libro appena ripubblicato da Il Mulino, I prigionieri italiani negli Stati Uniti, con alcuni documenti aggiuntivi rispetto all’edizione originale, del 1986. Ma chi voglia farsi un’idea della vicenda da un punto di vista lievemente diverso, politico-diplomatico e storico-militare, e si tratta di vicenda non secondaria, sia per il numero altissimo di interessati, decine di migliaia, sia per il significato assunto negli anni cruciali della guerra civile italiana e in seguito, può leggere l’agile libro di Francesca Somenzari, 8 settembre 1943: Gli Stati Uniti e i prigionieri italiani (Aracne, pp. 236, € 14). È un libro che narra la vicenda drammatica di un esercito allo sbando, come del resto tutta l’Italia, divisa, contesa, invasa, violentata da troppi armati, lacerata, dopo la resa dell’8 settembre, con un Regno del Sud nelle mani di un generale incapace, Badoglio, che incarna una storia tipicamente alla rovescia: più incapace uno si rivela, a partire dalla sua disastrosa condotta a Caporetto, più sale nei gradini, italici, del potere.
Decine di migliaia di prigionieri italiani, catturati dagli Alleati in Europa, Africa, e tutti i teatri della guerra, presero la via dell’ America, dove vennero trattati spesso, in barba alla convenzione di Ginevra del 1929, nel peggiore dei modi, salvo poi poter tornare utili agli USA, che ne rispedirono alcuni a combattere per Badoglio; ma che ne tennero anche molti a disposizione nelle inquietanti ISU, “Italian Service Units”, dei reparti speciali che dovevano essere, previa adeguato addestramento – quello delle truppe sabaude era carente almeno dai tempi di Vittorio Emanuele I, il fondatore dell’Arma dei Carabinieri – e previa sconfessione ufficiale del fascismo. In fondo, essi erano soldati dell’esercito del Duce, e non era chiaro se sarebbe stato convenienti spedirli in Italia. Avrebbero servito con Badoglio? O avrebbero cercato tutti i modi per scappare su al Nord ed arruolarsi a Salò? Meglio tenerli lontani, pensarono a Washington, meglio lasciarli internati e rigenerarli nei campi di prigionia, salvo alcuni ufficiali, pochi. Che sorte amara. La speranza, in seguito, era che se questi prigionieri fossero tornati “ricondizionati” in Italia, essi avrebbero poi servito come quinte colonne americane nella ricostruzione imminenti, giurando fedeltà agli ideali democratici, ovvero, non tanto antifascisti, quanto anticomunisti. Era ben chiaro che presto l’Europa, e il mondo, si sarebbero divisi in due blocchi contrapposti.
Povera gente. I loro diari, le loro memorie, narrano di viaggi per mare terribili, stipati come topi in stive senza luce e con poca aria, a diretto contatto con l’Oceano invisibile, con il terrore che un u-boot li silurasse, incuranti che erano ancora, o erano stati alleati, alleati impreparati e scomodi, ma pur sempre alleati, e dopo l’8 settembre, tragicamente, traditori. Poi i soggiorni nei campi, soprattutto nella dimenticata Hereford, in Texas. Un luogo singolare, sperduto, dove l’acqua contiene un alto grado di fluoro, dunque, una specie di dentifricio naturale, mentre in ogni dove vi sono allevamenti “free range”, tanto che Hereford è conosciuta come la capitale mondiale della carne di manzo. Vi soggiornarono, spesso proprio come bestie, ma non in libertà, in un vero e proprio campo con filo spinato elettrizzato, migliaia di italiani. Incerto il loro destino, anche dopo la formale alleanza di Badoglio con gli USA. La guerra, tragedia madre, è sempre fomite di infiniti altri drammi.
Link al sito