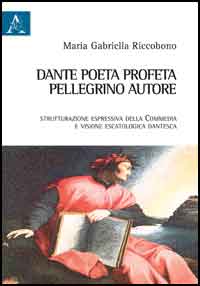La Rassegna della Letteratura Italiana e Fronesis
Dante poeta profeta pellegrino autore
Non è consueto confrontarsi, come in modo stimolante è stato fatto all’interno del presente volume, con la riapplicazione, nello studio di un autore, dei risultati nati dalla propria esperienza professionale come docente fondendo allo stesso tempo, come si precisa già all’interno della Premessa (pp. 7-10), interessi filosofici e interessi per la critica testuale e la critica stilistica.La studiosa ripercorre infatti, riconoscendo la necessità di un’approfondita scansione filologica del testo dantesco, quegli aspetti del profetismo dantesco che, strettamente connessi alle Sacre Scritture (e in particolare a Ezechiele e all’Apocalisse, si nota), portano necessariamente a riflettere sul «problema delle diverse figure di Dante proiettate all’interno del poema» (p. 8); se, come si riconosce, «Dante auctor è in relazione dialettica […] con il se stesso di un tempo del tutto trascorso […], cioè con l’agens, e per un altro verso con un se stesso attuale, insediato egli pure nel presente della scrittura, al quale è eminentemente affidato il compito di narrare il passato, i casi occorsi durante il viaggio» (p. 9), diventa allora indispensabile chiarire differenze e somiglianze tra auctor e poeta all’interno dell’opera dell’esule fiorentino.In quattro capitoli, dunque, si procede a una serrata analisi secondo le direttive ora tratteggiate, cominciando con Dante poeta-profeta. Lo scriba, l’autore e il personaggio (pp. 11-39), sezione all’interno della quale si nota, tracciando un regesto degli interventi dell’autore nel percorso narrativo della Commedia, che è possibile individuare diverse tipologie degli interventi suddetti, i cui principali espedienti retorici d’espressione risultano essere gli officia esordiali della poesia epica, gli appelli al lettore, le apostrofi, ecc., ma anche gli espedienti legati al trasformare i personaggi via via incontrati in portavoce delle ideologie dantesche: l’autore arriva così «a congiungere in sé le figure dello scriba fedele e dello storico verace» (p. 39), il che rende conto della scrittura “a due tempi” del poema, tra presente della scrittura e passato del viaggio concluso.«Sternel la voce del verace autore» (pp. 41-67) è incentrato invece sull’indagine dei valori semantico-referenziali differenziati che assumono “autore” e “poeta” («Dante si incorona poeta ma non auctor», si sostiene a p. 41), svolgendo alcuni suggerimenti di Michelangelo Picone; i preamboli del primo e secondo canto dell’Inferno e del primo del Paradiso (e anche certi passi della Vita nova, del Convivio e del De vulgari eloquentia), con tra l’altro un’originale interpretazione dei vv. 13-15 di quest’ultimo, sono materia per discettare del senso di «auto-legittimazione autoriale e poetica di Dante, cui si congiunge la sua legittimazione profetica» (p. 42): l’esule fiorentino tiene a essere identificato come poeta in volgare e profeta, ma non come autore, si conclude, poiché l’unico verace autore è Dio.Il tipo di discettazione messa in atto all’interno del terzo capitolo, «Veggio il novo Pilato sì crudele,/ che ciò nol sazia». Ezechiele e l’Apocalisse in Purg. XX (pp. 69-99), si incentra sull’influenza riconosciuta dell’Apocalisse sugli ultimi canti del Purgatorio, sui legami intercorrenti tra XIX e XX canto di questa stessa cantica e su sogni e profezie ravvisabili al loro interno; in Appendice viene anche proposto un confronto tra l’apostrofe all’Italia del VI canto del Purgatorio (a p. 97, per una mera svista, segnalato come VI dell’Inferno) e il XX canto della medesima cantica già preso in esame.Spetta al capitolo conclusivo, «Con altra voce omai, con altro vello/ ritornerò poeta». Dante autore sul proscenio (pp. 101-154), insistere sulle “scene proemiali” del poema, identificando nell’inscindibile dittico costituito da primo e secondo canto un antefatto delle vicende poi narrate, «il potente nucleo generatore dei casi straordinari che saranno raccontati» (p. 105); elemento esegetico elettivo sarà la differenziazione tra le due voci del poeta scrittore, l’io immagine dell’autore proiettata nel testo e il pellegrino che svolge il viaggio salvifico.I contenuti salienti dell’antefatto in esame, le relazioni tra Dante e la lupa, nelle valenze individuali, politiche ed escatologiche ravvisate in questo rapporto dialettico, i collegamenti delineati con i canti finali della seconda e della terza cantica, l’indagine inerente alle protasi e invocazioni collocate proemialmente diventano precisi tasselli di un mosaico teso a indagare infine il rapporto che l’autore vuole stabilire con il “suo” pubblico, raggruppabile, a parere della studiosa, in «tre serie differenti di destinatari» (p. 152), la terza delle quali è riconosciuta, in definitiva, costituita dalla cristianità tutta.
Link al sito