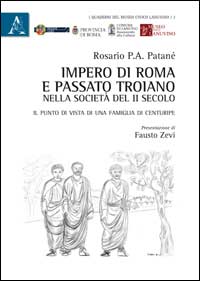Bryn Mawr Classical Review
Impero di Roma e passato troiano nella società del II secolo
Il volume nasce sulla scia di recenti studi sull'uso di arte e memoria nell'età della Seconda Sofistica e, in particolare, sul significato politico-culturale degli interventi di evergetismo nella creazione di spazi urbani commemorativi del passato all'interno di grandi città di cultura greca. È dedicato alla ricomposizione e contestualizzazione storico- culturale di un ciclo statuario marmoreo, che uno dei consoli del 149 d.C., Sosio Prisco, avrebbe dedicato in un luogo pubblico di Centuripe, una città dell'entroterra siciliano, della quale la famiglia del console sarebbe stata originaria. Il ciclo scultoreo avrebbe compreso esponenti della dinastia giulio-claudia, un eroe locale, Lanoios, e i ritratti di membri della facoltosa famiglia del dedicante, i Pompeii Falcones ( PIR 2 VI, 1998, Stemma 29). Nonostante l'assenza di figure della casa regnante, il monumento sarebbe stato "un chiaro esempio di propaganda con richiamo alla storia mitica della città e al rapporto della famiglia del committente con Roma e con l'imperatore" (28). Il "passato troiano", cui si allude nel titolo, sarebbe stato rievocato dagli esponenti della gens Iulia e da Lanoios, "centuripino approdato nel Lazio al seguito di Enea" (69) e mitico fondatore eponimo di Lanuvio, una città del Lazio, alla quale Centuripe era legata da un rapporto di cognatio documentato da un'epigrafe tardo- ellenistica. La città siciliana è annoverata da Plinio tra le comunità Latinae condicionis . In età imperiale, si arricchì di vari monumenti in opera cementizia, pubblici e privati, che hanno fatto pensare e interventi finanziari imperiali e all'esistenza di un'agiata "borghesia" locale. Il contesto di rinvenimento delle sculture facenti parte, secondo l'Autore, di un unico gruppo è quella che ormai, nella letteratura archeologica, viene definita come "area presso l'ex Mulino Barbagallo", nella vallata orientale della collina di Centuripe. Qui, dopo rinvenimenti fortuiti e scavi clandestini, all'inizio degli anni '50, furono avviati scavi di recupero che portarono in luce un articolato complesso architettonico, con almeno tre fasi costruttive medio- imperiali. Sulla base di un'iscrizione menzionante un sacerdote augustale, fu naturale supporre che uno degli ambienti messi in luce potesse essere sede di un collegio di Augustales e che nei pressi potesse sorgere il foro. Si è, infine, ipotizzato che tutto il complesso potesse essere parte del foro, 1 ipotesi, questa, accettata ed elaborata dal Patané. Il gruppo, al di là della sua composizione, è datato tra il 128, l'anno di una probabile visita di Adriano a Centuripe, e il 149 d.C., l'anno del consolato del dedicante (28). Arco temporale, questo, che va senz'altro ristretto, perché Sosio Prisco, morto all'età di sessantadue anni nel 180 d.C., 2 nel 128 avrebbe avuto solo una decina d'anni. La rilettura del complesso architettonico, con cui si apre il primo capitolo, è utile, purché si tenga presente che è basata su resti profondamente danneggiati dal tempo e dai vandali nei sessant'anni intercorsi dallo scavo. Va precisato che il mosaico all'interno di un distinto corpo di fabbrica al margine sud dell'area, con l'eccezione del primo editore che lo ritenne di età antonina, non è mai "stato datato all'epoca di Adriano o degli Antonini", come crede il Patanè (41). Esso, saldamente collocabile tra il tardo II e gli inizi del III sec. d.C., data anzi l'ultima fase costruttiva medio-imperiale, a cui appartiene il corpo di fabbrica che lo ospita. Né, in assenza di nuovi lavori, c'è motivo di sospettare che tale struttura possa appartenere ad una fase anteriore (43-44). Le partizioni ricavate in epoca tarda all'interno di uno degli ambienti di età medio-imperiale, inoltre, dal momento che non presentano il fondo impermeabilizzato né un bordo superiore, non possono essere lette come vasche (39). Né si capisce che ruolo avrebbero potuto avere delle vasche all'interno di un impianto per la produzione di calce, di cui, in base a tracce di bruciato nel terreno e di fuoco su qualche scultura, prima si congettura (40) e poi si dà per certa l'esistenza (48). In assenza di un forno o di chiari indizi della sua esistenza, è arbitrario supporre che i marmi rinvenuti in zona si trovassero lì per essere calcinati (40, 49). Poco convincente, infine, mi sembra il riconoscimento del pavimento del foro di età repubblicana in un piano acciottolato emerso in un saggio del 1987, presso l'area scavata negli anni '50; l'identificazione di un settore così importante si basa solo sulla presenza di un frammento di capitello con tracce di riutilizzo e di uno di mattone sagomato, trovati sull'acciottolato, e sul rinvenimento, avvenuto in passato nei dintorni, di due epigrafi di carattere pubblico (31-33). Di nessuno dei marmi, quasi tutti recuperati in seguito a ritrovamenti fortuiti o a scavi clandestini condotti per cunicoli, si conosce la posizione stratigrafica. Non è detto, quindi, che le sculture,
Link al sito