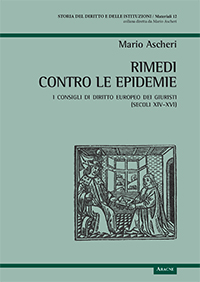Medioevo Latino
Mario Ascheri Rimedi contro le epidemie. I consigli di diritto europeo dei giuristi (secoli XIV-XVI) Roma, Aracne 2020 pp. 124 (Storia del diritto e delle istituzioni. III. Materiali 12)
L'opera si presenta divisa in tre ampi capitoli: il primo relativo alla risposta del diritto comune alla peste (pp. 9-32), il secondo (pp. 33-64) e il terzo (pp. 65-118), speculari, delineano le varie epidemie di peste e illustrano le misure predisposte dai legislatori. Il primo capitolo è tratto dalla monografia Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche Rimini 1991 (cfr. MEL XVI 5708); i capitoli II e III sono apparsi in «Quaderni internazionali di storia della medicina e della sanità» 4 (1995) 19-49 e 5 (1996) 11-66. Al centro del volume e in particolare nella prima sezione, vi è la problematica della peste osservata dalla prospettiva della dottrina giuridica, in cui essa fa il suo ingresso tramite i commenti ai frammenti del Corpus iuris civilis. Nel Quattrocento la giurisprudenza mostra un interesse crescente per il tema della peste e una maggiore necessità di una disciplina espressa in opere sistematiche (per lo più trattati), sebbene con un certo ritardo, causato da diverse circostanze, rispetto ad altri campi come la medicina. Questa necessità si ricollega al bisogno della giurisprudenza di apparire come garanzia di tutela delle istituzioni e di evitare di essere minata nella sua credibilità anche dalla concorrenza di altri operatori culturali. Per non perdere autorità, il mondo del diritto ha il dovere di affrontare temi scottanti, rivolgendosi anche a un pubblico non specialistico. Tra i giuristi più competenti che iniziano a occuparsi in maniera sistematica della peste si annoverano Gianfrancesco Sannazzari della Ripa, Silvestro Aldobrandini e Girolamo Previdelli, tutti impegnati nella composizione di un Tractatus iuridicus de peste, che pone le premesse per una rinnovata discussione e fissa i punti chiave della questione, inserendosi nella tradizione di diritto comune. Questi tre trattati ebbero capillare diffusione e una grande utilità immediata, riuscendo a legittimare le esperienze quotidiane alla luce del diritto comune, a divulgare la saggezza politico-amministrativa e rivelare la problematica concreta legata all'epidemia con la sua risoluzione. Mostrano invece una maggiore carenza sul piano della storia giuridica, per la modestia del loro approccio sistematico, e su quello degli effetti pubblicistici. La prima parte del libro si conclude con un'appendice relativa alle personalità dei tre giuristi. La seconda sezione illustra, una volta assodata ancora nel Quattrocento la mancanza di un'opera sistematica sulla peste da parte del diritto comune, espressione della cultura giuridica del tempo, alcune delle misure giuridiche adottate sulla questione. La dottrina, nella rielaborazione delle disparate fonti romano-canonistiche, giunse a risultati piuttosto significativi, concretizzati nei tre trattati sopranominati. Nella terza sezione l'A. si sofferma sulle questioni più strettamente giuridiche disciplinate dai tre trattati, concernenti gli interessi e il diritto privato, come lo status giuridico degli individui, i negozi giuridici e l'amministrazione della giustizia in relazione alle epidemie di peste. L'opera si conclude con un'appendice che riporta alcuni documenti genovesi su una prassi assicurativa. Si potrà notare, alla fine, che le conclusioni dei trattati, indipendenti tra loro, appaiono spesso affini, in quanto influenzate dalle medesime fonti legali e da un simile ambiente socio-culturale. (Martina Putrino)
MEDIOEVO LATINO XLIV
Link al sito