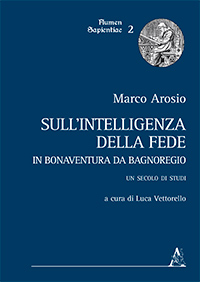Medioevo Latino
Sull’intelligenza della fede in Bonaventura da Bagnoregio
Il volume, pubblicato postumo con una presentazione di A. Ghisalberti e una prefazione del curatore, raccoglie gli studi dell’A. sulla storiograJa bonaventuriana del XX secolo, suddivisi in tre capitoli che ne scandiscono i cambiamenti di paradigma storiograJco a partire dal concordismo orientato in senso neo-scolastico, sostenuto da I. Jeiler nelle annotazioni all’edizione degli Opera omnia. Questa interpretazione cominciò a essere messa in crisi attorno agli anni Trenta dagli studi volti a mettere in luce l’originalità del pensiero di Bonaventura sul rapporto tra filosofia e teologia, o tra ragione e fede, secondo l’idea di cristiana proposta da E. Gilson. Successivamente, a partire dagli anni Cinquanta emerge il tema della teologia filosofica bonaventuriana (G.H. Tavard, J. Ratzinger). Negli ultimi decenni del Novecento Bonaventura è presentato da alcuni studiosi (C. Bérubé, J.-G. Bougerol) come peculiare rappresentante di una «filosofia francescana», mentre da altri vengono messi in luce temi quali la «metafisica teologica» e il simbolismo della coniunctio oppositorum (Z. Hayes, E.H. Cousins). Una dettagliata attenzione viene dedicata al panorama italiano del secondo dopoguerra e ai numerosi studi elaborati nel contesto dell’Università Cattolica di Milano (S. Vanni Rovighi, E. Bettoni, F. Corvino, L. Mauro). Oltre a questi autori di importanti monografie, costella le pagine del libro un fitto panorama di studiosi, non soltanto specialisti di filosofia medievale; l’insieme mostra l’estensione della rete degli studi bonaventuriani, di cui la bibliografia finale dà la misura, e le molte sfumature interpretative proposte.
Tratteggiando la posizione dei diversi interpreti, vengono via via nominati numerosi autori medievali considerati fonti o interlocutori di Bonaventura; tuttavia, a parte qualche cenno più specifico su Tommaso d’Aquino, non si incontrano elementi di rilievo né dal punto di vista documentario né interpretativo a riguardo dei singoli filosofi e teologi menzionati. Nelle conclusioni (pp. 189-91) l’A. mette in evidenza l’estrema diversificazione delle interpretazioni riguardanti lo statuto della teologia in Bonaventura, e sottolinea la necessità di liberarne l’immagine dall’incrostazione dei paradigmi che si sono succeduti nel volgere di un secolo a partire dalla falsificazione del concordismo neoscolastico jeileriano» insieme all’esigenza di una radicale riconsiderazione dell’intera produzione del maestro francescano, alla luce delle fonti. In appendice al volume un analogo, ma assai più sintetico, percorso critico su due temi centrali dell’etica è oggetto del saggio di I. Zavattero Studi sul pensiero etico di Bonaventura da Bagnoregio. Felicità e virtù (pp. 219-40). La presentazione di M. Arosio pp. (9-12) è un breve excursus sul dibattito novecentesco (Gilson, van Steeberghen, Putallaz) relativo alla “Filosoficità”della posizione bonaventuriana. Quella di L. Vettorello (p.13-6) delinea la struttura del volume e ne indica l’obiettivo nell’intenzione di verificare la correttezza delle modalità con cui la storiografia medievale novecentesca ha recepito la nozione bonaventuriana di intellectus 0dei. (M.Per.) [758.