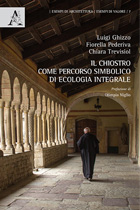Avvenire
Il chiostro e quel costruire per l’uomo in ricerca
Spesso invischiata nel fascino della forma, l’architettura tende a non considerare che ogni suo prodotto è un luogo: interagisce con quanto l’attornia e racchiude spazi che possono essere pregni di senso. Questo fatto invece appare molto chiaro se si guardano i monasteri medievali, ben riconoscibili per l’ordine che ne caratterizza la gerarchia degli ambienti. A partire dal chiostro, spazio aperto ma chiuso allo stesso tempo, in piccolo espressione di armonia cosmica ove si incontrano lo spazio fisico e quello spirituale.
Il tema è trattato con preziosa sintesi da L. Ghizzo, F. Pederiva e C. Trevisiol in Il chiostro come percorso simbolico di ecologia integrale (Aracne editrice, pagine 80 ill. Euro 12), in cui si mostra come la continuità tra costruito e natura derivi dal lavoro che trasfigura il luogo in un canto di lode, strutturato in modo da invitare a un vivere in cui la felicità deriva non dal consumare, ma dall’aderire a una vocazione.
L’esempio esaminato è l’abbazia cistercense di Follina (TV, sec. XIIXIII) ma il discorso vale in generale per la costruzioni monastiche. Di cui il chiostro è autentico cuore: una radura aperta nella foresta, che è quanto sta "fuori" dal vivere civile (spesso i monasteri furono fondati in luoghi inospitali che i monaci resero non solo abitabili ma fertili) e incentrata sul pozzo, ove non solo si attinge l’acqua sorgente di vita (come il battistero, è di forma ottagonale quale richiamo dell’ottavo giorno simbolo di vita eterna) ma si stabilisce un’assialità verticale. Mentre tutto attorno allo spiazzo si raccoglie il porticato che, con le sue aperture mediane, inquadra gli assi che l’attraversano segnando i percorsi da sud a nord (lato sul quale sta la chiesa) e da ovest a est: il primo esprime l’ascesa dalla terra al cielo e il secondo l’aprirsi al sorgere della luce.
Coerentemente i sostegni del porticato sono una selva di alberi stilizzati di valore simbolico. Il pilastro dell’angolo nordest si compone di quattro colonne separate, segno della disobbedienza di Adamo ed Eva tradotta nella «quadruplice frattura con: se stessi, il creato, il prossimo, Dio». Il pilastro a sudest è avvolto da quattro colonne a spirale discendente, «allusione alla dispersione del popolo eletto e alla distruzione di Gerusalemme», perché il chiostro avverte contro i rischi del moto centrifugo che allontana dalla grazia, mentre invita all’incontro nella comunità e nella salvezza. Questa è espressa nei pilastri di sudovest (quattro colonne formano due nodi allusivi al recupero dei legami spezzati tra cielo e terra) e di nordovest, le cui colonne disegnano una spirale ascendente indicante la «composizione dell’ultima frattura, quella della separazione dal corpo» superata nel ritorno all’integrità: corpo e anima assieme nell’Eden ritrovato. Secondo un percorso di ecologia integrale in cui la parola stessa è trans-significata: «Da scienza (logia) della casa comune (oikos) è diventata "abitazione comune" nel Logos».
Il monastero si pone come percorso di crescita, e si scopre capace di un ruolo che Olmpia Niglio nella prefazione definisce di «diplomazia culturale», in quanto espressione di potenzialità di incontro tra la tradizione giudeocristiana e altre tradizioni religiose «impegnate in un cammino comune per un mondo di pace». Così il monastero è compiutamente paradigma di un’architettura non fatta di forme ma di contenuti.
Qualcosa il cui studio dovrebbe interessare chiunque si occupi di spazi per la vita dell’essere umano.