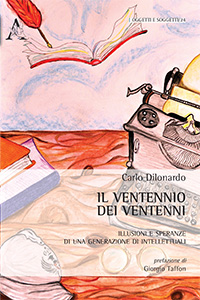Il Mestiere di Storico
Il Ventennio dei ventenni
L’a. inizia la sua narrazione con una lunga introduzione, forse troppo prolissa e pocosincronica, almeno in questa parte del volume, con il tema della sua ricerca: l’analisi delleposizioni politico-culturali dei giovani ventenni che non vissero l’esperienza della primaguerra mondiale e non parteciparono, pur aderendo, all’avvento del regime fascista inItalia.
Nel primo capitolo, Educare i giovani: fascistizzare i futuri italiani, l’a. espone sinteticamentele interpretazioni che la storiografia più avveduta ha dedicato al tema preso inesame e analizza, anche se non sistematicamente, il pensiero di Mussolini sull’arte, nonchél’atteggiamento che, secondo il duce, lo Stato avrebbe dovuto tenere nei suoi confronti. Ilvolume dedica ampio spazio alle concezioni che i giovani fascisti svilupparono dell’arte edella funzione che in uno Stato totalitario avrebbero dovuto svolgere gli intellettuali, conun’attenzione particolare ai letterati e al teatro.
Nel secondo capitolo, Percorsi «della» e «per» la cultura, l’a. analizza approfonditamentei due manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti, sottolineando le diverse impostazionidel rapporto politica-cultura. In questo capitolo, si approfondisce inoltre l’ideadi cultura di Giuseppe Bottai il quale, insieme a Pellizzi e allo stesso Mussolini è, secondol’a., il più empatico rispetto alle esigenze di rinnovamento della cultura avanzate dai giovanifascisti.
Nel terzo capitolo, il più riuscito e originale, intitolato La parola alle riviste giovanili,l’a. analizza con sistematicità, attraverso le principali riviste – non solo universitarie –, leposizioni politico-culturali di questi giovani. Il volume, in questa parte, illustra vividamentele inquietudini di questi giovani, che avevano origine dal conflitto tra l’atteggiamentofideistico assunto nei confronti del capo carismatico e il desiderio di vivere con maggiorelibertà il loro rapporto con il fascismo e i fascisti. Tra le molte riviste analizzate spiccanoquelle di carattere letterario, artistico e filosofico come «Il Saggiatore», «Il Cantiere», «LaPenna dei ragazzi». Tra le fonti utilizzate in questo capitolo, oltre quelle a stampa, sonole interessanti dichiarazioni di un testimone del tempo, Armando Ravaglioli. Particolareattenzione infatti è qui dedicata all’analisi del rapporto tra politica e cultura in personalitàdi grande rilievo artistico come Silvio D’Amico e Giorgio Strehler.Nell’ultimo capitolo, Una difficile rinascita, l’a. delinea i tormentati percorsi, pocostudiati, del movimento artistico legato al quindicinale «Vita Giovanile», fondato da ErnestoTreccani, che annoverava tra i collaboratori Renato Birolli e Luciano Anceschi. Attraversolo studio di questa rivista anticonformista, che non aveva rapporti con i Guf e con ilPnf, l’a. mostra le difficoltà di questi giovani a uscire dalla temperie culturale del fascismonel momento in cui questo, a causa della guerra, cessava di vivere, ma anche la ricchezza eintensità del dibattito culturale che il regime totalitario, malgrado tutti suoi mali, era statoin grado di suscitare in questi ventenni.