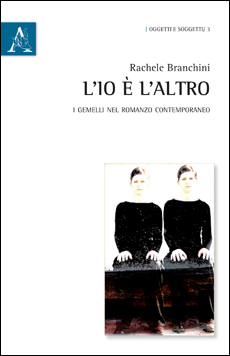Francofonia
L’Io e l’Altro. I gemelli nel romanzo contemporaneo.
Nella prefazione al volume, Franca Zanelli Quarantini apprezza particolarmente, fra i meriti del lavoro da lei introdotto, il titolo scelto da Rachele Branchini per la trattazione del tema della gemellarità nelle scritture contemporanee, esemplificate attraverso le opere di alcuni scrittori emblematici: Agota Kristof, Michel Tournier e Bruce Chatwin. L’Io è l’Altro potrebbe sembrare una banale variazione del titolo di Lejeune, “Je est un autre” (a cui certamente Branchini rinvia), ma la semplice variazione di un articolo cambia completamente la prospettiva del discorso: l’Io che è anche l’Altro vive in termini molto più drammatici il tema dell’identità e della ricerca disé, perché è costretto a percorre, per trovarsi o ritrovarsi, una via obbligata e pericolosa che non può maiprescindere da quella dell’altro che è parte di sé: «i gemelli funzionano come un congegno diabolicamente autoreferenziale: ogni fratello costruisce sull’altro la propria identità.Il lavoro è diviso in due parti, la prima delle quali costituisce una sorta di lunga, ma imprescindibile, premessa all’analisi del tema della gemellarità negli autori sopra citati, i cui risultati rappresentano un punto d’arrivo importante nel percorso di un tema, o di un mito, per dare voce alla complessità e all’ambiguità dell’io, attraverso uno dei fenomeni più perturbanti della storia umana: la compresenza di due io.In questa prima parte, costituita di due capitoli intitolati rispettivamente «Mitologie» e «Dal teatro al romanzo», Rachele Branchini ricostruisce, sia pure per sommi capi ma mai in maniera scontata, il percorso del mito gemellare dall’Antichità al Novecento, il secolo che decreta «la definitiva fortuna romanzesca dei gemelli, i quali assumono una propria autonomia tematica solo in seguito all’avvenuta metabolizzazione letteraria delle teorie psicanalitiche». La seconda parte è intitolata «Tra separazione e simbiosi: i gemelli nel romanzo contemporaneo», un titolo che sintetizza in maniera efficace il nucleo narrativo delle opere studiate. Il primo capitolo, «La Trilogie des jumeaux o della separazione», è dedicato ad una scrittrice ineludibile, Agota Kristof, che ha coagulato attorno a questo tema la sua difficile ricerca identitaria di donna e di scrittrice, in un gioco sottile e perverso di specchi, menzogne, mistificazioni, deliri onirici e desiderio fantasmato dell’altro («j’imaginais seulement que nous étions deux, mon frère et moi, pour supporter l’insupportable solitude»), in cui ben si riflette il marasma di un io che si fa scrittura per essere. Ma alla fine, come ben conclude l’analisi, molto acuta e per certi versi molto cruda, di Rachele Branchini: «assieme a Kristof, anche i gemelli hanno compiuto la loro parabola dalla parola ironica al muto cinismo» (p. 84).Segue un capitolo su Michel Tournier ed in particolare, come indica il titolo, «Le Météores o della sublimazione», sul romanzo della gemellarità, senza tuttavia ignorare il ritorno ossessivo dei gemelli in quasi tutta l’opera dello scrittore. Nelle Météores il tema assurge agli onori di una riscrittura alta e vitalissima del mito antico (come sappiamo Tournier non scrive, ma riscrive), perché l’autore ne fa una sorta di nuova cosmogonia, fondata sul trauma della spaccatura del nucleo primigenio e sulla ricomposizione dell’io «spaiato» in un’unità cosmica, che sana le fratture della storia e i conflitti del vivere «singolare». In conclusione, Brachini offre un’analisi davvero molto coinvolgente, e convincente, di uno dei più complessi romanzi del Novecento, in cui convergono, come sempre in Tournier, gli apporti di diverse scienze: antropologia, filosofia, storia, astronomia…, senza contare gli infiniti rinvii intra ed intertestuali: «Al pari del Saint-Esprit, sintesi tra il cielo del Padre e la terra del Figlio, essa [la gemellarità tournieriana] diviene il tramite attraverso il quale si sublima la frattura tra l’acronia del mito e il divenire della storia, tra la perfezione dell’Androgino e l’abiezione dell’uomo». Il volume si conclude con un capitolo dedicatoa Bruce Chatwin che non sarà analizzato qui in quanto esula dall’area francofona, ma che contribuisce efficacemente a comporre il panorama delle rivisitazioni novecentesche della gemellarità.Oltre all’intelligenza critica, il lettore non mancherà di apprezzare la chiarezza (che non è semplificazione)e la bellezza di una scrittura che sposa, senza sforzo e senza gerghi per iniziati, i meandri spesso oscuriin cui ci costringono ad inoltrarci le opere da lei studiate.
Link al sito