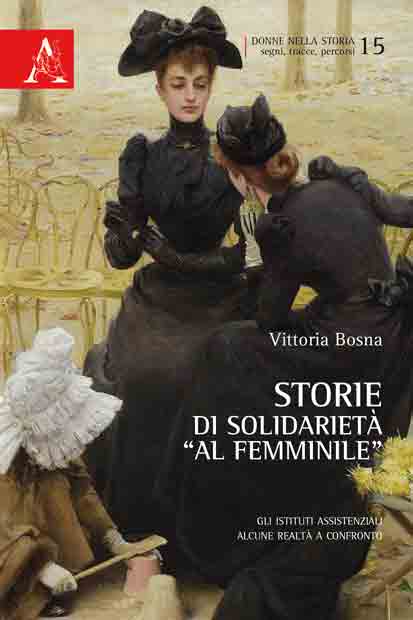Foro de Educación
Bosna, V. (2013). Storie di solidarietà «al femminile». Gli Istituti Assistenziali: alcune realtà a confronto. Roma: Aracne
Il lungo e tortuoso percorso dell’educazione femminile nell’Ottocento ci viene qui presentato da Vittoria Bosna la quale – fedele all’impegno di disvelare attraverso le sue ricerche eventi e fatti di ‘genere’ nella sua preziosa terra di Puglia – dipinge uno spaccato quanto mai interessante di alcune istituzioni rivolte esplicitamente alle piccole orfane che venivano così «tolte alla corruzione dei trivii e spinte sulla via della religione e della virtù». Il fecondo lavoro sulle fonti d’archivio recuperate ed attentamente analizzate offre un panorama che si uniforma senza alcun dubbio alla storiografia più accreditata: in primis va rilevato, come Bosna ben suggerisce nella prima parte del suo libro, la critica situazione di endemica povertà di molte zone del Mezzogiorni all’indomani dell’Unità d’Italia, le cui vittime designate paiono essere in particolar modo i bambini. Indici altissimi di mortalità infantile, la miseria morale dei genitori, l’idea della scarsa o nulla importanza dell’infanzia incontrano un loro potenziamento negativo allorquando andiamo a verificare le reali condizioni di vita e di esistenza in cui si trovavano a vivere questi pargoli. Soluzioni di efferata crudeltà come l’infanticidio, l’abbandono e la «ruota» paiono normali nell’epoca presa in considerazione: in tale contesto di notevole emergenza sociale si fa più presente il ruolo delle istituzioni benefiche dapprima esclusivo appannaggio della gerarchia ecclesiastica, in seguito a carico degli enti comunali che, sempre più coinvolti nella gestione umana e sociale del territori loro assegnati, si trovano a fronteggiare situazioni a dir poco drammatiche. Lo snodo fondamentale per rispondere a tali esigenze passa attraverso un efficace pragmatismo che tenta di dare risposte operative ai bisogni: le istituzioni non restano dunque insensibili bensì attivano processi di accudimento, educazione, assistenza.Come è ampiamente noto, la situazione delle bambine rappresenta una doppia inferiorità: marchiate da una condizione di sudditanza dalla concezione patriarcale e misogina, sono mantenute nell’impossibilità di avere un’identità propria a causa della mancanza assoluta di percorsi di alfabetizzazione e di istruzione che, dopo l’Unità, paiono ancora nebulosi e difficili da attivare, pur nel rispetto formale della legge Casati. All’assenza dello Stato corrisponde fortunatamente la presenza degli enti, delle opere pie, di filantropi caritatevoli che, animati da zelo cristiano, offrono alle fanciulle una diversa prospettiva di vita. Sottolineo con piacere il ruolo dell’istituto «Maria Cristina di Savoia» che a Bitonto ospitava le orfane, dando ricovero ed educazione a numerose bambine del territorio circostante: Bosna ne analizza i documenti, le carte d’archivio per restituirci anche la sequenzialità della vita quotidiana per le piccole ospiti all’interno del bel palazzo ottocentesco. Seppur in linea con la struttura ed i regolamenti degli orfanotrofi del tempo, ne viene rimarcata la necessità di fornire alle fanciulle una buona preparazione nei famosi «lavori donneschi» che ne avrebbero fatto buone spose e buone madri, una volta uscite per il matrimonio, oppure al fine di garantirsi un salario andando a servizio presso le case dei nobili. La massima cura era riposta anche nel corretto uso del tempo e nel rispetto ossequioso alle regole che scandivano le ore della giornata: il magro vitto, il lavoro di cucito e ricamo, le devozioni religiose. Sorprende positivamente la presenza di un percorso – seppur breve e limitato – d’istruzione di durata biennale, iter che poteva prolungarsi per ben due anni ulteriori e dava la possibilità di conseguire la «patente» di maestra. Le giovanette migliori, per condotta e studio, venivano adeguatamente selezionate perché frequentassero la Scuola Normale a Bari, a spese dell’amministrazione provinciale. Si innesca in tale positivo frangente un meccanismo che darà i suoi fertili frutti per la creazione di una specifica identità femminile: la maestra, lungi dall’essere l’esile e povera maestrina di tanta letteratura tardo ottocentesca, è il primo passo di un sentiero di emancipazione che sfocerà nella ridefinizione dei diritti delle donne all’alba del Novecento, un piccolo seme che darà buoni frutti.Procedendo quindi alla seconda realtà esaminata da Bosna, ci troviamo di fronte ad un altro pregevole esempio di filantropia, ovvero la fondazione dell’orfanotrofio femminile «Il boccone del povero» a Palermo, il cui fine prioritario consisteva nel garantire la formazione al lavoro per le giovinette ospiti della struttura. Non mancava la considerazione per gli aspetti morali della crescita, l’enfasi sulla virtù, sulla morigeratezza e sulla devozione religiosa.In conclusione, mi preme lumeggiare l’impegno dell’Autrice nello scavo attento e minuzioso delle fonti al fine di ricostruire la genesi e l’esistenza di tali istituzioni che, pur con evidenti limiti dovuti alla scarsità di fondi, alla troppo spesso miope gestione politica, hanno rappresentato un’opportunità per quelle bambine che, se lasciate ai margini, non avrebbero avuto alcuna possibilità di riscatto e sarebbero diventate facili prede del vizio e della corruzione. Questo libro vuole essere dunque una preziosa testimonianza per approfondire la storia dell’educazione delle bambine nel Mezzogiorno postunitario.Antonella Cagnolati
Link al sito