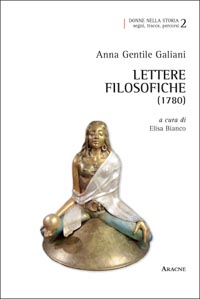LeggereDonna
Le Lettere filosofiche di Anna Gentile Galiani, recentemente riedite da Aracne nella collana “Donne nella Storia: segni, tracce, percorsi”, rappresentano un nuovo tassello del pregetto di costruzione di una tradizione al femminile al quale Antonella Cagnolati partecipa con la direzione di questa collana. La cura delle Lettere è stata fatta da una giovane ricercatrice, Elisa Bianco, che, nell'ambito dei suoi studi dediti all'Illuminismo, ha scelto di focalizzare l'attenzione sul pensiero e sulla vita di una donna: Anna Gentile Galiani, una delle figure più interessanti del dibattito intellettuale svoltosi nella Sicilia del Settecento. Si tratta di una figura emersa nonostante i pregiudizi nei confronti del sesso femminile fossero, a quel tempo ancora molteplici. Il loro peso si fa sentire anche nelle pagine di questa pubblicazione: sono presenti nella stessa nota introduttiva dell’editore settecentesco (il napoletano Giacomo Antonio Vinaccia che ha pubblicato le lettere nel 1870) dove l’interlocutore maschile dell'epistolario viene presentato non come un partner alla pari ma come un uomo d'ingegno per il quale il dialogo rappresenta una sorta di divertissement al quale dedicarsi “in qualche momento di suo ozio”. Inoltre, le capacità intellettuali di Anna Gentile Galiani – di una giovane che vie chiamata “mia musa” dal suo interlocutore e di cui viene ossessivamente sottolineata la gentilezza e la grazia femminile del carattere – vengono giustificate ricorrendo alla classica figura della “donna d'eccezione” che si eleva grazie a “un ingegno superiore al suo sesso” e che in questo modo, nel ruolo di “eccezione”, conferma l’inferiorità e l’inadeguatezza di tutte le altre.
All'interno di questa lettura comincia però a farsi una strada una diversa valutazione politica relativa al ruolo che il fattore “educazione” viene ad avere nella costruzione dell'identità e nella formazione delle capacità intellettuali, discorso questo che, anche se solo accennato – “una donna, mediante la buona educazione può innalzarsi sopra delle altre” –, contribuisce a sferrare i primi decisivi colpi al modello essenzialistico a partire dal quale sino a quel momento è stata legittimata e avvalorata l’inferiorità delle donne.
Diversi sono gli ambiti del sapere che nel Settecento vedono l’affermarsi della partecipazione femminile: la scienza, la letteratura, la poesia, la musica. Anna Gentile Galiani si è inserita però in uno dei filoni più ostici dell'emancipazione di genere: la filosofia, che dalla Grecia antica sino all'epoca contemporanea è stata una delle discipline più collaborative nella legittimazione teorica delle pratiche di subordinazione del sesso femminile a quello maschile. Da Aristotele fino a Rousseau il leitmotiv è stato infatti il medesimo: la donna, dominata da passioni e sentimenti è incapace di essere soggetto razionale e per questo deve essere confinata entro la sfera domestica dedita ai compiti di cura.
Nel dibattito settecentesco che vedeva la contesa tra i materialisti da un lato, e dall'altro i razionalisti che esaltavano il ruolo della ragione e della sfera spirituale, Anna Gentile Galiani, che ignorava il carico di pregiudizi attraverso i quali era stata normata la soggettività femminile, prende posizione per la seconda delle opzioni. Gran parte delle riflessioni presenti nelle sue lettere ruotano infatti intorno a questo tema. Nella disputa con il suo anonimo interlocutore, convinto materialista e sostenitore della “bontà” delle passioni, la nostra filosofa difende la ragione e il suo potere disciplinante sulle passioni come strumento decisivo nell'emancipazione di genere. In realtà Anna Gentile Galiani parla a nome del genere umano e dell’umana natura ma è evidente che nell'argomentazione di cui si fa portavoce emerge il suo bisogno di riscatto del genere, il suo desiderio di liberarsi da una condizione sociale di subordinazione tutta giocata sulla negazione delle capacità di raziocinio. Esaltando il ruolo della ragione rispetto alle passioni vuole dimostrare al suo interlocutore la sua dignità di essere razionale capace di pensiero, di giudizio e di riflessione al pari del soggetto maschile.
Nel gergo del femminismo novecentesco della differenza si potrebbe a ragione sostenere che l’autrice sta scegliendo la cooptazione rispetto al discorso maschile, rinunciando a una valorizzazione della propria identità e specifica, salvo riconoscere che questa cooptazione è un passaggio necessario e inevitabile per qualsiasi tipo di discorso: la rivendicazione del diritto al giudizio e alla parola razionale, registro questo su cui si gioca tutta l’argomentazione della filosofia, è infatti il diritto che garantisce tutti gli altri, sia quelli espressi nel termini dell'uguaglianza sia quelli intesi come valorizzazione della differenza. Se, come si interroga Elisa Bianco nella sua “Introduzione” all’epistolario, si volesse andare alla ricerca delle implicazioni in termini di filosofia che queste lettere custodiscono è a questo decisivo versante del suo discorso che si deve guardare, perché se è vero che la difesa del razionalismo filosofico è un’opzione di origine maschile, quando è rivendicata da una donna del Settecento, priva del diritto alla parola, assume un ruolo che trascende i suoi significati originari e diviene più rivoluzionaria del materialismo del suo interlocutore. Costui può infatti dichiararsi sostenitore del primato del corpo e delle passioni perché la ragione è una facoltà che gli appartiene per nascita. Per Anna Gentile Galiani il significante “materialismo” è invece troppo pericolosamente contiguo ai pregiudizi misogini del suo tempo: la riduzione del sesso femminile a mera natura, corpo e istinto, sprovvisto, al pari degli animali, delle alte facoltà dello spirito. Ciò a dimostrazione della non univocità dei significanti, che acquistano significati diversi a seconda del contesto a cui appartengono e che, compresi in questa prospettiva, possono aiutarci a risolvere alcuni apparenti dilemmi di genere del nostro tempo: minigonna sì/minigonna no, velo sì/velo no, maternità sì/maternità no, più intelligibili se si considera il contesto di senso entro cui avvengono queste rivendicazioni.
Link al sito