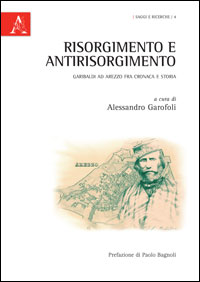Aerrecom
Garofoli: "Garibaldi ad Arezzo fra cronaca e storia "
I numerosi studi compiuti nel 150° dell’Unità hanno confermato che gli eventi che compongono la storia d’Italia si prestano a interpretazioni non sempre conciliabili. Altrettanto si dica dei protagonisti. Uno di questi è Garibaldi, “eroe dei due Mondi” per gli uni, volgare brigante per gli altri. Può essere interessante, allora, vederlo sullo sfondo di una città di provincia, studiare le reazioni che provoca nel tempo. Per verificare che il Risorgimento è un lungo processo di crescita. Su questa linea si orientano gli autori di questa raccolta di saggi. Descrivono l’atmosfera in cui si muove Garibaldi in Toscana fino all’Unità, ricostruiscono gli influssi sulla vita postunitaria, sottolineano un tipico esempio di contraddizione fra Risorgimento e Antirisorgimento: da un lato Arezzo che “chiude le porte in faccia a Garibaldi”, dall’altro il fiorire del garibaldinismo in città e provincia.
Risorgimento e Antirisorgimento. Garibaldi ad Arezzo fra cronaca e storia, ARACNE, Roma, 2012, a cura di A. Garofoli, Prefazione P. Bagnoli; Contributi di L. Armandi, G. Galli, A. Garofoli, R.G. Salvadori.
Uno dei meriti delle celebrazioni del 150 anniversario dell’Unità - scrive Bagnoli nella Prefazione - è aver provocato un risveglio di natura storica. In questo clima si colloca il volume che parla di Garibaldi e Arezzo, curato da Alessandro Garofoli. A onor del vero non c’era necessità della ricorrenza per rinnovare l’interesse per una figura che non è mai passata dalla gloria al dimenticatoio della storia nazionale essendo un elemento unificante la vicenda complessiva del nostro Paese dal Risorgimento fino alla Resistenza, ma anche nell’Italia democratica l’attenzione per Garibaldi è stata sempre viva tanto che, considerate le targhe e i monumenti sparsi in tutta Italia, la memoria ha accompagnato i centri e le periferie d’Italia.
Garibaldi è studiato in relazione ad Arezzo, che con il processo unitario ebbe un rapporto complesso di cui il volume analizza specificità, contesti e relazioni; mettendo in mostra come, tra la città e il generale, sia rimasto per anni un contenzioso successivamente riscattato anche se, come avviene in casi del genere, si possono trovare massicce porzioni di retorica che, però, vanno anch’esse contestualizzate. Questo volume lo fa con piglio di argomentazione storiografica certa e meditate connessioni dovute alla temperie politica del momento.
Intorno al tema emerge un contesto storico territoriale di grande interesse, perché gli studi concorrono ad arricchire la storia stessa della città. Non si tratta di un libro che affoga nelle spire del patriottismo, bensì uno studio che, nell’evidenziare luci e ombre, conferma quanto la conoscenza del Paese richieda sforzi di ricerca e ricostruzione critica, trattandosi di una storia complessa la cui morale ribalta l’idea che fatta l’Italia bisognasse fare gli italiani perché furono questi ultimi, con le loro storie, problemi, tipicità che la fecero, ma un Paese così ricco di peculiarità quale è l’Italia, è un cantiere sempre aperto nonostante i tanti eventi, anche di rilevanza primaria quale la nascita della Repubblica e della democrazia politica, che lo hanno segnato positivamente. Dentro la profondità di questa multiforme storia complessiva, Garibaldi e il “garibaldinismo” - dice questo libro - non sono mai stati un fattore del passato ma un presente continuo per portare a sintesi la coscienza nazionale, presupposto perché un Paese si senta nazione e viva civilmente.Di Garibaldi è stato raccontato molto, con incremento considerevole dopo il centenario della nascita. Ciò nonostante la grandezza indiscutibile e alcuni momenti non chiariti o dimenticati, fanno sì che si debba scrivere su di lui. L’azione incessante orientata in più direzioni, la varietà e quantità di fonti e interpretazioni, la caratterizzazione e la distanza dei luoghi che l’hanno visto protagonista, la copia degli uomini con cui si è relazionato, continuano a stimolare ricerche. Immaginiamo la ricostruzione virtuale - sarebbe agevole grazie all’informatica - di un’immensa cartografia universale con i transiti fisici e l’indicazione dei siti influenzati, anche indirettamente, dalle sue idee e dalla fama. Fra le apparizioni in scenari minori indagate in maniera incompleta, prima di questo volume, stavano i transiti dell’eroe da Arezzo: 1849 e 1867, soprattutto il secondo. Più in generale il garibaldinismo nel territorio ’800 e ’900.
Le visite sono pagine minori della biografia ricchissima di Garibaldi. Oggetto di una sorta di rimozione collettiva, storiografica e della memorialistica, sono centrali per la comprensione dell’Ottocento aretino. Accanto allo spessore dell’uomo si prestano a delimitare un segmento temporale fra un primo e un secondo momento della storia della città che, oltre al significato intrinseco degli avvenimenti, offre la cartina al tornasole delle trasformazioni socio-politiche: la modernizzazione del pensiero e delle strutture civiche. Il passaggio del comandante dei Mille ha contribuito ad alterare equilibri potestativi statici, dando vigore ed entusiasmo alle forze locali intenzionate a muoversi per il progresso. Il rappresentante istituzionale era il sindaco Mori.
La prima tappa, il 1849, è la più nota. Sorgente di discussioni mai sopite, si scrisse nello stesso secolo. Una pagina ingloriosa del rapporto fra Arezzo e il movimento unitario. Anticipava gli esiti poco patriottici del plebiscito in provincia, fra i peggiori della Toscana. L’accoglienza semi trionfale di diciotto anni dopo si propose perciò come il dovuto riscatto rispetto alla storia d’Italia. L’attestazione dello stadio d’inserimento identitario della comunità nel Risorgimento.
Le due vicende hanno il comune denominatore Roma, progetto irrinunciabile per il nizzardo. Le comparazioni dei tempi storici e dei fatti codificano i cambiamenti avvenuti nell’uomo, nella patria e nel contesto locale, riformulato in maniera radicale. Quel generale che parte nel 1867 per la “passeggiata” ad Arezzo (così la chiamò), ancora indomito nella volontà, è un anziano leone verso il tramonto fisico, in auge invece nella gratificazione encomiastica tributatagli dalla popolazione. Garibaldi 1867 era sospeso fra storia e mito, diventando lui stesso un luogo della memoria.
Il testo assembla l’apparato scenografico nel quale gli attori aretini dei fatti raccontati hanno orientato le opinioni nei suoi confronti. Sull’influenza garibaldina, sulla continuità della fama e della presenza fantasmatica dell’eroe, post mortem, sempre più strumentalizzata, ha dato conto Giovanni Galli su Garibaldini e tradizione garibaldina in Arezzo. Il Garibaldi universale, a global hero mediatico che già in vita vestiva i panni del “personaggio dello star system”, è associabile, a vantaggio del nostro, al Buffalo Bill d’oltreoceano (più folcloristico e paracircense). Nel 1907 “La troupe di Buffalo Bill’s” si esibì al Petrarca guadagnando il sarcasmo progressista che costatava gli aspetti farseschi. Nella caricatura dell’americano la somiglianza con Garibaldi è impressionante, non casuale: la parodia dell’intrepido connazionale.
Ogni luogo, anche il più insignificante e sperduto, si arricchiva di notorietà e gloria al transito dell’italiano, era sopraelevato a fonte d’orgoglio per i cittadini, che sentivano d’insinuarsi a tempo indefinito nelle pagine della Storia. Così fu per Rapolano, Sinalunga, Foiano, Arezzo, Pozzo della Chiana, Chiusi, Poggibonsi, Figline, Montepulciano. Il municipalismo stabiliva una congiunzione con la fresca avventura statale.
Pur incardinato nel ceto che contava, il garibaldino Guiducci afferrò al volo il pretesto per rinnovare i lamenti, costanti negli eruditi, sulle condizioni del regno e del territorio. Nel guado fra la grandezza del duce delle camicie rosse e il martirio di tanti da una parte, il disagio per le tristi condizioni dall’altra, stavano le speranze disattese, il fastidio per la classe politica inadeguata. Tenace assertore d’italianità, Guiducci ultrasettantenne sentiva vivi gli entusiasmi dell’epopea e l’orgoglio d’aver indossato la camicia rossa.Lo scoramento, inquietudini in parte affrettate, avvicinavano la Sinistra, con i contorni del “Risorgimento tradito”, ai critici della Destra aretina. Il contrasto fra ideale e realtà in progress era sentito e inquietante. I pregi sublimi dell’epoca al tramonto stridevano con la mediocrità, la pochezza del quotidiano, il grigiore politico. Ai vecchi dovevano sostituirsi nuovi eroi, nella gestione della cosa pubblica, nell’imprenditoria, nel magistero, nelle scienze e lettere, nell’obbedienza alle leggi, nel rispetto e identificazione con patria e nazione, nel senso dello Stato.
Fra le righe che rievocano il valdarnese Dendi, morto per le ferite di Bezzecca, si legge dall’Armandi che “spirò, soddisfatto nell’udire che il corpo dei volontari era vittorioso”. Il fine sommo sublimava la consapevolezza dell’exitus. Salvifico rispetto ai dolori dell’anima patriottica, superiori a quelli della caduca corporeità: “La morte gli risparmiò il dolore della pace di Villafranca.” La politicizzazione della morte: l’obiettivo, la conquista morale e collettiva, anestetizzava l’agonia e la consapevolezza della dipartita.Perticucci, Arezzo città, era attualizzato da “L’Appennino” sostanziando uno dei numerosi casi di confronto sconfortante fra il passato prossimo, eroico, e la vita del luogo. Unitosi a Garibaldi, all’Italia aveva dedicato la gioventù: “dedicato” non rinunciato, a certificare il dono volontario, entusiasta. Della libertà, in tutta l’onorata esistenza, aveva “un culto sincero”.
L’affronto demoralizzante della memoria collettiva e la scarsa riconoscenza per il dono della vita e degli anni migliori, degli interessi personali e familiari, affiorano in più circostanze. “L’Appennino” nel 1907 estrae dall’anonimato Aniceto Masciadri, deceduto da pochi giorni. Tornato a Montevarchi dopo aver dato un largo tributo alla patria, è dimenticato e vive in modesta posizione, finché un “soffio di fortuna” lo porta all’ufficio di custode dell’Ospedale, ove venerazione di tante benemerenze lo tennero “fino all’ultimo di sua esistenza grama”. Il corsivo di “custode”, corroborato dal “soffio di fortuna”, sottolineava il credito inevaso di gratitudine verso i costruttori del presente. D’altronde nel medesimo interesse del popolo, Garibaldi aveva anteposto al suo credo e agli interessi personali, il fine sommo. Di tempra del tutto diversa appariva, alla vista di testimoni coevi come Guiducci, il litigioso ceto dirigente.
Francesco Gressi, anghiarese benestante, morì povero “perché trascurò i propri interessi per correre a combattere per l’indipendenza e perché di cuore generoso soccorse gli amici e i miseri fino alla prodigalità.” Aveva fatto la campagna del ’48, l’anno dopo era stato sergente a Roma per la Repubblica, nel ’59 si metteva in luce a S. Martino, nel ’66 aveva operato nel doloroso ruolo di foriere della Guardia nazionale contro i renitenti alla leva.
Se penalizzato da semplificazioni il Risorgimento rischia di risolversi in un affaire di ristrutturazione geopolitica. Non fu solo questo: la luce che brillava nei poco più che adolescenti pronti a rischiare la vita, significava unire l’Italia ma molto altro: una società più libera, equa, giusta e (si direbbe oggi) solidale. Un futuro roseo per la collettività, il congiungersi con le nazioni evolute, un raccordo ideale con il passato, preparare il terreno per il progresso; la fine dell’oppressione straniera.
Essere ferventi patrioti prima del 1861 ad Arezzo non era facile. All’occhiuta vigilanza della pubblica sicurezza si aggiungeva l’aridità del notabilato allergico al cambiamento, un humus sociale tradizionalista. Il trattamento riservato a Garibaldi sul finire degli anni ’40, allorché gli furono serrate le porte della città o, qualche anno dopo, marzo 1860, l’esito sconfortante del voto per l’annessione, erano prove non opinabili. Merito dell’Armandi è aver scoperto una partecipazione forte. Dopo il 17 marzo 1861 non tutto andò per il verso giusto. Nel privato alcuni patrioti raggiunsero i vertici della vita pubblica o delle professioni liberali. Furono bravi e onesti artigiani. Tipografi, falegnami, fabbri, panificatori, barbieri, sarti, artisti, commercianti. Le preferenze li smistarono su strade diverse, accendendo una prassi politica anche dura: liberali moderati, progressisti, democratici, mazziniani; più avanti socialisti, anarchici.
L’arrivo della ferrovia e l’edificazione della stazione posero la pietra tombale sull’isolamento delle comunicazioni. Innescarono conseguenze economiche con il corollario di modificazioni sostanziali della struttura urbana. Incrementando i traffici, facilitando il raggiungimento delle capitali. Aprendo le menti, accorciando le distanze. Crescevano con andamento impetuoso nuove associazioni. Si erigevano scuole. istituti bancari cominciavano a sostenere l’imprenditoria e a togliere dagli aguzzini tanti disgraziati. Si estendeva il voto, emergevano raggruppamenti politici, si organizzavano mostre industriali e agrarie, era potenziata la formazione professionale, si affacciava la meccanizzazione. S’illuminavano le vie applicando le conquiste della scienza, migliorando l’igiene con la rete fognaria, distribuendo acqua potabile, spingendo la sanità verso livelli decorosi. Si potevano manifestare le opinioni con libertà accettabile. Con movenze prudenti, camminando su un viottolo irto di ostacoli, su tutti la mancanza di risorse, al tramonto degli anni Settanta la modernizzazione era iniziata.
Giabbani, Dendi, Ghignoni morto ragazzo sul Volturno e gli altri caduti potevano riposare in pace. Il martirio non era stato vano. I patimenti della figura oblativa che per Banti era la mater dolorosa, “simbolo della positività del sacrificio”, trovavano risposte sulla via crucis del lenimento del lutto. Il fine aveva giustificato i mezzi. Se Garibaldi del secondo approccio con Arezzo non era il medesimo del ’49, la città che l’aveva respinto lo accoglieva con calore nel 1867 mentre era impegnata in uno straordinario sforzo di trasformazione. L’incedere verso l’età contemporanea, cesura per Arezzo databile 1882, apriva gli occhi di un numero sempre maggiore di aretini sul significato della resurrezione italiana e lo spessore del demiurgo più amato e demonizzato.
I nodi da sciogliere per verificare la fedeltà della provincia alla patria sono essenzialmente due. Da un lato affiorano i valorosi. Una gioventù d’eccellenza che offre buona prova in più ambiti: i campi di battaglia diventarono palestre per il futuro impegno civile. Un nucleo non esiguo, specie se proporzionato alla popolazione più valida della comunità, conferma l’Armandi inserendo nel testo una nutrita lista ragionata. Dall’altro versante i protagonisti del Risorgimento aretino agirono in uno spazio pubblico sostanzialmente amorfo e gretto (su questo Salvadori ha tutte le ragioni). Trincerato in difesa di privilegi e dello status quo.Fatta l’Unità i reduci portarono energie, l’esperienza del contatto con mondi e individui non consueti per lingua, etnia, tradizioni. Si proposero come soggetti emergenti dando vigore alle sollecitazioni della modernità. Gli ostacoli che si frapposero alla loro azione furono vari, non escluse le sembianze bulimiche degli appetiti in gioco, degli affari, degli appalti.
Le simpatie per il Partito d’azione permearono gli atti dei progressisti e continuarono a spaccare la polis in tutto il secolo, adottando come terreno di scontro l’indirizzo verso cui orientare associazioni mutue e cooperative, la stampa, le preferenze circa gli anniversari da celebrare, l’espansione della memoria del Risorgimento. Affiora la successiva storia politica cittadina. Una città addormentata è svegliata da volontari imberbi o non più tali che ricevono linfa, stimoli e una scossa energetica dall’apparizione garibaldina del 1867. Per trainare il progresso. Se il mito di Garibaldi “impersonificò quattro momenti caratterizzanti il secolo al quale appartenne”, nazione, popolo, volontariato e associazione, lo schierarsi pro o contro l’arrivo, soprattutto nel ’67, dava l’idea del come porsi soggettivamente e programmaticamente rispetto ai quattro momenti.
Tirando le fila del ragionamento le visite di Garibaldi costringono a prendere posizione. In circostanze ad alta tensione emotiva, le schiere favorevoli o contrarie al garibaldinismo si compattano. Per anticipare le difficoltà della ricostruzione, ecco le riflessioni di Galli: al tramonto dell’Ottocento la memoria del prode per eccellenza assume “una forte centralità come forma unificante delle varie forze politiche democratiche, radicali, repubblicane e socialiste,” quelle forze che “contendono la direzione del comune ai moderati, divenuti poi clerico-moderati”. Negli stessi anni la sinistra aretina contribuiva alla costruzione del mito di Garibaldi con modi differenti rispetto agli avversari: “Lo diffondono e tramandano, lo fanno penetrare nel sentimento comune e gli fanno acquistare centralità politica e non pochi aspetti polemici nelle celebrazioni del 1907 e 1912”.
Lecito valutare meriti e demeriti del patriota. Tuttavia è plausibile il quesito se l’Italia, non di rado irriconoscente, sia stata in seguito in grado di proporre una personalità capace di seguirne le orme. Con i limiti, gli errori, le ossessioni, la faziosità. Cercando di sciogliere il nodo di quale ruolo la memoria della tradizione garibaldina abbia occupato “nelle culture politiche del Paese e nell’uso pubblico della storia, specialmente durante alcuni snodi cruciali della vita nazionale.”
Link al sito