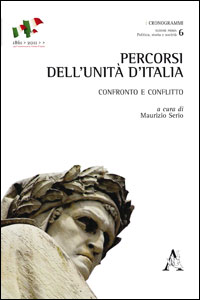Il Borghese
Percorsi dell'Unità d'Italia
«All'atto dell'unificazione», scrive Paolo Savona, ex direttore generale di Confindustria e ministro dell'industria nel Governo Ciampi (1993-1994) nel suo contributo al saggio, appena pubblicato da «Aracne editrice», «fu commesso un errore monetario, non si sa se consapevolmente o per ignoranza: il rapporto di cambio tra la lira sabauda e la lira tornese fu stabilito alla pari, mentre sarebbe dovuto essere maggiore, forse nell'ordine di 4. Si potrebbe avanzare l'ipotesi che il sottosviluppo meridionale possa trovare spiegazione, in tutto o in parte, in questo errore, dato che, per la natura dello sviluppo dell'epoca, il livello di attività economica del Sud non era inferiore a quello del Nord» (P. Savona, I complessi intrecci reali e finanziari Nord-Sud che caratterizzano il nostro modello di sviluppo, p. 17). La citazione, che si potrebbe benissimo anche utilizzare, sovrapponendo i relativi termini, per lo scenario verificatosi con la conversione della lira all'euro, rappresenta solo uno degli esempi offerti da uno studio serio, di carattere storicoeconomico- istuzionale, come quello presentato in Percorsi dell'Unità d'Italia, che raccoglie i contributi scientifici emersi nell'omonimo convegno, svoltosi il 7 giugno 2011 all'Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma. Sulla stessa linea di Savona, ma con strumenti analitici differenti, sono anche i contributi di due giovani ricercatori come Mario Ciampi, Foedus e nazione nel federalismo italiano (pp. 27-32) e Maurizio Serio Il meridionalismo del nuovo millennio (pp. 33-46), che denunciano la scarsa aderenza alla realtà di molte ricostruzioni ideologiche del «Risorgimento ». Anche ad avviso di un altro relatore al convegno, Tommaso Valentini (cfr. Augusto Del Noce: il Risorgimento come «rivoluzione liberale» e «restaurazione creatrice», pp. 57- 80), in molte letture storiografiche di questo tempo è stata spesso trascurata l'importanza che avrebbe potuto avere l'opera dell'abate Antonio Rosmini (1797-1855), se recepita dai liberali, ai fini della riunificazione italiana. Ha argomentato e documentato questa tesi il grande filosofo Augusto Del Noce, il quale ha individuato nel pensatore roveretano uno dei vertici del Risorgimento filosofico italiano, come riscoperta dell'ontologismo e come rinnovamento della stessa vita democratica italiana fondata su una nuova filosofia della libertà. Che a prevalere sia stata invece una impostazione di «Realpolitik» lo hanno rilevato persino osservatori coevi come i russi Aleksandr Herzen (1812-1870) e Nikolaj Dobroljubov (1836-1861), la cui lettura risulta decisiva secondo Roberto Valle (cfr. La disunità d'Italia. Herzen, Dobroljubov e il Risorgimento, pp. 91-102) per comprendere la filosofia del Risorgimento. Di grande interesse ed originalità è poi il contributo di Giuseppe Casale, intitolato L'idea corporativa nel Risorgimento: una tradizione "inventata (pp. 113-144), nel quale si avanza l'ipotesi di un'idea corporativa connaturata alla tradizione civile italiana e volta a realizzare una compenetrazione effettiva tra individuo, società civile e istituzioni politiche.