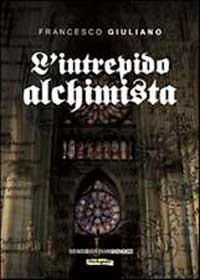La chimica e l’industria Web
L’intrepido alchimista
L’intreccio è nella tradizione dei romanzi di formazione: il secondogenito di una famiglia baronale siciliana,predisposto per nobiltà d’animo ai buoni sentimenti e per curiosità intellettuale all’apprendimento dedicherà la propria vita (1639-1693) allo studio di una disciplina figlia dell’alchimia, anche se la chimica più che arte è scienza, riuscendo per via sperimentale ad individuare quello spirito aereo che Lavoisier (1777) chiamerà “ossigeno”. Scelta senz’altro intrepida in un periodo in cui alla Chiesa definire gli alchimisti stregoni faceva comodo e in un luogo dove «della parola libertà non si conosceva né il nome né il significato. Nella molteplicità degli spunti speculativi offerti dalle 160 pagine dell’opera, tra i quali delle autentiche perle per gli appassionati di chimica (sul sapone, sull’olio di vetriolo, sull’argento vivo ecc.), ne segnaliamo due di sicuro interesse per i lettori: la ricostruzione storica dell’affannosa affermazione di questa nuova scienza e l’individuazione dei requisiti personali ed ambientali per una ricerca efficace. Riguardo alla prima questione, dobbiamo porci la domanda: perché la chimica ha trovato così grandi difficoltà ad emergere? La risposta non è né banale, come per labiologia (evoluzionismo vs. creazionismo), né scontata, come fu per l’astronomia (eliocentrismo vs. geocentrismo). La chimica sembrerebbe sostanzialmente innocua, cioè priva d’elementi di contrasto con i dettami della Bibbia secondo la tradizione tomistica. E allora? La risposta di Francesco Giuliano è articolata lungo tutto il romanzo. La tesi unitaria si può riassumere così: al pari delle altre scienze, anche la chimica dovette partire dalla ricusazione delle fuorvianti concezioni aristoteliche in merito alla composizione della materia» come, ad esempio, che il mondo su cui viviamo sia costituito solo da quattro principi fondamentali: aria, acqua, terra e fuoco o che ogni corpo ha un peso ad eccezione del fuoco che si dirige verso l’alto. Purtroppo, lungi dall’essere considerato una mera interpretazione della realtà, emendabile alle prime incongruenze, l’aristotelismo era diventato la malta che teneva uniti i mattoni di un potere autoritario e criminoso alimentato dalla sopraffazione e lo sfruttamento e responsabile «della fame di tanti e del benessere di pochi. Aristotele aveva favorito la Chiesa nelgenerare sudditanza; metterne in dubbio la filosofia (chi professa o studia l’aristotelismo, altro non è che un ignorante) voleva dire attaccare gli apparati ecclesiastici e, per un connubio divenuto indissolubile nell’Ancient Régime Questa educazione trasmette la convinzione che la società sia basata su una scala gerarchica, al cui apice ci sono i preti e i nobili), anche i governanti di turno L’affermazione della chimica ha richiesto alla scienza e la filosofia di affrancarsi dalla religione e alla società di emanciparsi democraticamente dai potentati laici e clericali ed intellettualmente dai dogmi e dagli stereotipi perché dalla libertà di pensiero dipende qualunque altra forma di libertà. [...]