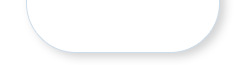Teoria dei sistemi e complessità
Collana diretta da Andrea Pitasi
Collana diretta da Andrea Pitasi
Dagli studi di von Bertalanffy in biologia, agli scritti di Wiener e Ashby a fondazione della prima cibernetica, dalle pagine di Buckley sulla teoria dell’informazione a quelle di von Foerster per lo sviluppo di una cibernetica di secondo ordine, dalla sociologia costruttivista di Luhmann al campo olografico di Laszlo, dagli studi nelle scienze dell’organizzazione di Crozier e Friedberg alle riflessioni epistemologiche di Delattre, la teoria dei sistemi è una delle principali protagoniste intellettuali del XX secolo e, all’alba di questo terzo millennio, si conferma uno strumento concettuale potentissimo per l’evoluzione socio-economica dell’umanità. Come scrive brillantemente proprio Delattre: La teoria dei sistemi ambisce ad agire allo sgretolamento dei saperi e a sviluppare una metodologia all’altezza delle sfide della complessità [...]. Dopo la fase di decostruzione delle vecchie discipline [...] è diventato oggi indispensabile procedere ad una nuova sintesi delle conoscenze secondo un principio di unificazione necessariamente differente da quelli precedenti poiché deve essere adeguato ad altri livelli di apprendimento (P. Delattre, Teoria dei sistemi ed epistemologia, Einaudi, Torino 1984, pp. 3-5) e in tal senso, appunto, la teoria dei sistemi si è rivelata un modello concettuale formidabile anche per la sua plasticità evolutiva e adattiva per esempio attraverso il paradigm shift da una logica tutto/parti a una logica sistema/ambiente. Essa rivela la sua grande potenza euristica nel creare modellizzazioni concettuali interdisciplinari fondamentali per sviluppare analisi di scenario globale, strategie evolutive dotate anche di un adeguato impianto predittivo su base probabilistica e interventi tattico-operativi di problem solving che l’hanno resa applicabile anche in varianti più divulgative come quella di Paul Watzlawick e i suoi collaboratori. La teoria dei sistemi, inoltre, essendo a sua volta evolutiva, come testimoniano le splendide ricerche di Ford e Lerner, si presta a creare modelli concettuali glocali in grado, cioè, di gestire le complesse dinamiche di globalizzazione e localizzazione, di integrazione e differenziazione che contraddistinguono l’evoluzione auto-organizzativa del vivente. Come scrive saggiamente lo stesso Delattre (ivi: pp. 15-16): il carattere interdisciplinare della teoria dei sistemi implica lo studio e il confronto dei metodi e dei concetti utilizzati dalle diverse discipline per isolare il sostrato comune capace di costituire l’ossatura di un linguaggio più o meno unificato [...] ogni linguaggio deve essere, nella misura del possibile, formalizzato il che significa che le sue regole di combinazione interna devono essere sufficientemente precise da eliminare al massimo le ambiguità, un’esigenza costante di ogni attività scientifica.
Questa collana, dunque, è attenta e aperta a contributi interdisciplinari che offrano anche occasione di rivoluzioni kuhniane e innovazioni schumpeterianamente radicali all’altezza delle sfide evolutive della complessità negli scenari globali attuali, così ricchi di soglie epocali e di biforcazioni (per esempio se continuare ad avere un’economia basata sul petrolio o attivare seriamente fonti alternative di energia, se invocare teorie creazioniste sull’origine e l’identità biologica dell’uomo oppure aprirci a salti evolutivi che implichino una rilettura, con relative minacce e opportunità, delle chances di vita dell’uomo in nuove forme) che sono proprie del nostro tempo e di fronte alle quali la più tragica e rischiosa decisione sarebbe quella di non decidere.
Questa collana, dunque, è attenta e aperta a contributi interdisciplinari che offrano anche occasione di rivoluzioni kuhniane e innovazioni schumpeterianamente radicali all’altezza delle sfide evolutive della complessità negli scenari globali attuali, così ricchi di soglie epocali e di biforcazioni (per esempio se continuare ad avere un’economia basata sul petrolio o attivare seriamente fonti alternative di energia, se invocare teorie creazioniste sull’origine e l’identità biologica dell’uomo oppure aprirci a salti evolutivi che implichino una rilettura, con relative minacce e opportunità, delle chances di vita dell’uomo in nuove forme) che sono proprie del nostro tempo e di fronte alle quali la più tragica e rischiosa decisione sarebbe quella di non decidere.

SINTESI
PUBBLICAZIONI